
Gloria del disteso mezzogiorno, Casa sul mare e Dora Markus di Montale
28 Dicembre 2019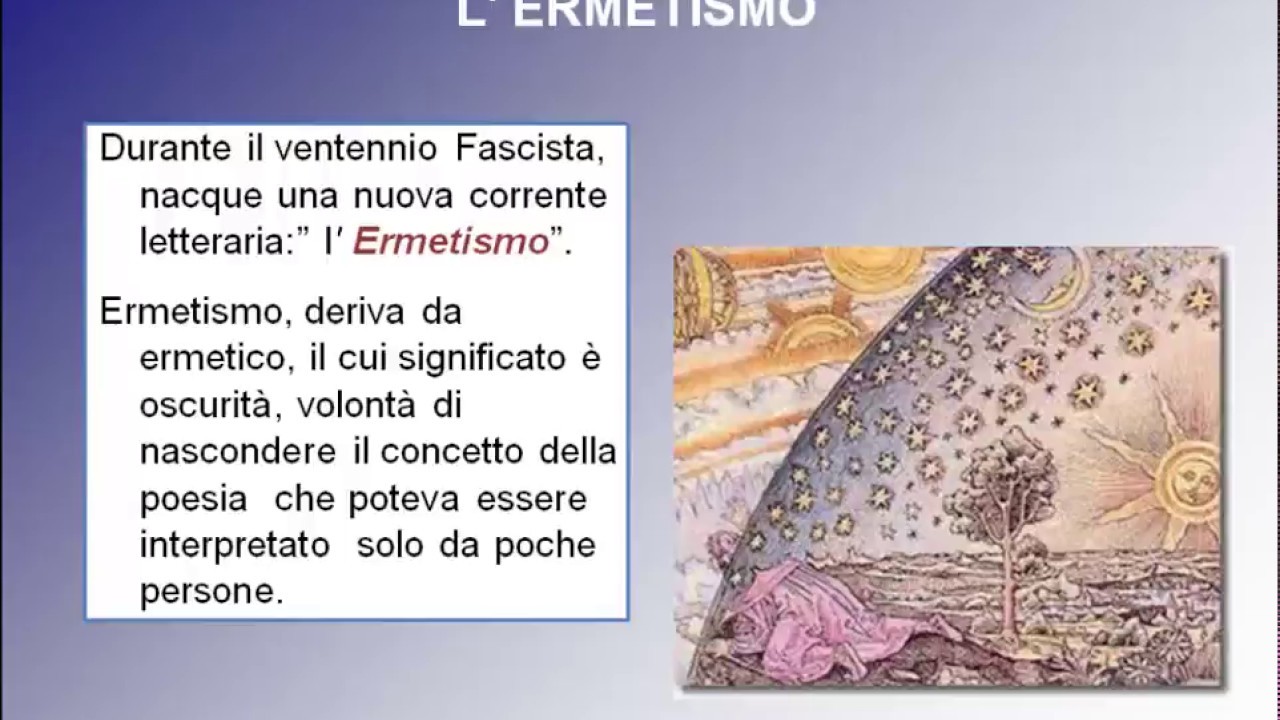
La poesia “La preghiera” in Sentimento del tempo di Giuseppe Ungaretti
28 Dicembre 2019Lo “strappo nel cielo di carta” è una delle immagini più celebri e profonde de Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello.
Qui sotto un’analisi articolata del brano con introduzione e commento.
📘 Introduzione: Mattia Pascal e la crisi dell’identità
Nel romanzo Il fu Mattia Pascal (1904), Pirandello costruisce un laboratorio narrativo dell’identità, dove il protagonista sperimenta la possibilità di sfuggire al proprio io sociale e vivere “due volte”. Mattia Pascal, creduto morto, assume la nuova identità di Adriano Meis. Ma la seconda vita, anziché liberarlo, si rivela altrettanto illusoria, costringendolo a una riflessione tragica sulla relatività della realtà e sull’impossibilità di una libertà autentica.
È in questo contesto che si colloca il celebre episodio dello “strappo nel cielo di carta”, una metafora tanto poetica quanto destabilizzante, emblematica della poetica pirandelliana.
🔍 Il passo: lo strappo nel cielo di carta
Il protagonista si trova in una sala di marionette insieme all’amico Anselmo Paleari. Guardando lo spettacolo, osserva il cielo dipinto sulla scena:
«Mi sembrava che quella carta azzurra, su cui erano disegnate qua e là nuvolette bianche, fosse proprio il cielo, e che le figurine laggiù si agitassero veramente in quel cielo; finché vidi che, in un punto, quella carta s’era lacerata, e s’affacciava da quel buco una bacchetta con un filo. […] Tutto si ruppe. Non potei più illudermi. Avevo veduto. C’era lo strappo.»
🎭 Analisi e commento: l’irruzione del reale
Lo “strappo” non è solo una lacerazione fisica, ma una rottura ontologica: il momento in cui l’illusione del mondo viene smascherata. La sala delle marionette rappresenta la vita, una rappresentazione ordinata, rassicurante nella sua finzione. Le “nuvolette bianche” sul cielo di carta evocano un mondo fittizio ma accettabile, dove ogni elemento ha il suo posto e il suo ruolo. Ma lo strappo nella scenografia mostra la verità cruda: dietro la rappresentazione c’è il nulla, o meglio, c’è la costruzione artificiale di ogni forma di senso.
Come spettatore, Mattia non riesce più a “credere” alla scena. È la stessa sensazione che prova nella vita: la sua nuova identità (Adriano Meis) è un personaggio, una maschera costruita su misura, ma non autenticamente vissuta. La sua crisi nasce proprio da questo: vedere ciò che sta dietro la forma, e non potervi più credere.
🧠 Il pensiero pirandelliano in nuce
L’episodio è una perfetta espressione della poetica dell’umorismo di Pirandello. L’umorismo non è solo comicità, ma lucida consapevolezza del contrasto tra forma e vita, tra ciò che appare e ciò che è. Lo strappo nel cielo è la caduta della maschera, la frattura tra realtà e rappresentazione.
Per Pirandello, la realtà è una costruzione artificiale, convenzionale, fittizia — come il cielo dipinto in teatro. Vivere significa recitare un ruolo all’interno di quella scenografia. Ma se si vede lo strappo, non si può più tornare indietro. Chi è consapevole della finzione diventa un estraneo: non può più aderire sinceramente al gioco sociale.
⛓ Conclusione: la condanna alla maschera
Lo “strappo nel cielo di carta” è una folgorazione: un’illuminazione tragica. Mattia Pascal scopre che la libertà non consiste nell’inventarsi un’altra identità, ma nel vedere che tutte le identità sono costruzioni precarie, maschere appese a un filo.
Come il cielo del teatrino, anche la realtà è fatta di carta: può sembrare solida, ma basta uno strappo — una crisi, un’illuminazione — per mostrare il suo carattere illusorio. Dopo quel momento, l’uomo pirandelliano non può più aderire al mondo con ingenuità, ma è condannato a vivere “fuori” dal gioco, lucidamente solo.
📖 Esercizio finale
Confronta questo passo con il finale del romanzo o con altri “strappi” simili in Pirandello, da Uno, nessuno e centomila alle novelle. ✨
📘Brano del romanzo “Lo strappo nel cielo di carta” (da Il fu Mattia Pascal, capitolo XII)
→ La scena si svolge durante la permanenza di Mattia Pascal a Roma, nella pensione della famiglia Paleari.
Un giorno Anselmo Paleari, il capofamiglia, propone a Mattia di recarsi a vedere uno spettacolo di marionette:
vi si rappresenta la tragedia greca Elettra di Sofocle. Da qui, ragionando, espone l’ipotesi di un banale imprevisto
che, bloccando l’azione del personaggio interpretato dalla marionetta, metterebbe in crisi ogni visione assoluta, ogni
interpretazione coerente della realtà.
— La tragedia d’Oreste in un teatrino di marionette! — venne ad annunziarmi il signor Anselmo Paleari. — Marionette automatiche, di nuova invenzione. Stasera, alle ore otto e mezzo, in via dei Prefetti, n. 54. Sarebbe da andarci, signor Meis.
— La tragedia d’Oreste?
— Già! D’après Sophocle, dice il manifestino. Sarà l’Elettra. Ora senta un po’ che bizzarria mi viene in mente! Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei.
— Non saprei, — risposi, stringendomi ne le spalle.
— Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo.
— E perchè?
— Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma gli occhi, sul punto, gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta.
E se ne andò, ciabattando.
(L. Pirandello, Tutti i romanzi, vol. i, Mondadori, Milano 2005)




