
L’impatto distruttivo della civiltà occidentale sui popoli e sugli ambienti
15 Giugno 2025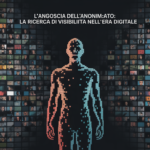
L’angoscia dell’anonimato: la ricerca di visibilità nell’era di…
15 Giugno 2025Traccia e svolgimento di un tema di attualità sull’importanza della lettura

TRACCIA
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE – PROVA DI ITALIANO – Sessione suppletiva 2024 – Prima prova scritta – Ministero dell’istruzione e del merito
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C1
Testo tratto da: Paolo Di Paolo, Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi in 27 storie, Laterza, Bari-Roma, 2017, pp. XII-XIII.
TESTO
«[…] mettersi a leggere qualcosa come un romanzo
1. non rende più intelligenti
2. può fare male
3. non allunga la vita
4. non c’entra con l’essere colti, non direttamente
e però anche che
1. aiuta a non smettere mai di farsi domande
2. alimenta l’inquietudine che ci tiene vivi
3. permette di non vivere solo il proprio tempo e la propria storia
4. offre quindi la possibilità di non essere solo sé stessi
5. rende più intenso il vissuto, e forse più misterioso il vivibile
6. [ti lascia sempre molte caselle vuote da riempire]»
Paolo Di Paolo, Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi in 27 storie, Laterza, Bari-Roma, 2017, pp. XII-XIII.
CONSEGNA
A partire dall’elenco elaborato dallo scrittore Paolo Di Paolo e traendo spunto dalle tue letture, dalle tue conoscenze e dalle tue esperienze personali, rifletti su quale significato e valore possa avere la lettura per un giovane: puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

Salone del libro di Torino
SVOLGIMENTO
Il Libro come Compagno: Coltivare l’Inquietudine per una Vita Piena
Il testo di Paolo Di Paolo, “Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi in 27 storie”, presenta un elenco apparentemente paradossale sul significato della lettura, in particolare del romanzo. Se da un lato ammette che leggere “non rende più intelligenti”, “può fare male” e “non allunga la vita”, dall’altro celebra la sua capacità di “aiutare a non smettere mai di farsi domande” e di “rendere più intenso il vissuto”. Questa visione, che va oltre i benefici immediati e quantificabili, mi trova profondamente concorde. Credo che per un giovane la lettura abbia un valore inestimabile, non tanto per i suoi effetti diretti e misurabili, quanto per la sua capacità di alimentare una profonda inquietudine interiore, di espandere orizzonti e di arricchire la percezione della vita stessa, lasciando sempre “caselle vuote da riempire” che stimolano la crescita continua.
Il Valore Oltre la Quantificazione: L’Intelligenza che non si Misura
Di Paolo inizia con affermazioni che potrebbero scoraggiare il lettore meno convinto: leggere “non rende più intelligenti”, “non allunga la vita”, “non c’entra con l’essere colti, non direttamente”. In una società ossessionata dalle metriche, dalla performance e dai risultati immediati, dove tutto deve essere quantificabile e utile in modo tangibile, queste osservazioni sono un pugno nello stomaco. E forse è proprio qui che risiede il primo, fondamentale valore della lettura per un giovane: la sua capacità di sfuggire a questa logica stringente. L’intelligenza che la lettura sviluppa non è quella misurata dai test standardizzati, ma una forma più profonda: l’intelligenza emotiva, la capacità di analisi critica, l’elasticità mentale, la sensibilità alle sfumature. Leggere non aggiunge anni alla vita, ma aggiunge vita agli anni, arricchendo la qualità dell’esperienza. Non fa automaticamente “colti” nel senso nozionistico del termine, ma apre la mente a complessità e prospettive diverse. Nella mia esperienza scolastica, ho spesso notato come l’apprendimento sia orientato al “sapere che” (come la conoscenza superficiale delle proteine che lamenta Serianni nel suo articolo sulle due culture, vedi B2 Sessione straordinaria 2023), ma è attraverso la lettura dei romanzi o dei saggi che ho compreso il “perché” delle cose, sviluppando un pensiero più autonomo, non riducibile a una mera riproduzione di dati.
L’Inquietudine Come Motore: Farsi Domande e Non Fermarsi Mai
Il vero potere della lettura, come sottolinea Di Paolo, risiede nella sua capacità di “aiutare a non smettere mai di farsi domande” e di “alimentare l’inquietudine che ci tiene vivi”. In un mondo che spesso ci offre risposte preconfezionate e una realtà semplificata (soprattutto nel flusso continuo dei social media, come evidenziato da Caminito nel suo testo sul diario digitale, vedi C2 Sessione ordinaria 2024), la lettura ci spinge a dubitare, a indagare, a cercare oltre la superficie. Ogni pagina letta può essere un “non so” (come lo definiva Szymborska nel suo elogio alla ricerca, vedi B3 Sessione straordinaria 2023), il punto di partenza per una nuova esplorazione.
I romanzi, in particolare, ci mettono di fronte a personaggi complessi, a dilemmi morali, a contesti storici e sociali che sfidano le nostre certezze. Questa “inquietudine” non è una fonte di malessere, ma una spinta vitale: è il desiderio di comprendere, di approfondire, di non accontentarsi di soluzioni semplici. È una forma di resistenza all’omologazione del pensiero e alla passività intellettuale. Un libro ben scelto mi ha spesso portato a interrogarmi su questioni etiche, sociali o esistenziali, spingendomi a cercare altre letture, a confrontarmi con diverse prospettive, e a sviluppare una mia opinione più articolata.
Vivere Mille Vite: Espandere Tempo e Identità
Un altro valore insostituibile della lettura è che “permette di non vivere solo il proprio tempo e la propria storia” e “offre quindi la possibilità di non essere solo sé stessi”. Attraverso i libri, un giovane può viaggiare nel tempo e nello spazio, esplorare culture lontane, rivivere epoche passate e immaginare futuri possibili. Si può diventare, per il tempo della lettura, un soldato in trincea (come in Ungaretti, vedi A1 Sessione ordinaria 2024), un operaio nell’Italia del miracolo economico (come in Calvino, vedi A2 Sessione suppletiva 2024), o un uomo alla ricerca di un senso in una società che lo aliena (come in Pirandello, vedi A2 Sessione ordinaria 2024).
Questo “mettersi nei panni degli altri” è un esercizio fondamentale di empatia, la capacità di “guardare il mondo con gli occhi degli altri” (come ha evidenziato Gino Strada, vedi C1 Sessione ordinaria 2024). La lettura ci rende più consapevoli della complessità dell’esistenza umana, delle diverse sfumature della sofferenza e della gioia, dei condizionamenti sociali e storici. Permette di comprendere che il mondo è fatto di “molteplici sfaccettature”, non di un rigido “noi” e “loro”. Questo allarga la nostra visione del mondo e ci rende cittadini più informati e compassionevoli.
L’Intensità del Vissuto: Mistero e Caselle Vuote
Infine, la lettura “rende più intenso il vissuto, e forse più misterioso il vivibile” e ci “lascia sempre molte caselle vuote da riempire”. Questa è la vera magia del libro. Non si limita a fornire risposte, ma stimola la nostra immaginazione, la nostra capacità di interpretazione e la nostra sensibilità. Non ci consegna una verità confezionata, ma ci invita a completarla con la nostra esperienza e la nostra riflessione. La vita, dopo aver letto un romanzo profondo, non è più la stessa: è arricchita da nuove prospettive, da nuove chiavi di lettura, da una maggiore consapevolezza delle sue sfumature e dei suoi misteri.
Ho sperimentato come un libro possa dare voce a emozioni inespresse, o aiutare a decifrare situazioni complesse della vita reale. Le “caselle vuote” sono un invito alla ricerca continua (come sottolineato da Szymborska), alla curiosità, a non smettere mai di imparare e di esplorare. È l’anti-perfetto, l’anti-completo, il rifiuto di una conoscenza superficiale e l’apertura a un’esistenza che si svela progressivamente, in tutta la sua ricchezza e, sì, la sua imperfezione (come la elogia Levi-Montalcini, vedi C1 Sessione ordinaria 2024).
Conclusioni: La Lettura, Ponte verso l’Autenticità
In conclusione, l’elenco di Paolo Di Paolo, lungi dall’essere una svalutazione, è un profondo elogio della lettura come strumento essenziale per la formazione di un giovane. In un’epoca che spinge verso la superficialità, la gratificazione immediata e l’omologazione, la lettura ci offre un’ancora di salvezza. Essa non promette guadagni immediati o quantificabili, ma coltiva un’intelligenza profonda, alimenta una salutare inquietudine, espande i confini del nostro tempo e della nostra identità, e rende il vissuto più intenso e il vivibile più misterioso. Per un giovane, leggere non è un semplice passatempo o un dovere scolastico, ma un atto di libertà, un investimento nella propria autenticità, un viaggio continuo che lascia sempre “molte caselle vuote da riempire”, invitando alla crescita e alla scoperta senza fine.





