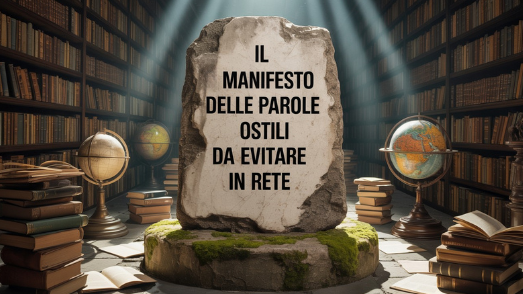I Valori che fondano l’Unione Europea di David Sassoli
11 Giugno 2025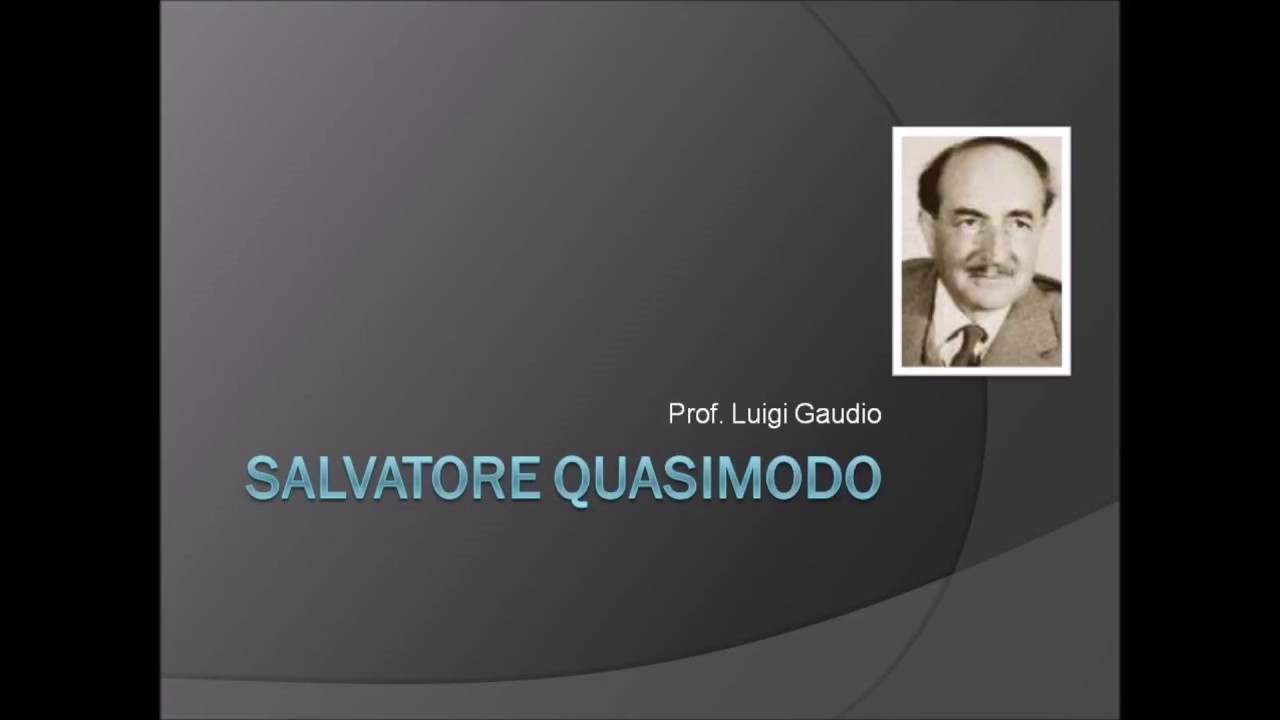
Alla nuova luna di Salvatore Quasimodo
11 Giugno 2025Traccia svolta di un tema di attualità sul Manifesto della comunicazione non ostile

TRACCIA
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – PROVA DI ITALIANO – SESSIONE STRAORDINARIA 2022 – PRIMA PROVA SCRITTA
Ministero dell’Istruzione
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C2
Il Manifesto della comunicazione non ostile (www.paroleostili.it/manifesto/)
IL DECALOGO
1. Virtuale è reale Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.
2. Si è ciò che si comunica Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.
3. Le parole danno forma al pensiero Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
4. Prima di parlare bisogna ascoltare Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
5. Le parole sono un ponte Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.
6. Le parole hanno conseguenze So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.
7. Condividere è una responsabilità Condivido testi, video e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.
8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.
9. Gli insulti non sono argomenti Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
10. Anche il silenzio comunica Quando la scelta migliore è tacere, taccio.
CONTESTO
Il Manifesto delle parole non ostili è un decalogo con i principi per migliorare il comportamento in rete, per suggerire maggiore rispetto per gli altri attraverso l’adozione di modi, parole e comportamenti, elaborato nel 2017.
CONSEGNA
Sei del parere che tale documento abbia una sua utilità?
Quali principi del decalogo, a tuo avviso, sono particolarmente necessari per evitare le storture della comunicazione attuale?
Argomenta il tuo punto di vista facendo riferimento alle tue conoscenze, al tuo percorso civico, alle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Lunghezza consigliata: 4-5 colonne di metà di foglio protocollo
- Struttura: Introduzione, sviluppo argomentativo, conclusione
- Possibili sviluppi tematici:
- L’importanza della comunicazione digitale responsabile
- Analisi dei principi più rilevanti del decalogo
- Confronto tra comunicazione virtuale e reale
- Il ruolo dell’educazione digitale
- Esperienze personali di comunicazione online
- Le conseguenze dell’hate speech e del cyberbullismo
- Proposte per migliorare il dibattito pubblico in rete

SVOLGIMENTO
Il Decalogo del Rispetto Digitale: Una Guida Vitale per la Comunicazione Online
L’avvento del mondo iperconnesso ha trasformato radicalmente il nostro modo di comunicare, aprendo orizzonti inediti di condivisione e interazione. Tuttavia, questa rivoluzione ha portato con sé anche nuove sfide e, in particolare, la diffusione di forme di comunicazione ostile, aggressiva e dannosa. In questo contesto, il “Manifesto della comunicazione non ostile” si presenta come un decalogo di principi fondamentali, un faro necessario per orientare il comportamento in rete verso un maggiore rispetto e una maggiore consapevolezza. Ritengo che tale documento abbia un’utilità inestimabile, non solo come guida teorica, ma come strumento pratico per educare e promuovere una cittadinanza digitale responsabile, indispensabile per evitare le storture e le derive della comunicazione attuale.
L’Utilità del Manifesto in un Contesto Flessibile
La prima, innegabile utilità del Manifesto risiede nella sua capacità di fornire un quadro etico chiaro in un ambiente, quello digitale, che per sua natura è fluido, dinamico e spesso privo di regole esplicite. In un mondo dove le interazioni avvengono a ritmi vertiginosi e la distanza fisica può far percepire una minore responsabilità, avere un riferimento di principi condivisi è fondamentale. Il Manifesto serve a colmare il vuoto lasciato dalla mancanza di un’educazione digitale diffusa e strutturata, offrendo a tutti – dai nativi digitali agli adulti meno esperti – strumenti per riflettere sulle proprie abitudini comunicative. Nella mia esperienza scolastica e extrascolastica, ho spesso notato come molti comportamenti inappropriati online non siano frutto di vera malizia, ma di una scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e di una superficialità indotta dalla velocità della rete. Il Manifesto interviene proprio su questa lacuna, invitando a “tenere acceso il cervello” prima di postare, commentare o condividere.
Principi Fondamentali per un Dialogo Costruttivo
Tra i dieci principi del decalogo, alcuni mi appaiono particolarmente urgenti e necessari per contrastare le storture della comunicazione attuale:
-
“Virtuale è reale” (Principio 1): Questo è il punto di partenza essenziale e, a mio avviso, il più difficile da interiorizzare per molti utenti. La falsa percezione di anonimato e impunità offerta dalla rete porta spesso a dire e fare online ciò che non si avrebbe “il coraggio di dire di persona”. Tuttavia, le conseguenze di una parola, di un insulto, di una minaccia online sono tangibili e possono avere un impatto devastante sulla vita reale delle persone. Ho visto casi di cyberbullismo o di diffamazione online che hanno rovinato la reputazione e la salute mentale di individui, dimostrando come le parole virtuali siano, di fatto, reali e con conseguenze altrettanto reali. Far comprendere che “si è ciò che si comunica” (Principio 2) è il passo successivo per promuovere una responsabilità personale in rete.
-
“Prima di parlare bisogna ascoltare” (Principio 4): In un’epoca di polarizzazione e di “echo chambers”, dove le persone tendono a confrontarsi solo con chi la pensa come loro, la capacità di ascolto è un’arte perduta. Il Manifesto ci ricorda che “Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura”. Questo principio è cruciale per rompere il circolo vizioso dell’auto-conferma e favorire un vero confronto di idee. La mia esperienza nelle discussioni di gruppo, in classe o tra amici, mi ha insegnato che solo ascoltando attentamente le ragioni altrui si può arrivare a una comprensione più profonda, a una sintesi o, almeno, a una accettazione reciproca delle differenze, trasformando il potenziale conflitto in un’opportunità di crescita.
-
“Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare” (Principio 8) e “Gli insulti non sono argomenti” (Principio 9): Questi due principi sono gemelli e costituiscono la base per un dibattito pubblico sano e costruttivo. La rete, troppo spesso, è un campo di battaglia dove il disaccordo sulle idee si trasforma in attacco personale, con l’uso di insulti, denigrazioni e aggressioni verbali. Non trasformare chi sostiene opinioni diverse in un “nemico da annientare” è fondamentale per la salute della democrazia. Gli insulti, infatti, non solo non argomentano, ma delegittimano il confronto, avvelenano il clima e rendono impossibile qualsiasi dialogo. La mia formazione civica ha sempre enfatizzato l’importanza del rispetto reciproco come fondamento della convivenza civile; questi principi lo estendono al contesto digitale, ricordandoci che la forza di un’argomentazione non risiede nella sua aggressività, ma nella sua solidità logica e nella sua capacità di persuadere.
-
“Anche il silenzio comunica” (Principio 10): Questo principio, apparentemente semplice, racchiude una grande saggezza. In un mondo che ci spinge a commentare tutto, a esprimere un’opinione su ogni cosa, la capacità di “tacere quando la scelta migliore è tacere” è un atto di maturità e autocontrollo. Significa riconoscere il momento in cui un’ulteriore interazione non farebbe altro che alimentare una polemica sterile, o quando la propria parola non aggiungerebbe valore. È la consapevolezza che non tutto merita una risposta, e che a volte il non reagire è la forma più efficace di comunicazione, contribuendo a disinnescare situazioni potenzialmente dannose.
L’Educazione alla Cittadinanza Digitale: Un Imperativo
Il Manifesto, dunque, non è solo utile, ma necessario. La sua rilevanza va ben oltre la “netiquette” (le buone maniere in rete), toccando le fondamenta stesse della cittadinanza digitale. Educare i giovani e meno giovani a questi principi significa formarli non solo come utenti esperti, ma come cittadini consapevoli, capaci di agire in rete con etica e responsabilità. Dalla scuola al contesto familiare, dalla formazione professionale alla semplice conversazione quotidiana, questi principi dovrebbero essere discussi, assimilati e praticati. La mia esperienza mi conferma che quando questi valori sono presenti e applicati, le interazioni online diventano più ricche, meno stressanti e più costruttive. Al contrario, la loro assenza porta a un deterioramento del dibattito pubblico e a un aumento delle tensioni sociali, con conseguenze negative che si riversano dalla sfera virtuale a quella reale.
In conclusione, il “Manifesto della comunicazione non ostile” è un documento di grande valore, una bussola per navigare il vasto e a volte turbolento mare del web. La sua utilità risiede nella chiarezza e nella profondità dei suoi principi, che invitano alla responsabilità, all’ascolto, al rispetto e alla consapevolezza delle conseguenze delle nostre parole. Adottare questi principi non è solo una questione di buone maniere, ma un atto di responsabilità civica, un passo fondamentale per trasformare la rete da un potenziale campo di battaglia a uno spazio di dialogo, crescita e autentica connessione umana. È una lezione che ci ricorda che, anche in un mondo iperconnesso, il cervello deve rimanere acceso.