
Un sopruso feudale Lucia e Don Rodrigo
28 Dicembre 2019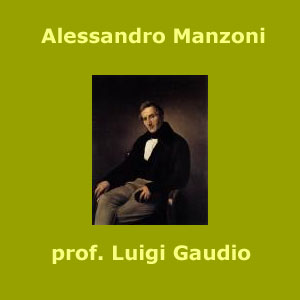
L’ironia manzoniana
28 Dicembre 2019introduzione ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni , con risorse e informazioni utili per uno studio scolastico o universitario.
Il Progetto del Romanzo “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni: Genesi, Sviluppo e Realizzazione di un Capolavoro
Introduzione: L’Ambizione di un’Opera Totale
Quando Alessandro Manzoni iniziò a concepire quello che sarebbe diventato “I Promessi Sposi”, non aveva in mente semplicemente la stesura di un romanzo, ma la realizzazione di un progetto culturale e civile di vastissima portata. L’opera doveva essere contemporaneamente romanzo di formazione e affresco storico, manifesto estetico e strumento pedagogico, capolavoro artistico e documento di impegno nazionale.
Il progetto manzoniano si inserisce nel contesto più ampio del Risorgimento culturale italiano, quando gli intellettuali della penisola cercavano forme espressive capaci di contribuire alla formazione di una coscienza nazionale unitaria. Tuttavia, l’ambizione di Manzoni andava oltre: voleva creare un’opera che potesse competere con i grandi romanzi europei del tempo, dimostrando la maturità raggiunta dalla cultura italiana.
Le Origini del Progetto: Contesto Storico e Culturale
L’Influenza del Romanticismo Europeo
Il progetto de “I Promessi Sposi” nasce dall’incontro tra la sensibilità manzoniana e le nuove correnti del romanticismo europeo. L’autore aveva seguito con interesse lo sviluppo del romanzo storico in Francia e Inghilterra, studiando in particolare Walter Scott, che considerava il maestro del genere. Dall’autore scozzese Manzoni apprese la tecnica di inserire personaggi fittizi in un contesto storico accuratamente documentato.
Tuttavia, l’ambizione manzoniana era quella di superare i modelli stranieri, creando un romanzo che non fosse solo intrattenimento, ma strumento di educazione morale e civile. Mentre Scott si limitava spesso a una ricostruzione pittoresca del passato, Manzoni voleva estrarre dalla storia insegnamenti validi per il presente.
La Questione della Lingua Letteraria
Uno degli aspetti più innovativi del progetto manzoniano riguardava la questione linguistica. L’autore si proponeva di scrivere un’opera che potesse essere compresa da un pubblico più vasto rispetto a quello tradizionale della letteratura italiana, caratterizzata dall’uso di un linguaggio aulico e artificioso.
La scelta di una lingua più vicina all’uso parlato colto non era però dettata da semplici ragioni pratiche, ma rispondeva a una precisa concezione democratica della letteratura. Manzoni voleva che il suo romanzo potesse raggiungere e influenzare i ceti borghesi emergenti, contribuendo alla formazione di una cultura nazionale condivisa.
La Genesi dell’Opera: Dal Progetto alla Prima Stesura
L’Ispirazione Iniziale
La prima idea del romanzo risale probabilmente al 1821, quando Manzoni iniziò a interessarsi alla storia lombarda del Seicento. L’episodio che fornì lo spunto iniziale fu la lettura di documenti relativi ai tumulti di Milano del 1628, durante la carestia che precedette la peste. Da questi documenti emerge la figura di un vicario di provvisione che si oppose coraggiosamente alla folla, fornendo il primo nucleo di quello che sarebbe diventato il personaggio di Ferrer.
Tuttavia, l’ispirazione più profonda del romanzo va ricercata nella volontà di rappresentare il popolo italiano in un momento di crisi, mostrando come anche gli umili possano essere protagonisti della storia. La scelta di porre al centro della narrazione due giovani popolani, Renzo e Lucia, rifletteva questa intenzione democratica.
La Ricerca Storica
Una volta definita l’ambientazione storica, Manzoni si dedicò a un’approfondita ricerca documentaria. Studiò cronache, memorie, documenti d’archivio, opere di storici contemporanei e posteriori agli eventi narrati. La sua biblioteca personale si arricchì di centinaia di volumi dedicati al Seicento lombardo.
Questa ricerca non aveva finalità puramente erudite, ma rispondeva all’esigenza di ricostruire con precisione l’ambiente storico in cui collocare la vicenda dei protagonisti. Manzoni voleva che ogni dettaglio dell’ambientazione fosse storicamente attendibile, per conferire maggiore credibilità alla narrazione.
La Prima Stesura (1821-1823)
La stesura del romanzo iniziò nel 1821 e si protrasse per circa due anni. Fin dall’inizio, Manzoni ebbe chiara la struttura generale dell’opera: una vicenda d’amore ostacolata dalla prepotenza dei potenti, inserita nel contesto della dominazione spagnola e della peste del 1630.
La prima versione, nota come “Fermo e Lucia”, presentava già tutti gli elementi fondamentali della trama definitiva, ma con differenze significative nell’impostazione narrativa e nella caratterizzazione dei personaggi. Il tono era più drammatico e patetico, l’analisi psicologica meno approfondita, il quadro storico meno organicamente integrato nella narrazione.
L’Evoluzione del Progetto: Dalle Prime Revisioni alla Ventisettana
Le Prime Correzioni (1823-1825)
Terminata la prima stesura, Manzoni iniziò immediatamente un processo di revisione che si sarebbe protratto per tutta la vita. Le prime correzioni riguardarono principalmente la struttura narrativa e l’equilibrio tra le diverse parti dell’opera. L’autore si rese conto che alcuni episodi risultavano troppo lunghi, altri troppo abbreviati, e che era necessario rielaborare l’intera architettura del romanzo.
Un aspetto cruciale di questa fase fu il ripensamento del rapporto tra storia e invenzione. Manzoni si pose il problema di come integrare organicamente i personaggi storici con quelli di fantasia, evitando che la narrazione apparisse artificiosa o forzata.
La Questione del Titolo e dei Personaggi
Durante le revisioni, Manzoni modificò il titolo dell’opera da “Fermo e Lucia” a “Gli sposi promessi”, poi definitivamente “I Promessi Sposi”. Questi cambiamenti riflettevano una diversa concezione del romanzo: non più la storia di due individui particolari, ma la rappresentazione di una condizione umana universale.
Anche i nomi dei protagonisti subirono modifiche significative: Fermo divenne Renzo, Lucia mantenne il suo nome ma acquisì una caratterizzazione più complessa. Questi cambiamenti non erano casuali, ma rispondevano all’esigenza di rendere i personaggi più tipici e rappresentativi.
La Prima Edizione (1827)
La prima edizione de “I Promessi Sposi” uscì a Milano nel 1827 presso l’editore Ferrario. L’opera, in tre volumi, riscosse immediatamente un grande successo di pubblico e di critica, affermandosi come il primo grande romanzo della letteratura italiana.
Tuttavia, Manzoni non era completamente soddisfatto del risultato raggiunto. Già durante la stampa dell’opera, aveva iniziato a progettare ulteriori revisioni, concentrate principalmente sulla questione linguistica. L’autore si era reso conto che la lingua utilizzata nella prima edizione non rispondeva completamente ai suoi ideali di chiarezza e accessibilità.
La Revisione Linguistica: Verso la Quarantana
Il Soggiorno Fiorentino (1827)
Subito dopo la pubblicazione della prima edizione, Manzoni si recò a Firenze per studiare dal vivo la lingua parlata colta toscana. Questa esperienza fu determinante per la concezione linguistica dell’opera definitiva. L’autore si convinse che solo adottando il fiorentino contemporaneo come base linguistica si poteva ottenere quella naturalezza espressiva che considerava indispensabile.
Il soggiorno fiorentino non fu solo un’esperienza linguistica, ma anche culturale e sociale. Manzoni entrò in contatto con l’ambiente intellettuale toscano, confrontando le proprie idee con quelle di scrittori e studiosi locali. Questo confronto contribuì a rafforzare le sue convinzioni sulla necessità di una lingua letteraria più vicina all’uso vivo.
La Seconda Revisione (1827-1840)
La revisione linguistica dell’opera si protrasse per oltre un decennio, durante il quale Manzoni riscrisse praticamente tutto il romanzo. Non si trattava di semplici correzioni lessicali, ma di una rielaborazione profonda che investiva la sintassi, il ritmo della prosa, l’intera struttura espressiva.
Durante questa fase, l’autore approfondì anche l’analisi psicologica dei personaggi e perfezionò la tecnica narrativa. Il narratore onnisciente della prima edizione acquisì quella particolare ironia e quella capacità di commento che caratterizzano la versione definitiva.
La Quarantana: L’Opera Definitiva (1840-1842)
L’edizione definitiva de “I Promessi Sposi” uscì a dispense tra il 1840 e il 1842, corredata dalle illustrazioni di Francesco Gonin. Questa versione rappresenta la realizzazione compiuta del progetto manzoniano: un’opera che unisce perfetta leggibilità, profondità psicologica, accuratezza storica e alta qualità artistica.
La quarantana non è semplicemente una versione linguisticamente corretta della ventisettana, ma un’opera sostanzialmente nuova, nella quale ogni elemento è stato ripensato in funzione dell’insieme. Il risultato è un romanzo di straordinaria compattezza e coerenza, nel quale forma e contenuto raggiungono un perfetto equilibrio.
Gli Obiettivi del Progetto Manzoniano
L’Educazione Morale del Popolo
Uno degli obiettivi primari del progetto manzoniano era l’educazione morale del popolo italiano. Attraverso le vicende di Renzo e Lucia, l’autore voleva trasmettere valori di onestà, laboriosità, fede religiosa e solidarietà sociale. Il romanzo doveva fungere da specchio nel quale i lettori potessero riconoscere i propri pregi e difetti, traendone insegnamenti per la propria condotta.
Questa finalità educativa non si traduceva però in un moralismo superficiale, ma in una rappresentazione complessa della natura umana, nella quale il bene e il male si intrecciano in modo realistico. Anche i personaggi positivi hanno le loro debolezze, mentre quelli negativi conservano tratti di umanità che li rendono comprensibili.
La Formazione della Coscienza Nazionale
Il progetto manzoniano aveva anche una chiara valenza politica e civile: contribuire alla formazione di una coscienza nazionale italiana. Attraverso la rappresentazione delle sofferenze del popolo lombardo sotto la dominazione spagnola, l’autore voleva suscitare nei lettori la consapevolezza dell’importanza dell’indipendenza e dell’unità nazionale.
Tuttavia, il messaggio politico del romanzo non si esauriva nella condanna della dominazione straniera, ma investiva più profondamente la critica a tutte le forme di oppressione e ingiustizia sociale. La vera patria, per Manzoni, era quella nella quale tutti i cittadini potevano vivere con dignità e sicurezza.
La Dimostrazione della Maturità Culturale Italiana
Un altro obiettivo del progetto era dimostrare che la cultura italiana aveva raggiunto una maturità tale da produrre opere paragonabili ai capolavori della letteratura europea. “I Promessi Sposi” doveva essere la risposta italiana ai romanzi di Walter Scott, Victor Hugo, Goethe.
Questa ambizione si realizzò pienamente: il romanzo manzoniano non solo raggiunse il livello dei modelli stranieri, ma li superò per profondità psicologica, complessità strutturale e ricchezza di significati. L’opera divenne immediatamente un punto di riferimento per tutta la letteratura europea.
Le Innovazioni Tecniche del Progetto
La Tecnica del Narratore Onnisciente
Una delle innovazioni più significative del romanzo manzoniano riguarda la tecnica narrativa. Manzoni sviluppò una forma particolare di narrazione onnisciente, nella quale il narratore non si limita a raccontare i fatti, ma li commenta con ironia bonaria, guidando il lettore nell’interpretazione degli eventi.
Questo narratore manzoniano è una delle creazioni più originali della letteratura italiana: colto ma non pedante, partecipe ma non sentimentale, ironico ma non cinico. La sua voce conferisce all’intera narrazione un tono particolare, che unisce serietà morale e leggerezza stilistica.
L’Integrazione di Storia e Invenzione
Il problema dell’integrazione tra elementi storici e elementi di fantasia fu uno dei più complessi che Manzoni dovette affrontare. La soluzione adottata fu quella di utilizzare la storia come sfondo credibile per le vicende dei personaggi inventati, evitando però di far interagire direttamente questi ultimi con i grandi protagonisti storici.
Questa tecnica permise all’autore di mantenere la libertà narrativa necessaria per lo sviluppo della trama, senza compromettere l’attendibilità storica dell’ambientazione. Il risultato è un perfetto equilibrio tra verità storica e verosimiglianza poetica.
La Caratterizzazione Psicologica
Manzoni fu uno dei primi romanzieri italiani a sviluppare una tecnica raffinate di caratterizzazione psicologica. I suoi personaggi non sono tipi fissi, ma individualità complesse che evolvono nel corso della narrazione. Anche i caratteri apparentemente più semplici, come quello di Lucia, rivelano sfumature e profondità inaspettate.
Questa attenzione alla psicologia dei personaggi rifletteva la concezione manzoniana dell’arte come strumento di conoscenza della natura umana. Il romanzo doveva essere una forma di antropologia narrativa, capace di illuminare gli aspetti più nascosti dell’animo umano.
L’Influenza del Progetto sulla Letteratura Italiana
Il Modello per il Romanzo Ottocentesco
“I Promessi Sposi” divenne immediatamente il modello di riferimento per tutti i romanzieri italiani dell’Ottocento. Scrittori come D’Azeglio, Guerrazzi, Cantù si ispirarono direttamente all’opera manzoniana, cercando di riprodurne il successo con romanzi storici ambientati in diverse epoche e regioni d’Italia.
Tuttavia, nessuno di questi epigoni riuscì a eguagliare la complessità e la profondità del capolavoro manzoniano. Questo insuccesso contribuì alla crisi del romanzo storico nella seconda metà dell’Ottocento, quando scrittori come Verga cercarono nuove strade narrative.
L’Influenza sulla Lingua Letteraria
L’aspetto più duraturo dell’influenza manzoniana sulla letteratura italiana riguarda la questione linguistica. La scelta di utilizzare il fiorentino parlato colto come base della lingua letteraria influenzò profondamente lo sviluppo dell’italiano moderno.
Anche se le teorie linguistiche di Manzoni furono successivamente superate, il principio della naturalezza espressiva da lui affermato rimase un punto fermo della letteratura italiana. L’ideale di una prosa chiara, elegante e accessibile, realizzato compiutamente ne “I Promessi Sposi”, continua a influenzare gli scrittori italiani.
Il Dibattito Critico
Il romanzo manzoniano suscitò fin dalla sua apparizione un intenso dibattito critico che si protrasse per tutto l’Ottocento e oltre. Critici come De Sanctis, Settembrini, Carducci si confrontarono con l’opera, esprimendo giudizi spesso contrastanti ma sempre motivati dalla consapevolezza della sua importanza.
Questo dibattito contribuì allo sviluppo della critica letteraria italiana, costringendo gli studiosi a elaborare nuovi strumenti interpretativi per affrontare la complessità dell’opera manzoniana.
L’Attualità del Progetto Manzoniano
La Questione dell’Impegno Letterario
Il progetto manzoniano di coniugare qualità artistica e impegno civile mantiene una straordinaria attualità nel dibattito letterario contemporaneo. La questione del rapporto tra arte e società, tra autonomia estetica e responsabilità morale, continua a interrogare scrittori e critici.
L’esempio di Manzoni dimostra che è possibile creare opere di alto valore artistico senza rinunciare all’impegno sociale e morale. Questa lezione è particolarmente preziosa in un’epoca nella quale si tende spesso a separare rigidamente l’arte dalla vita.
Il Problema della Comunicazione Culturale
L’obiettivo manzoniano di raggiungere un pubblico vasto senza compromettere la qualità dell’opera è più che mai attuale nell’era della comunicazione di massa. Come conciliare l’esigenza di accessibilità con quella di profondità culturale? La risposta manzoniana – una forma espressiva elegante ma non artificiosa, complessa ma non oscura – offre ancora oggi indicazioni preziose.
La Dimensione Europea della Cultura Italiana
Il progetto di creare un’opera italiana capace di competere con i capolavori europei rifletteva una consapevolezza dell’importanza della dimensione internazionale della cultura. Anche oggi, la cultura italiana deve confrontarsi con questa sfida, cercando di mantenere la propria specificità senza rinunciare al dialogo con le altre tradizioni culturali.
Conclusione: Un Progetto Compiuto e Aperto
Il progetto del romanzo “I Promessi Sposi” rappresenta uno dei casi più riusciti di realizzazione compiuta di un’ambizione artistica e culturale. Manzoni riuscì a creare un’opera che soddisfaceva contemporaneamente le esigenze dell’arte, della morale, della politica e della pedagogia, senza che nessuna di queste dimensioni prevalesse sulle altre.
Il segreto di questo successo sta probabilmente nella capacità dell’autore di mantenere sempre al centro del proprio progetto la dimensione umana. Tutti gli obiettivi perseguiti – dall’educazione morale alla formazione nazionale, dalla sperimentazione linguistica all’innovazione tecnica – erano finalizzati a una più profonda comprensione della natura umana e a una più efficace comunicazione di valori universali.
In questo senso, il progetto manzoniano, pur essendo perfettamente compiuto, rimane aperto alle interpretazioni e agli sviluppi futuri. Ogni epoca può trovare ne “I Promessi Sposi” nuovi significati e nuovi insegnamenti, confermando la validità di un progetto che mirava esplicitamente a creare un’opera per tutti i tempi.
L’eredità più preziosa del progetto manzoniano non sta tanto nelle soluzioni specifiche adottate dall’autore, quanto nel metodo di lavoro e nell’atteggiamento mentale che lo guidarono: il rifiuto della facilità, la ricerca della perfezione, l’ambizione di servire contemporaneamente l’arte e la società, la convinzione che la letteratura possa contribuire al progresso morale e civile dell’umanità. Questi principi conservano tutta la loro validità e continuano a ispirare chiunque concepisca la scrittura non come semplice mestiere, ma come missione culturale e sociale.




