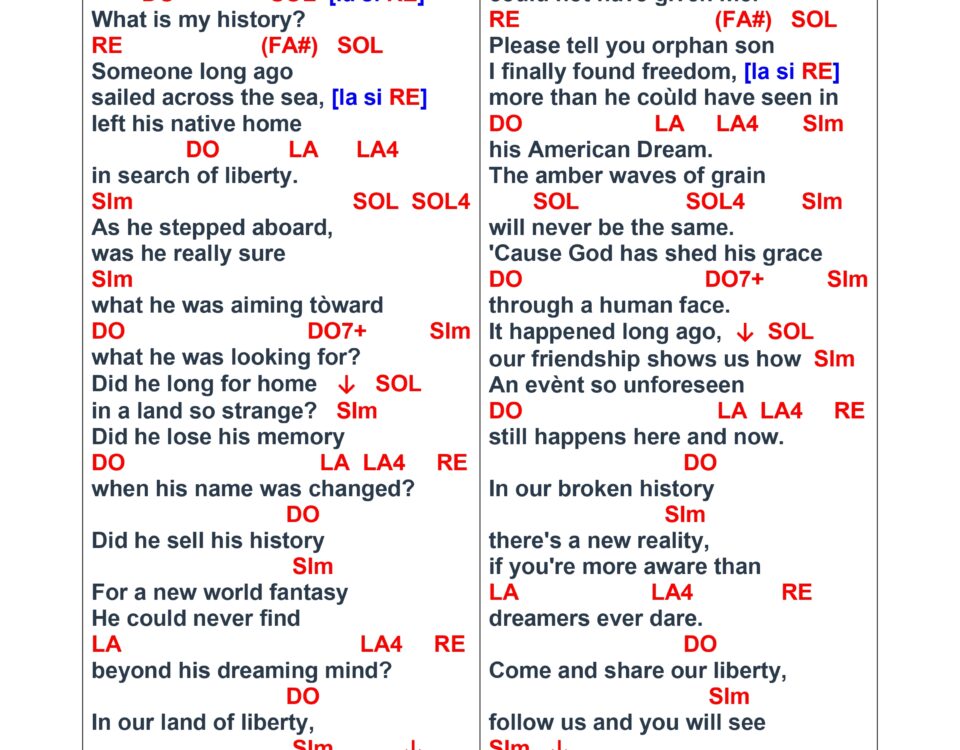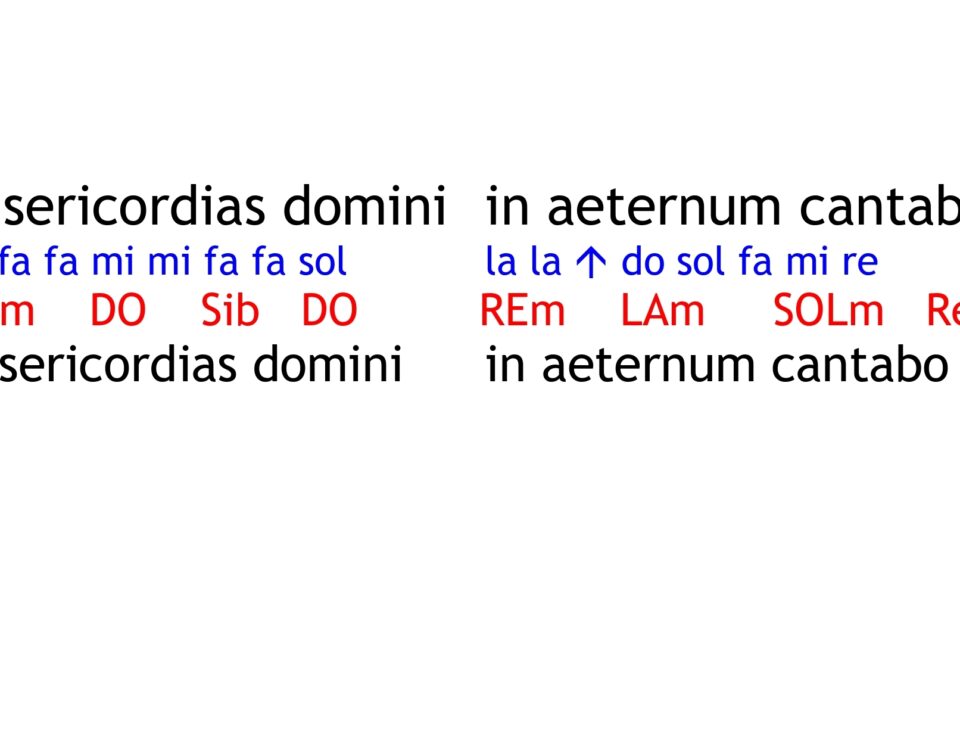Aggettivi e Pronomi Indefiniti in italiano
28 Dicembre 2019
Il mito di Icaro, Ditirambo IV, da Alcyone di Gabriele D’Annunzio
28 Dicembre 2019📚 Analisi e testo del racconto “Il rifugio” di Guy de Maupassant.
“Il rifugio” di Guy de Maupassant è un testo che esplora temi tipici dell’autore francese: l’isolamento, la follia, il terrore psicologico e la natura ostile.
Il racconto narra la storia di due uomini, il giovane Ulrich Kunsi e il vecchio Gaspard Hari, che restano come custodi di un rifugio alpino durante l’inverno. La famiglia Hauser, proprietaria del rifugio, parte per la valle prima che la neve renda impraticabile il passaggio. Ulrich è segretamente innamorato della giovane Louise Hauser.
Quando il vecchio Gaspard non torna da una battuta di caccia, Ulrich lo cerca invano per giorni. Una notte, terrorizzato dalla solitudine estrema, crede di sentire la voce del vecchio che lo chiama. Convinto che sia il fantasma di Gaspard morto nella neve, Ulrich sprofonda gradualmente nella follia, dapprima rifugiandosi nell’alcol e poi barricandosi in casa contro la presunta presenza esterna.
Alla fine dell’inverno, quando la famiglia Hauser ritorna, trova Sam (il cane) morto sulla soglia e Ulrich completamente impazzito, con i capelli bianchi. Il destino di Gaspard rimane un mistero, e la giovane Louise si ammala gravemente durante l’estate.
Conclusione 🌟
Il racconto è magistrale nel descrivere la progressiva discesa nella follia causata dall’isolamento estremo e dalla paura. Maupassant costruisce una tensione crescente attraverso l’ambiente ostile della montagna invernale, il silenzio opprimente, e la graduale dissoluzione psicologica del protagonista.😊
📘Testo del racconto “Il rifugio“ di Guy de Maupassant
Come tutti i rifugi di legno situati nelle Alpi, ai piedi dei ghiacciai, in quei canaloni rocciosi e nudi che tagliano le cime bianche delle montagne, il rifugio di Schwarenbach serve da asilo ai viaggiatori che seguono il passaggio della Gemmi.
Per sei mesi il rifugio è aperto ed è abitato dalla famiglia di Jean Hauser, poi quando le nevi si ammucchiano riempiendo il vallone e rendono impraticabile la discesa su Loeche, le donne, il padre ed i tre figli se ne vanno e lasciano a guardia alla casa la vecchia guida Gaspard Hari con il giovane Ulrich Kunsi, e Sam, il grosso cane di montagna.
I due uomini e la bestia restano fino a primavera in quella prigione di neve, e hanno davanti agli occhi solo il declivio immenso e bianco del Balmhorn, circondato da cime pallide e lucenti, imprigionati, bloccati, seppelliti sotto la neve che sale attorno a loro, avviluppa, stringe, opprime la piccola casa, si ammonticchia sul tetto, arrivando alle finestre e bloccando la porta.
Era il giorno in cui la famiglia Hauser doveva tornare a Loechg: l’inverno si avvicinava e la discesa diventava pericolosa.
Partirono prima tre muletti, carichi di bagagli, condotti dai figli. Poi la madre, Jeanne Hauser e sua figlia Louise, salirono su un quarto muletto e si avviarono. Il padre le seguiva accompagnato dalle due guide che dovevano scortare la famiglia fino al principio della discesa.
Dapprima costeggiarono il piccolo lago, ora del tutto gelato, in fondo all’imbuto di rocce che si apre davanti al rifugio, poi presero il vallone, chiaro come un lenzuolo e sovrastato da ogni parte da picchi nevosi.
Un profluvio di sole illuminava questo deserto bianco, splendente e ghiacciato, lo illuminava con una fiamma accecante e fredda; non c’era segno di vita in quell’oceano di monti, nessun movimento in quella solitudine immensa, nessun rumore turbava il profondo silenzio.
A poco a poco la giovane guida Ulrich Kunsi, uno svizzero alto, dalle lunghe gambe, lasciò indietro babbo Hauser e il vecchio Gaspard Hari per raggiungere il muletto che trasportava le due donne.
La più giovane lo guardava avvicinarsi e sembrava chiamarlo con occhi tristi.
Era una piccola ragazza di montagna, bionda, dalle guance bianche come il latte ed i capelli chiari, quasi scoloriti dai lunghi soggiorni sui ghiacciai.
Quando egli ebbe raggiunto il mulo che portava la ragazza, posò la mano sulla groppa della bestia e rallentò il passo. Mamma Hauser si mise a parlargli, enumerando con infiniti dettagli tutte le raccomandazioni per l’inverno. Era la prima volta che egli rimaneva lassù, mentre il vecchio Hari aveva già passato quattordici inverni sotto la neve nel rifugio di Schwarenbach.
Ulrich Kunsi ascoltava senza dar segno di comprendere e continuava a fissare la ragazza. Di tanto in tanto diceva «Sì, signora Hauser». Ma il suo pensiero pareva lontano e il suo viso calmo restava impassibile.
Raggiunsero il lago di Daube, la cui superficie ghiacciata si estendeva, piatta piatta, in fondo alla vallata. A destra il Daubenhorn mostrava le sue rocce nere, dritte a picco sulle enormi morene del ghiacciaio di Loemmern che domina il Wildstrubel.
Appena si avvicinarono alla conca della Gemmi, ove comincia la discesa su Loeche, scoprirono improvvisamente l’immenso orizzonte delle Alpi del Vallese, dalle quali li separava la profonda e larga valle del Rodano.
Era, in lontananza, una distesa di cime bianche, diseguali, scavate o appuntite e lucenti al sole: il Mischabel coi suoi due corni, il possente massiccio del Wissehorn, il grosso Brunnegghorn, l’alta e temibile piramide del Cervino, questo assassino di uomini, e la cima del Dent-Blanche, come una mostruosa tentatrice.
Poi, sotto, in una buca smisurata in fondo a un abisso spaventoso, scorsero Loeche, con le case simili a grani di sabbia gettati in quell’enorme crepaccio dove finisce la Gemmi, e che si apre laggiù, sul Rodano.
Il mulo si fermò sul ciglio del sentiero che, serpeggiando in tornanti, scende, fantastico e meraviglioso, lungo la montagna scoscesa fino al piccolo villaggio quasi invisibile, ai suoi piedi. Le donne saltarono nella neve.
I due vecchi le avevano raggiunte.
«Allora», disse babbo Hauser, «addio e coraggio.
All’anno venturo, amici!» Il vecchio Hari ripeté: «All’anno venturo!» Si abbracciarono. Poi la signora Hauser, a sua volta, offrì le guance e la giovane fece altrettanto.
Quando toccò a Ulrich Kunsi, egli mormorò nell’orecchio a Louise: «Non dimenticate quelli di lassù». Ella rispose «no» così a bassa voce che egli l’indovinò, senza averlo sentito.
«Allora arrivederci», ripeté Jean Hauser, «e statemi bene!» Passando davanti alle donne prese a scendere. Essi scomparvero presto alla prima svolta del sentiero.
I due uomini se ne ritornarono verso il rifugio di Schwarenbach.
Camminavano lentamente, fianco a fianco, senza parlare.
Era finito, ora restavano soli, faccia a faccia, per quattro o cinque mesi.
Poi Gaspard Hari si mise a raccontare la sua vita dell’inverno scorso.
Era rimasto con Michel Canol, troppo vecchio ora per ricominciare a stare lassù, perché può capitare un incidente durante quella lunga solitudine. D’altra parte, non si erano annoiati: tutto stava nell’organizzarsi i primi giorni, poi ci si finiva per creare delle distrazioni, dei giochi, dei passatempi.
Ulrich Kunsi l’ascoltava, con gli occhi bassi, pensando spesso a quelli che stavano scendendo verso il villaggio lungo le balze della Gemmi.
Ben presto scorsero il rifugio, appena visibile: così piccolo, un punto nero ai piedi della mostruosa montagna di neve.
Quando aprirono la porta, Sam, il grosso cane da guardia, si mise a zampettare attorno a loro.
«Su, ragazzo», disse il vecchio Gaspard, «ora non ci sono più le donne e bisogna preparare il pranzo: vai a sbucciare le patate».
E tutti e due, seduti su sgabelli di legno, cominciarono a mangiare la zuppa.
La mattina seguente sembrò lunga ad Ulrich Kunsi. Il vecchio Hari fumava e sputava nel focolare, mentre il giovane guardava dalla finestra la splendida montagna davanti al rifugio.
Nel pomeriggio uscì, e rifacendo il cammino del giorno prima, cercava sul terreno le tracce degli zoccoli del mulo che aveva portato le due donne. Poi, giunto alla conca della Gemmi, si distese sul ventre al margine dell’abisso e si mise a guardare Loeche. Il villaggio, nel suo pozzo di rocce, non era ancora sepolto dalla neve, sebbene questa lo circondasse, nettamente fermata dalle foreste di abeti che proteggevano i suoi dintorni. Le sue basse case sembravano, di lassù, pietre in un prato.
La piccola Hauser ora era là, in una di quelle case grigie.
In quale? Ulrich Kunsi si trovava troppo lontano per distinguerle l’una dall’altra. Come avrebbe voluto scendere a valle, intanto che poteva ancora!
Ma il sole era sparito dietro la grande cima del Wildstrubel e il giovane rientrò. Babbo Hari fumava. Vedendo ritornare il suo compagno gli propose una partita a carte e sedettero, l’uno di fronte all’altro, ai due lati della tavola.
Giocarono a lungo a quel gioco semplice che chiamano «briscola», poi, dopo mangiato, si coricarono.
I giorni seguenti furono simili al primo, chiari e freddi, senza nuova neve.
Il vecchio Gaspard passava i suoi pomeriggi spiando le aquile ed i rari uccelli che si avventuravano sulle cime ghiacciate, mentre Ulrich tornava regolarmente alla conca della Gemmi per guardare il villaggio. Poi giocavano a carte, a dadi, a domino; perdevano e vincevano piccoli oggetti per dare interesse al gioco.
Un mattino, Hari, alzatosi per primo, chiamò il suo compagno. Una nuvola in movimento, profonda e leggera, di bianca schiuma, calò su di loro, attorno a loro, senza rumore, seppellendoli a poco a poco sotto uno spesso e pesante materasso di spuma. L’assedio durò quattro giorni e quattro notti. Fu necessario liberare la porta e le finestre, scavare un corridoio e tagliare dei gradini per uscire fuori da quella polvere di ghiaccio, che dodici ore di gelo avevano resa più dura che il granito delle morene.
Allora vissero come prigionieri, senza più avventurarsi al di fuori del rifugio. Si erano divisi i compiti da svolgere regolarmente. Ulrich Kunsi si incaricava della pulizia, del lavare, di tutte le cure ed i lavori inerenti il rifugio. A lui toccava spaccare la legna, mentre Gaspard Hari cucinava e si occupava del fuoco. Le loro occupazioni, regolari e monotone, erano interrotte da lunghe partite a carte o a dadi. Non litigavano mai, poiché entrambi erano calmi e placidi. Non si spazientivano mai, non si facevano prendere dal malumore, né si scambiavano parole aspre, avendo fatto provvista di pazienza per quel soggiorno invernale sulle vette.
A volte il vecchio Gaspard prendeva il fucile ed andava in cerca di camosci e ogni tanto ne uccideva uno. Allora nel rifugio Schwarenbach era festa: un gran banchetto di carne fresca.
Così un mattino si mise in cammino. Il termometro fuori segnava diciotto gradi sotto zero. Il sole non si era ancora alzato e il cacciatore sperava di sorprendere gli animali vicino al Wildstrubel.
Ulrich, rimasto solo, restò a letto fino alle dieci. Era per natura un dormiglione ma non avrebbe osato abbandonarsi così alla sua inclinazione in presenza della vecchia guida, sempre alacre e mattiniera.
Fece colazione lentamente con Sam, che passava anche lui i giorni e le notti a dormire davanti al fuoco; poi, sentendosi triste ed oppresso dalla solitudine, fu preso dal bisogno della partita a carte quotidiana, come si è presi dal desiderio di una abitudine invincibile.
Uscì allora per andare incontro al suo compagno, che doveva rientrare alle quattro. La neve aveva livellato la profonda valle, colmando i crepacci, cancellando i due laghi, incappucciando le rocce, creando, fra le due cime, un’immensa conca bianca, regolare, accecante, ghiacciata.
Da tre settimane Ulrich non era tornato all’orlo dell’abisso da dove guardava il villaggio. Ci volle tornare prima di arrampicarsi sui declivi che portavano al Wildstrubel.
Loeche ora era coperta di neve e le case non si riconoscevano più, sepolte sotto quel candido manto.
Poi, girando a destra, raggiunse il ghiacciaio di Loemmern.
Camminava col suo passo lungo da montanaro, picchiando col bastone ferrato la neve dura come pietra.
Cercava, con lo sguardo penetrante, il piccolo punto nero in movimento, lontano, su quella coltre sconfinata. Quando fu sull’orlo del ghiacciaio si fermò, chiedendosi se il vecchio aveva preso davvero quella strada, poi si mise a costeggiare le morene con passo più rapido e inquieto.
Il giorno calava, le nevi si coloravano di rosa, un vento secco e gelato percorreva a brusche folate la loro superficie di cristallo. Ulrich lanciò un grido di richiamo, acuto, vibrante, prolungato. La voce si perse, nel silenzio di morte in cui dormivano le montagne; corse lontano, sulle onde immobili e profonde di schiuma glaciale, come un grido d’uccello sulle onde del mare; poi si spense senza avere risposta. Si mise ancora in cammino. Il sole si era inabissato, laggiù, dietro le cime che i riflessi del cielo arrossavano ancora; ma le profondità della valle erano già grigie.
E il giovane ebbe all’improvviso paura. Gli parve che il silenzio, il freddo, la solitudine, la morte invernale di quelle montagne fossero in lui, stessero per fermare e gelare il suo sangue, irrigidire le sue membra, riducendolo a un essere immobile e ghiacciato. Si mise a correre, fuggendo verso la casa. Il vecchio, pensava, forse era tornato durante la sua assenza. Forse aveva preso un’altra via e ora se ne stava davanti al fuoco con un camoscio ai piedi.
Presto scorse il rifugio. Non si vedeva traccia di fumo.
Ulrich corse più in fretta e aprì la porta. Sam si gettò a fargli le feste ma Gaspard Hari non era ancora tornato.
Smarrito, Kunsi girava su se stesso, come se si aspettasse di scoprire il suo compagno nascosto in un angolo. Poi accese il fuoco e preparò la zuppa, sempre sperando di veder tornare il vecchio. Ogni tanto usciva per vedere se non stesse tornando.
Era caduta la notte, la notte pallida delle montagne, la livida notte che la luna crescente, gialla e sottile, prossima a cadere dietro le vette, illuminava al limitare dell’orizzonte.
Poi il giovane rientrò, sedette, scaldandosi mani e piedi e immaginando i possibili incidenti.
Gaspard poteva essersi rotto una gamba, o essere caduto in una buca, o avere fatto un passo falso che gli avesse distorto un piede. E restava là, steso nella neve, prigioniero, irrigidito dal freddo, con l’animo angosciato, sperso, forse invocando aiuto, forse chiamando con tutte le sue forze nel silenzio della notte.
Ma dove? La montagna era tanto vasta, così aspra, così pericolosa in quei pressi, soprattutto in quella stagione, che ci sarebbero volute dieci o venti guide che camminassero per otto giorni in tutte le direzioni per trovare un uomo in quella immensità.
Ulrich Kunsi, tuttavia, decise di partire con Sam se Gaspard Hari non fosse rientrato tra mezzanotte e l’una.
Fece i preparativi. Mise nel sacco viveri per due giorni, prese i ramponi d’acciaio, s’arrotolò attorno alla vita una lunga corda, forte e sottile, verificò la tenuta del suo bastone ferrato e dell’accetta che serve a tagliare i gradini nel ghiaccio. Poi attese. Il fuoco bruciava nel camino; il grosso cane russava alla luce della fiamma, l’orologio batteva come un cuore i suoi colpi regolari nella sonora custodia di legno.
Egli attendeva, con l’orecchio teso ai rumori lontani, rabbrividendo quando il vento leggero sfiorava il tetto e i muri.
Suonò mezzanotte; trasalì. Poi, sentendosi inquieto e impaurito, mise dell’acqua sul fuoco per bersi un caffè caldo prima di mettersi in cammino.
Quando l’orologio suonò la una egli si alzò, svegliò Sam, aprì la porta e si diresse verso il Wildstrubel.
Per cinque ore si arrampicò, scalando le rocce con l’aiuto dei ramponi, tagliando il ghiaccio, avanzando sempre e spesso tirando su, mediante la corda, il cane che era restato ai piedi di una scarpata troppo ripida. Erano circa le sei quando raggiunse una cima dove il vecchio Gaspard veniva spesso a cercare i camosci. Attese che si levasse il giorno.
Il cielo impallidiva sopra la sua testa e ad un tratto una strana luminosità, sorta chissà dove, rischiarò bruscamente l’immenso oceano di cime pallide che si stendevano per centinaia di leghe attorno a lui.
Si sarebbe detto che quel chiarore incerto venisse dalla neve stessa per espandersi nello spazio. A poco a poco le vette più alte e più lontane presero un color rosa tenero come la carne ed il sole rosso apparve dietro i massicci giganti delle Alpi bernesi.
Ulrich Kunsi riprese il cammino. Andava come un cacciatore, curvo, spiando le tracce, dicendo al cane: «Cerca, Sam, cerca».
Ora ridiscendeva la montagna, frugando con gli occhi ogni conca, e a volte chiamando, gettando un grido prolungato, che presto moriva nella muta immensità.
Allora accostava l’orecchio a terra per ascoltare; credeva di distinguere una voce, si metteva a correre, chiamava di nuovo; poi, non sentendo più nulla, si gettava a terra sfinito, disperato. Verso mezzogiorno mangiò e fece mangiare anche il cane, che era stanco come lui. Poi ricominciò le ricerche.
Quando venne sera era ancora in marcia, dopo aver percorso una cinquantina di chilometri di montagna.
Poiché si trovava troppo lontano dal rifugio per ritornare ed era troppo stanco per trascinarsi ancora a lungo, scavò una buca nella neve e vi si rannicchiò col cane, sotto una coperta che aveva portato. Si accucciarono l’uno contro l’altro, l’uomo e l’animale, riscaldando a vicenda i loro corpi gelati fino alle midolla.
Ulrich non dormì affatto, la mente turbata da visioni e le membra percorse da brividi.
Stava per spuntare il giorno quando si rialzò. Aveva le gambe rigide come sbarre di ferro e si sentiva tanto scoraggiato da gemere d’angoscia; il cuore gli palpitava tanto che bastava un qualunque rumore per farlo stramazzare per l’emozione. Pensò che stava anche lui per morire di freddo in quella solitudine e la paura di quella morte, risvegliando le sue energie, gli ridonò vigore.
Scendeva ora verso il rifugio, cadendo, rialzandosi, seguito a distanza da Sam, che zoppicava su tre zampe.
Arrivarono allo Schwarenbach solo verso le quattro del pomeriggio. La casa era vuota. Il giovane accese il fuoco, mangiò e si addormentò, così abbruttito da non riuscire a pensare a nulla.
Dormì a lungo, molto a lungo, di un sonno invincibile, ma improvvisamente una voce, un grido, un nome: «Ulrich!» scossero il suo profondo stordimento e lo fecero balzare su. Aveva sognato? Era uno di quei richiami strani che attraversano lo spirito nei sogni inquieti? No, egli lo sentiva ancora, quel grido vibrante, penetratogli nelle orecchie e restato nella sua carne fino alle estremità delle sue dita nervose. Certo qualcuno aveva gridato, aveva chiamato:
«Ulrich». Ci doveva essere qualcuno lì vicino al rifugio. Non c’erano dubbi.
Spalancò la porta e urlò: «Sei tu, Gaspard!» con tutta la voce che aveva.
Nessuna risposta, nessun suono, nessun mormorio, neanche un gemito: nulla.
Era notte. Solo la neve pallida.
Si era alzato il vento, quel vento ghiacciato che spezza le pietre e non lascia tracce di vita su quelle alture abbandonate.
Il vento passava a brusche folate, secche, e più mortali di quelle del vento di fuoco dei deserti. Ulrich di nuovo gridò: «Gaspard! Gaspard!» Poi attese.
Tutto, sulla montagna, era muto. Allora uno spavento lo scosse fino nel profondo. D’un balzo rientrò in casa, chiuse la porta e serrò il chiavistello;
poi cadde tremando su una sedia, certo di essere stato chiamato dal suo compagno nel momento in cui stava morendo.
Di questo era certo, come si è sicuri di vivere o di mangiare il pane. Il vecchio Gaspard Hari era restato in agonia per due giorni e tre notti in qualche posto, dentro un buco, in uno di quei profondi burroni immacolati la cui bianchezza è più sinistra delle tenebre dei sotterranei. Aveva agonizzato per due giorni e tre notti ed era morto pensando al suo compagno. La sua anima, appena liberata, era volata verso il rifugio dove Ulrich dormiva e l’aveva chiamato con quel potere terribile e misterioso che hanno le anime dei morti di comunicare con i vivi. Aveva gridato, quell’anima senza voce, dentro l’anima oppressa del dormiente, aveva gridato il suo ultimo addio, o il suo rimprovero, o la sua maledizione verso l’uomo che non aveva cercato abbastanza.
E Ulrich la sentiva là vicino, dietro il muro, dietro la porta che aveva appena chiuso. L’anima girovagava come un uccello di notte che sfiora con le ali una finestra illuminata; e il giovane terrorizzato era sul punto di gridare per l’orrore. Avrebbe voluto fuggire ma non osava uscire; non osava e non avrebbe più osato ormai perché il fantasma sarebbe rimasto là, notte e giorno, attorno al rifugio, fino a che il corpo della vecchia guida non fosse stato ritrovato e sepolto nella terra benedetta di un cimitero.
Venne l’alba e Kunsi riprese un po’ di sicurezza vedendo tornare la luce del sole. Preparò il suo pasto, fece la zuppa al cane, poi restò su una sedia immobile, col cuore torturato dal pensiero del vecchio disteso sulla neve.
Quando la notte ricoprì la montagna, fu assalito da nuovi timori. Ora camminava nella cucina nera, appena rischiarata dalla fiamma di una candela, camminava da un lato all’altro della casa, a grandi passi, ascoltando se il grido straziante della notte passata non tornasse a echeggiare nel cupo silenzio. Si sentiva solo, il poveretto, solo come nessuno era mai stato! Era solo in quell’immenso deserto di neve, solo, duemila metri più in alto della terra abitata, al di sopra delle case degli uomini, al di sopra della vita che si agita, rumoreggia e palpita, solo, sotto il cielo gelato! Gli veniva un folle desiderio di salvarsi, non importa in quale modo, di scendere a Loeche gettandosi nell’abisso; ma non osava nemmeno aprire la porta, sicuro che l’altro, il morto, gli avrebbe sbarrato la strada per non restare solo lassù.
Verso mezzanotte, stanco di camminare, oppresso dall’angoscia e dalla paura, infine si assopì su una sedia, poiché temeva il letto come un luogo stregato.
E all’improvviso il grido stridente della sera precedente gli squarciò le orecchie, così acuto che Ulrich stese il braccio per respingere il fantasma e cadde a terra con la sedia.
Sam, svegliato dal rumore, si mise a ululare come ululano i cani spaventati, e girava per le stanze cercando da dove venisse il pericolo. Giunto presso la porta, ne annusò la soglia, soffiando e fiutando con forza, col pelo ritto, la coda rigida, e mugolando.
Kunsi, smarrito, s’era alzato e, presa per una gamba la sedia, gridò: «Non entrare, non entrare o ti ammazzo!» E il cane, eccitato da quella minaccia, abbaiava con furore contro il nemico invisibile che la voce del suo padrone stava sfidando. A poco a poco Sam si calmò e tornò a stendersi vicino al fuoco, ma restava inquieto, la testa alzata, gli occhi brillanti, ringhiando.
Ulrich a sua volta tornò in sé, ma poiché si sentiva mancare per il terrore, andò a cercare una bottiglia di acquavite nella credenza e ne bevve, sorsi su sorsi, molti bicchieri. Le sue idee erano vaghe, ora, e il coraggio tornava; una febbre di fuoco gli circolava nelle vene.
L’indomani non mangiò affatto, limitandosi a bere dell’alcool. E per parecchi giorni visse saturo di acquavite, come un bruto. Quando lo riprendeva il pensiero di Gaspard Hari, ricominciava a bere finché non cadeva a terra, stroncato dall’ebbrezza.
E restava lì, prono, ubriaco morto, le ossa rotte, russando con la fronte per terra. Ma non appena aveva digerito il liquido che lo bruciava e lo inebriava, il grido: «Ulrich!» sempre uguale, lo risvegliava come una pallottola che gli attraversasse il cranio; e si rialzava ciondolando, tendendo le mani per non cadere, chiamando Sam. E il cane, che pareva impazzire come il suo padrone, si precipitava alla porta, la graffiava, la rodeva con i suoi denti bianchi e lunghi, mentre il giovane, il collo rovesciato e la testa indietro, trangugiava a pieni sorsi, come si beve acqua fresca dopo una corsa, l’acquavite che gli addormentava ancora il pensiero, il ricordo, il folle terrore.
In tre settimane consumò tutta la scorta di alcool. Ma quell’ubriachezza continua non faceva che assopire il suo terrore, che si svegliò più furioso quando fu impossibile calmarlo. Allora l’idea fissa, esasperata da un mese di ubriachezza, cresciuta in un mese di solitudine, penetrava in lui come un succhiello.
Ora camminava nel rifugio come una bestia in gabbia, appoggiando l’orecchio alla porta per sentire se quello era là, e lo sfidava attraverso il muro.
Poi, quando sonnecchiava un po’, vinto dalla fatica, la voce lo faceva ancora balzare in piedi.
Una notte, infine, come un vile spinto all’estremo, si precipitò contro la porta e l’aprì per vedere colui che lo chiamava e per costringerlo a tacere.
Ricevette in pieno viso un soffio di aria fredda che lo gelò fin nelle ossa ed egli richiuse la porta sbattendola e serrò il chiavistello, senza accorgersi che Sam si era lanciato fuori. Fremendo, gettò legna sul fuoco e vi sedette davanti per scaldarsi; ma subito sobbalzò: qualcuno grattava il muro piangendo.
Gridò smarrito: «Vàttene!» Gli rispose un pianto, lungo e doloroso.
Allora ciò che gli restava della sua ragione gli fu portato via dal terrore.
Ripeté: «Vàttene!» girando su se stesso per trovare un angolo dove nascondersi. L’altro, sempre piangendo, girava attorno alla casa strofinandosi contro il muro.
Ulrich si lanciò verso la credenza di quercia, piena di vasellame e di provviste, e, sollevandola con uno sforzo sovrumano, la trascinò fino alla porta, per appoggiarvela come barricata. Poi, ammassando gli uni sugli altri tutti i mobili rimasti, i materassi, i pagliericci, le sedie, ostruì la finestra, come assalito da un nemico.
Ma quello là fuori lanciava ora grandi e lugubri gemiti ai quali il giovane si mise a rispondere con gemiti uguali.
Passarono giorni e notti senza che cessassero di urlare l’uno contro l’altro.
L’uno girava senza tregua intorno alla casa e grattava i muri con le unghie, con tanta forza che pareva li volesse demolire, l’altro, dentro, seguiva tutti i suoi movimenti curvo, l’orecchio incollato contro la parete e rispondeva ai richiami con grida spaventevoli.
Una sera Ulrich non sentì più nulla. Sedette, talmente stremato di fatica che si addormentò subito.
Si svegliò senza un ricordo, senza un pensiero, come se la testa gli si fosse svuotata durante quel sonno pesante. Aveva fame, mangiò.
L’inverno era finito. Il passaggio alla Gemmi ridiventava praticabile; la famiglia Hauser si mise in strada per tornare nel suo rifugio.
Raggiunta la parte più ripida della salita, le donne salirono sul loro mulo e si misero a parlare dei due uomini che fra poco avrebbero rivisto.
Si meravigliavano che uno dei due non fosse sceso qualche giorno prima, quando la via era diventata praticabile, per dare notizie del loro lungo soggiorno invernale.
Scorsero infine il rifugio, ancora coperto e incappucciato di neve.
Porta e finestra erano chiuse; dal tetto usciva un po’ di fumo, che rassicurò babbo Hauser.
Ma avvicinandosi egli scorse, sulla soglia, lo scheletro di un animale spolpato dalle aquile, un grande scheletro coricato su un fianco.
Tutti lo esaminarono attentamente.
«Dev’essere Sam», disse la madre. E chiamò: «Ehilà, Gaspard!» Dall’interno venne un grido, un grido acuto, che si sarebbe detto di animale.
Babbo Hauser ripeté: «Ehilà, Gaspard!» Un grido come il primo risuonò.
Allora i tre uomini, il padre ed i due figli, cercarono di aprire la porta. Ma resisteva. Presero dalla stalla vuota una lunga trave e la lanciarono contro servendosi di essa come un ariete. Il legno scricchiolando cedette, le assi volarono in pezzi, poi un gran fracasso scosse la casa.
Dentro videro, dietro la credenza crollata, un uomo in piedi, coi capelli che gli cadevano sulle spalle e la barba fino al petto, gli occhi lucidi, vestito di stracci.
Non lo riconobbero affatto, ma Louise gridò: «É Ulrich, mamma!» E la madre constatò che era Ulrich, benché avesse i capelli bianchi.
Egli li lasciò entrare, si lasciò toccare ma non rispose alle domande che gli rivolgevano; bisognò condurlo a Loeche dove i medici constatarono che era pazzo.
Nessuno seppe mai cosa ne fosse stato del suo compagno.
La piccola Hauser, quell’estate, fu sul punto di morire, a causa di una malattia di languore che fu attribuita al freddo della montagna.
in Racconti dell’incubo, Einaudi, Torino, 1993