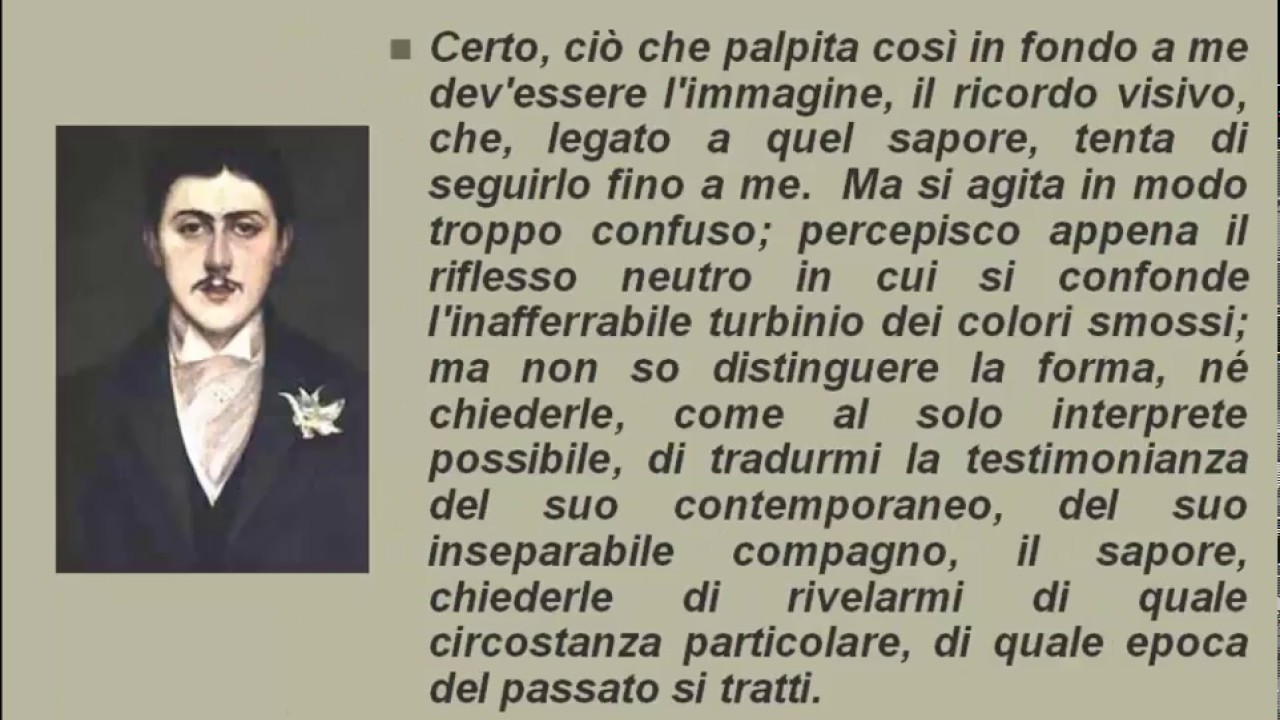Le valenze del verbo
28 Dicembre 2019
Il carnevale: una triste commedia da Senilità di Italo Svevo
28 Dicembre 2019Il romanzo del Novecento: trasformazioni e innovazioni di un genere letterario
Introduzione
Il Novecento rappresenta per il romanzo un periodo di profonde trasformazioni, caratterizzate da una rottura con le convenzioni narrative tradizionali e dall’emergere di nuove tecniche espressive che rispecchiano i cambiamenti sociali, filosofici e culturali dell’epoca. Questo articolo si propone di analizzare le principali innovazioni che hanno caratterizzato il romanzo novecentesco, evidenziando come il genere abbia risposto alle sollecitazioni della modernità e della postmodernità, rinnovandosi profondamente sia nella forma che nei contenuti.
La crisi del romanzo ottocentesco
Il romanzo del Novecento si sviluppa inizialmente come reazione alle convenzioni narrative del secolo precedente. Il romanzo realista e naturalista ottocentesco, con la sua pretesa di rappresentare obiettivamente la realtà sociale e con la sua struttura narrativa lineare, entra in crisi di fronte alle nuove scoperte scientifiche (la teoria della relatività, la psicoanalisi), alle trasformazioni sociali (l’industrializzazione, l’urbanizzazione) e ai drammatici eventi storici (le guerre mondiali) che caratterizzano l’inizio del secolo.
Come osserva György Lukács nel suo “Teoria del romanzo” (1916), il romanzo moderno nasce come espressione della “trascendenza divenuta problematica” in un mondo in cui l’unità tra l’individuo e il cosmo è ormai definitivamente compromessa. La fiducia nella possibilità di rappresentare oggettivamente la realtà viene meno, e gli scrittori iniziano a interrogarsi sul significato stesso dell’atto narrativo.
Lo stream of consciousness e l’interiorizzazione del romanzo
Una delle innovazioni più significative del romanzo novecentesco è rappresentata dalla tecnica dello “stream of consciousness” (flusso di coscienza), teorizzata dal filosofo William James e portata alle sue massime conseguenze da scrittori come James Joyce, Virginia Woolf e Dorothy Richardson. Questa tecnica narrativa mira a riprodurre sulla pagina il flusso ininterrotto di pensieri, sensazioni e associazioni mentali che caratterizza la vita interiore dei personaggi.
In opere come “Ulisse” (1922) di Joyce o “La signora Dalloway” (1925) di Woolf, l’azione esteriore diventa secondaria rispetto alla rappresentazione della coscienza dei personaggi. Il tempo cronologico viene sostituito dal tempo soggettivo della memoria e dell’esperienza, in quello che Henri Bergson definiva “durée” (durata). Come scrive Erich Auerbach in “Mimesis” (1946), “un avvenimento esteriore insignificante mette in libertà idee e catene di idee che abbandonano il loro presente per muoversi liberamente nelle profondità temporali”.
La frammentazione della narrazione e la dissoluzione del plot
Un’altra caratteristica fondamentale del romanzo novecentesco è la frammentazione della narrazione e la dissoluzione del plot tradizionale. Se il romanzo ottocentesco era caratterizzato da una struttura narrativa lineare, con un inizio, uno svolgimento e una fine ben definiti, molti romanzi del Novecento rifiutano questa struttura a favore di narrazioni frammentarie, discontinue, che riflettono la percezione di un mondo ormai privo di un significato unitario.
Opere come “La montagna incantata” (1924) di Thomas Mann, “La coscienza di Zeno” (1923) di Italo Svevo o “L’uomo senza qualità” (1930-1942) di Robert Musil rappresentano esempi significativi di questa tendenza. In esse, la trama tradizionale viene sostituita da una serie di riflessioni, digressioni e analisi che mirano a esplorare la complessità dell’esperienza umana piuttosto che a raccontare una storia nel senso convenzionale del termine.
La problematizzazione del narratore e la metanarrazione
Il romanzo del Novecento mette in discussione anche la figura del narratore onnisciente, caratteristica del romanzo ottocentesco. Al suo posto, emergono narratori inaffidabili, parziali, spesso implicati nella storia che raccontano, che non pretendono di offrire una visione oggettiva degli eventi narrati.
Questa problematizzazione del narratore si accompagna spesso a una riflessione sulla natura stessa dell’atto narrativo, in quella che viene definita “metanarrazione”. Romanzi come “Se una notte d’inverno un viaggiatore” (1979) di Italo Calvino o “La trilogia di New York” (1985-1987) di Paul Auster tematizzano esplicitamente il processo di scrittura e lettura, invitando il lettore a interrogarsi sul significato e sui limiti della narrazione.
Il romanzo e le avanguardie
Le avanguardie storiche del primo Novecento (futurismo, dadaismo, surrealismo) hanno esercitato un’influenza significativa sul romanzo, contribuendo alla sperimentazione formale e alla rottura con le convenzioni narrative tradizionali.
Il romanzo surrealista, in particolare, ha cercato di applicare alla narrativa i principi del surrealismo, valorizzando l’inconscio, il sogno e l’associazione libera. Opere come “Nadja” (1928) di André Breton o “Il grande sonno” (1939) di Raymond Chandler mostrano l’influenza di questa corrente, con la loro rappresentazione di una realtà enigmatica, irrazionale, spesso onirica.
Il romanzo e l’esperienza delle guerre mondiali
Le due guerre mondiali hanno profondamente segnato lo sviluppo del romanzo novecentesco, sia dal punto di vista tematico che formale. L’esperienza traumatica della guerra ha portato molti scrittori a interrogarsi sulla possibilità stessa di rappresentare l’orrore attraverso la narrazione.
Romanzi come “Addio alle armi” (1929) di Ernest Hemingway, “Viaggio al termine della notte” (1932) di Louis-Ferdinand Céline o “Catch-22” (1961) di Joseph Heller rappresentano diverse risposte a questa sfida. In essi, la guerra viene rappresentata non come un evento eroico o nobilitante, ma come un’esperienza di alienazione, assurdità e disumanizzazione, che richiede nuove forme narrative per essere adeguatamente espressa.
Il romanzo postmoderno
Nella seconda metà del Novecento, il romanzo subisce un’ulteriore trasformazione con l’emergere di quella che viene definita “letteratura postmoderna”. Caratterizzata da elementi come l’intertestualità, la metafinzione, la parodia e il pastiche, questa corrente letteraria riflette la condizione culturale del tardo capitalismo, caratterizzata dalla frammentazione dell’esperienza e dalla dissoluzione delle grandi narrazioni.
Romanzi come “I versi satanici” (1988) di Salman Rushdie, “L’arcobaleno della gravità” (1973) di Thomas Pynchon o “Il nome della rosa” (1980) di Umberto Eco sono esempi significativi di questa tendenza. In essi, la narrazione diventa un gioco di specchi, in cui diversi livelli di realtà si intersecano e si confondono, e il confine tra realtà e finzione si fa sempre più sfumato.
Il romanzo e la globalizzazione
Con l’accelerazione del processo di globalizzazione negli ultimi decenni del Novecento, il romanzo si è aperto a nuove influenze culturali e linguistiche, dando vita a forme narrative ibride che riflettono la complessità del mondo contemporaneo.
Scrittori come Salman Rushdie, V.S. Naipaul, Zadie Smith o Chimamanda Ngozi Adichie hanno creato opere che attraversano confini nazionali e culturali, mettendo in discussione le nozioni tradizionali di identità e appartenenza. Il loro lavoro rappresenta una delle direzioni più interessanti del romanzo contemporaneo, che continua a evolversi in risposta alle trasformazioni del mondo globalizzato.
Il romanzo e le nuove tecnologie
Infine, lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali ha influenzato profondamente il romanzo negli ultimi decenni del Novecento e all’inizio del nuovo millennio. Da un lato, la rivoluzione digitale ha portato alla nascita di nuove forme narrative, come l’ipertesto o la narrativa interattiva, che sfidano la linearità e la chiusura del romanzo tradizionale.
D’altro lato, molti romanzieri hanno tematizzato nelle loro opere l’impatto delle nuove tecnologie sulla vita contemporanea e sulla percezione della realtà. Romanzi come “Neuromante” (1984) di William Gibson, “L’arcobaleno della gravità” di Thomas Pynchon o “Infinite Jest” (1996) di David Foster Wallace esplorano le implicazioni culturali, sociali e esistenziali della rivoluzione tecnologica, offrendo una riflessione critica sulla società dell’informazione.
Conclusioni
Il romanzo del Novecento rappresenta un campo di sperimentazione e innovazione senza precedenti nella storia del genere letterario. Dalla crisi del romanzo realista all’emergere di nuove forme narrative che riflettono la complessità dell’esperienza contemporanea, il romanzo ha dimostrato una straordinaria capacità di rinnovarsi in risposta alle trasformazioni culturali, sociali e tecnologiche del secolo.
Come scrive Milan Kundera in “L’arte del romanzo” (1986), “il romanzo è l’ultima osservazione dell’uomo davanti alla condizione umana divenuta indecifrabile”. In un mondo sempre più complesso e frammentato, il romanzo continua a offrire uno spazio di riflessione e esplorazione delle possibilità e dei limiti dell’esperienza umana, confermando la sua vitalità come forma artistica e come strumento di conoscenza.
Bibliografia
- Auerbach, E. (1946). Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale.
- Bachtin, M. (1975). Estetica e romanzo.
- Calvino, I. (1988). Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio.
- Jameson, F. (1991). Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism.
- Kundera, M. (1986). L’arte del romanzo.
- Lukács, G. (1916). Teoria del romanzo.
- Moretti, F. (1987). Il romanzo di formazione.
- Watt, I. (1957). Le origini del romanzo borghese.
- Wood, J. (2008). Come funzionano i romanzi.