
Il treno ha fischiato di Luigi Pirandello
28 Dicembre 2019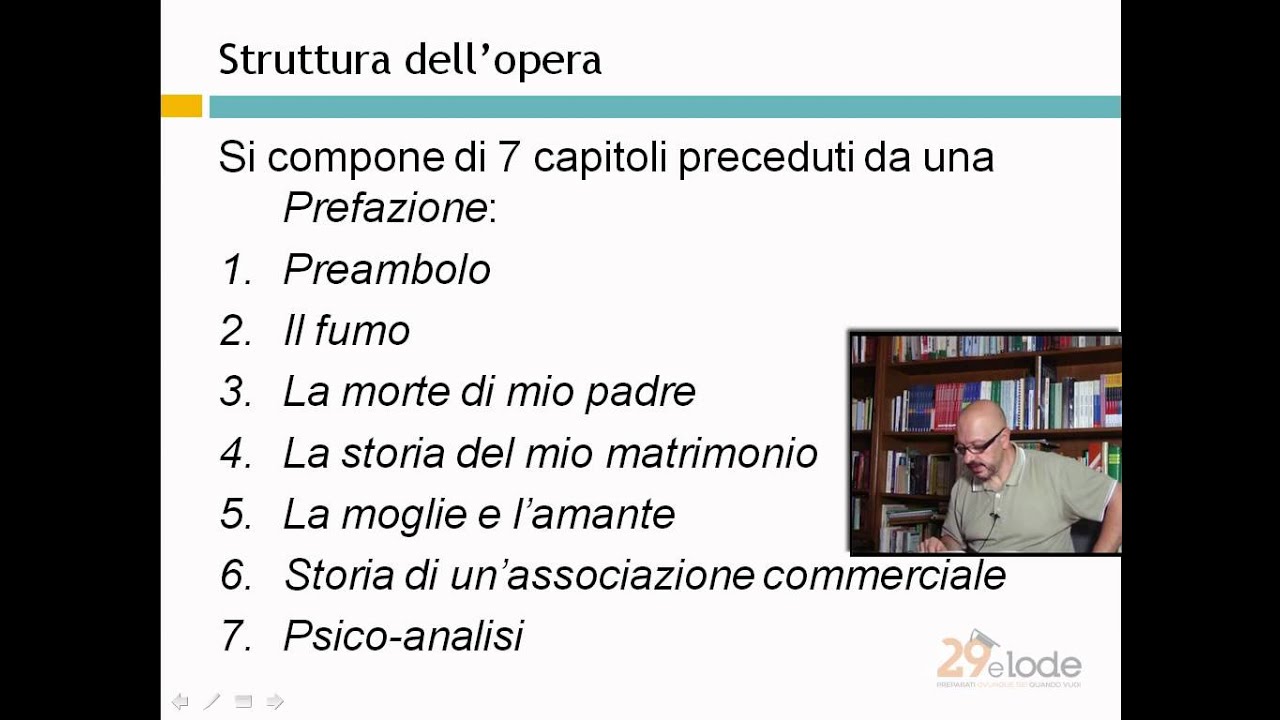
La coscienza di Zeno di Italo Svevo, e lettura del brano sulla Morte del padre
28 Dicembre 2019Il saggio sull’umorismo di Luigi Pirandello, pubblicato nel 1908, è uno dei testi più importanti per comprendere la sua poetica e il suo approccio alla letteratura.
Nel saggio, Pirandello definisce l’umorismo come una forma d’arte che, diversamente dalla comicità, non si limita a suscitare il riso superficiale, ma scava più in profondità, mettendo in evidenza le contraddizioni e le incongruenze della vita umana. Attraverso l’umorismo, Pirandello mostra come dietro la risata si nasconda spesso un sentimento più amaro, legato alla riflessione su temi universali come la fragilità dell’esistenza, la crisi dell’identità e la relatività della verità.
La distinzione tra comico e umoristico
Nel saggio, Pirandello distingue nettamente tra comicità e umorismo:
- La comicità nasce dal contrasto evidente e immediato tra la realtà e le aspettative. È ciò che provoca una risata istintiva, una reazione immediata e superficiale a una situazione grottesca o buffa. Ad esempio, una vecchia signora che si trucca e si veste in modo vistoso per sembrare più giovane suscita una risata comica perché il suo tentativo appare fuori luogo e assurdo.
- L’umorismo, invece, non si ferma a questo livello. Esso riflette su ciò che sta dietro al gesto o alla situazione, cercando di comprenderne le motivazioni profonde. Usando l’esempio della vecchia signora truccata, Pirandello spiega che, mentre il comico si limita a ridere del tentativo maldestro della donna di apparire giovane, l’umorista comprende il dramma che sta dietro quel gesto: la paura della vecchiaia, il desiderio di sentirsi ancora viva, la nostalgia per la gioventù perduta. In questo modo, l’umorismo passa dal ridicolo alla compassione, dalla risata alla riflessione.
“Avvertimento del contrario” è la chiave dell’umorismo: dopo aver percepito un contrasto comico, l’umorismo sorge quando si va oltre e si intuisce la discrepanza interiore, ciò che spinge una persona a compiere quel gesto o vivere quella situazione. La comprensione di questa discrepanza genera un sentimento più complesso, un misto di riso e dolore, di compassione e riflessione.
L’umorismo come strumento di indagine psicologica
Pirandello, influenzato dalle idee del Decadentismo e dalla psicologia moderna (soprattutto il pensiero di Freud), vede nell’umorismo uno strumento per indagare le profondità dell’animo umano. Attraverso l’umorismo, si può esaminare la frammentazione dell’identità e la crisi dell’individuo nella società moderna. Il saggio riflette la sua convinzione che l’individuo sia diviso tra l’essere e il sembrare, costretto a indossare maschere per adattarsi alle aspettative sociali.
La figura umoristica pirandelliana, come Mattia Pascal o Vitangelo Moscarda in “Uno, nessuno e centomila”, è spesso un personaggio che vive un dramma interiore legato all’incapacità di conciliare la propria realtà soggettiva con quella imposta dagli altri. Questi personaggi sono spesso inetti, incapaci di agire in maniera decisa, e si trovano sospesi tra il desiderio di autenticità e l’impossibilità di sfuggire alle maschere sociali.
Il relativismo pirandelliano e la crisi dell’io
Pirandello utilizza l’umorismo anche come un modo per esprimere il suo relativismo filosofico. Per lui, non esiste una verità assoluta, ma solo una molteplicità di verità, ognuna relativa al punto di vista individuale. Ogni persona percepisce il mondo in modo diverso, e l’umorismo permette di mettere a confronto queste diverse prospettive, mostrando come ogni verità sia inevitabilmente parziale e frammentata.
Questo relativismo è centrale in molte delle sue opere, dove i personaggi si trovano a scontrarsi con la mancanza di certezze. Il sentimento umoristico nasce proprio da questa consapevolezza: l’individuo, pur riconoscendo l’assurdità della vita e delle sue convenzioni, non può far altro che convivere con esse, generando un sentimento di amara accettazione.
Umorismo e vita moderna
Il saggio sull’umorismo di Pirandello riflette profondamente la crisi dell’uomo moderno, alienato in un mondo in cui le certezze assolute sono crollate. La vita diventa un teatro di maschere, dove ogni persona recita un ruolo imposto dagli altri o dalla società, ma nessuno riesce a essere davvero autentico. L’umorismo diventa così lo strumento attraverso cui Pirandello esprime la disillusione dell’uomo moderno, costretto a vivere in un mondo di apparenze e illusioni.
Conclusione
Il saggio sull’umorismo di Pirandello non è solo un’analisi teorica, ma una chiave di lettura per comprendere tutta la sua produzione artistica, dai romanzi alle opere teatrali. L’umorismo, come definito da Pirandello, è una forma d’arte che mette in luce la complessità e la contraddittorietà della condizione umana, rivelando come dietro ogni gesto comico o grottesco ci sia un profondo dramma interiore. Pirandello trasforma la risata in un mezzo di riflessione critica sulla vita, mostrando che l’umorismo non è solo un gioco di parole o situazioni, ma una forma di consapevolezza esistenziale.




