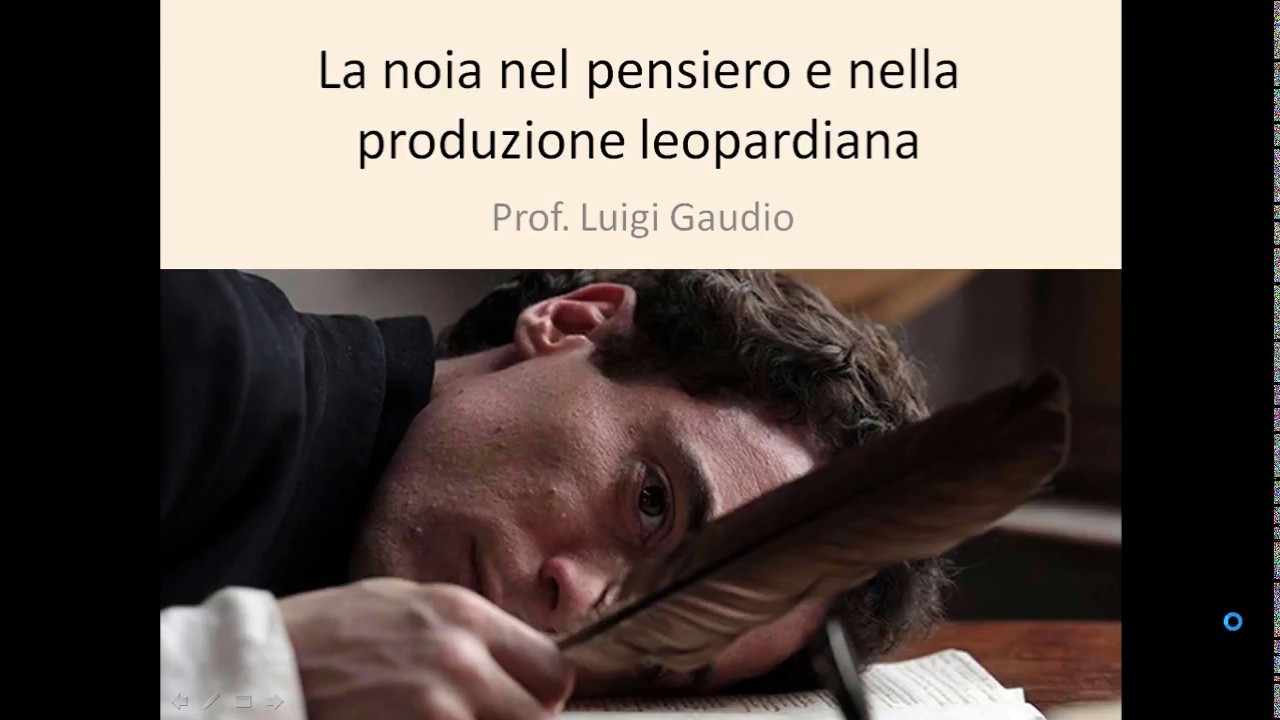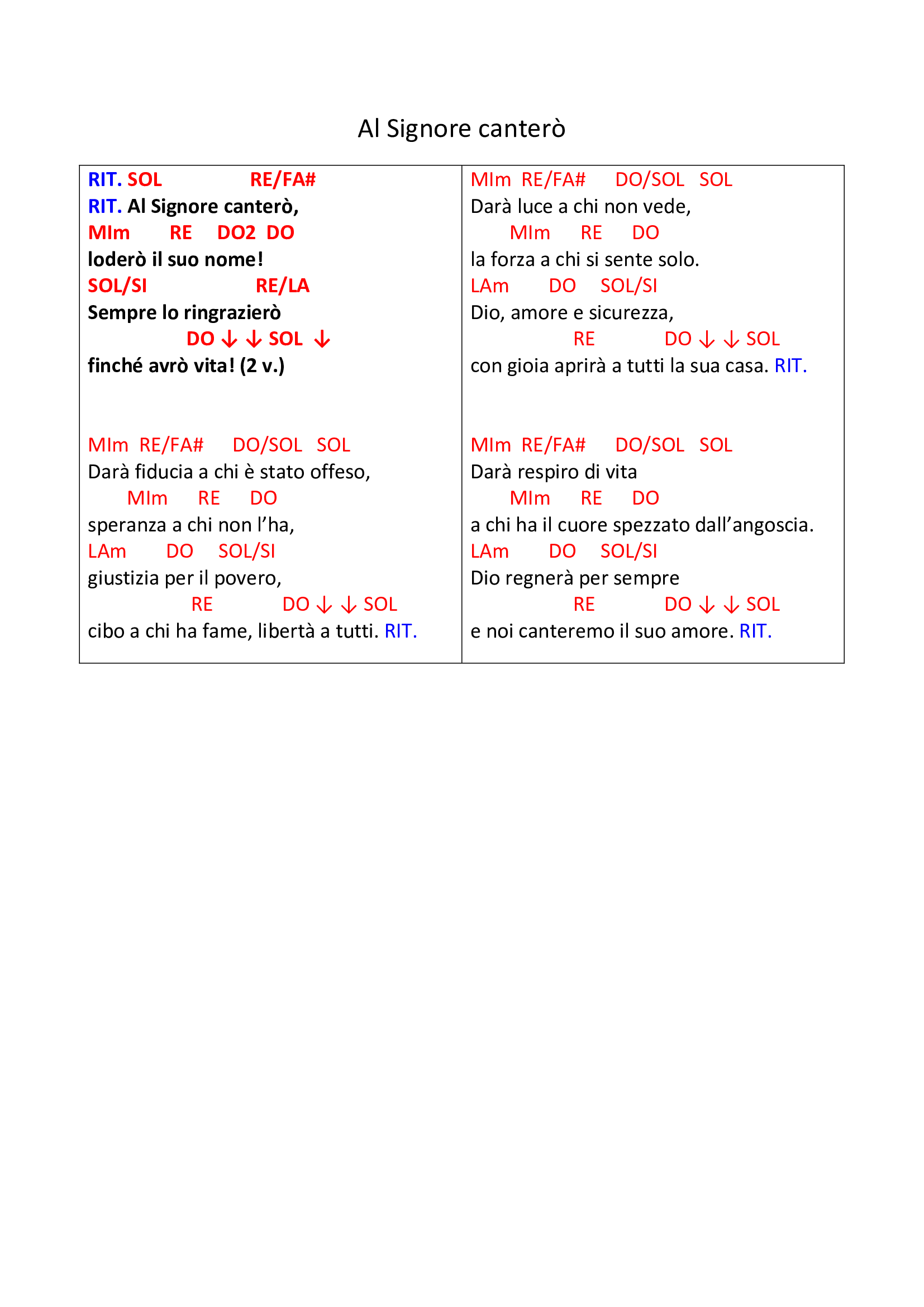
Al Signore canterò
28 Dicembre 2019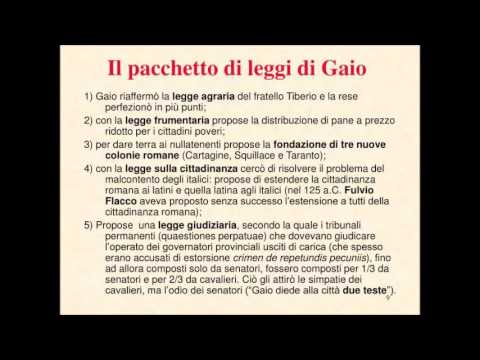
Le riforme dei Gracchi seconda parte: Caio Gracco
28 Dicembre 2019Giacomo Leopardi (1798-1837) è una delle figure centrali della letteratura italiana e uno dei più grandi poeti e pensatori dell’Ottocento europeo.
La sua opera è il frutto di un sistema filosofico (la sua ideologia) profondamente originale e coerente, che si traduce in una poetica altrettanto innovativa. Il suo pensiero, sviluppatosi attraverso una rigorosa autoanalisi e una vasta erudizione, è inscindibile dalla sua produzione lirica: i Canti sono la sublime espressione poetica delle riflessioni contenute nello Zibaldone di pensieri.
1. Il Sistema Filosofico (Ideologia Leopardiana): Il Pessimismo
Il pensiero di Leopardi è dominato da una visione profondamente pessimistica della condizione umana, che evolve attraverso diverse fasi.
A) Pessimismo Storico (o della Ragione)
- Fase Iniziale: Nei primi anni (fino al 1819 circa), Leopardi ritiene che l’infelicità dell’uomo sia una conseguenza del progresso della ragione e della civiltà.
- La Natura Benevola e le Illusioni: In origine, l’uomo viveva in uno stato di armonia con una Natura benigna, che lo dotava di “illusioni” (miti, fantasie, grandi ideali eroici, l’amore, la gloria). Queste illusioni, pur non essendo vere, erano fonte di felicità e mitigavano la percezione del dolore.
- La Ragione Distruttrice: La ragione, con il suo sviluppo, ha svelato la vanità delle illusioni, distruggendo la capacità umana di illudesi e rivelando la nuda e cruda verità dell’esistenza. L’uomo moderno è infelice perché è consapevole della sua condizione.
B) Pessimismo Cosmico (o della Natura Matrigna)
- Fase Matura: Intorno al 1819-1820, il pensiero di Leopardi si radicalizza. Non è più la ragione a essere la causa del male, ma la Natura stessa. La Natura, lungi dall’essere benigna, è una forza cieca, indifferente e crudele, una “matrigna” che genera gli esseri viventi solo per distruggerli, in un ciclo perpetuo di creazione e annientamento.
- Il Male Ontologico: Il male e il dolore non sono un incidente o una punizione, ma una condizione intrinseca e ineludibile dell’esistenza. Ogni creatura è destinata alla sofferenza e alla morte, in quanto parte di un meccanismo universale che non ha alcuna finalità per il singolo individuo.
- La Teoria del Piacere: Il piacere non è un’entità positiva, ma solo la cessazione del dolore o l’attesa di un piacere futuro che, una volta raggiunto, si rivela sempre inferiore all’aspettativa, lasciando un senso di vuoto e insoddisfazione. L’uomo è condannato a un “infinito desiderio” di piacere che non potrà mai essere appagato da una realtà finita.
C) La “Social Catena” (o Pessimismo Eroico)
- Fase Finale: Di fronte all’ineluttabilità del male cosmico, Leopardi individua una forma di resistenza: la solidarietà tra gli uomini. Gli uomini, consapevoli della loro comune condizione di infelicità e della crudeltà della Natura, dovrebbero unirsi in una “social catena” (una sorta di alleanza fraterna) per combattere il vero nemico: l’indifferenza della Natura e il dolore che essa infligge. Non si tratta di eliminare il male, ma di affrontarlo con dignità, consapevolezza e reciproco sostegno.
- L’Eroismo della Consapevolezza: L’eroismo non sta più nell’illusione o nella lotta contro un nemico esterno, ma nella lucida consapevolezza del proprio destino e nella capacità di non piegarsi alla disperazione, mantenendo la propria dignità.
2. La Poetica Leopardiana: L’Espressione del Pensiero
La poetica di Leopardi è la diretta conseguenza e la sublime espressione del suo sistema filosofico. Essa è caratterizzata da una ricerca costante dell’indefinito e del vago, elementi che permettono di evocare l’infinito desiderio umano e la sua frustrazione.
A) La Teoria del Vago e dell’Indefinito
- Il Piacere dell’Immaginazione: Poiché il piacere sensibile è effimero e insoddisfacente, l’unico vero piacere risiede nell’immaginazione. L’immaginazione è stimolata da tutto ciò che è “vago, indefinito, lontano”, perché ciò che non è definito permette alla mente di spaziare e di creare illusioni di infinito.
- Tecniche Poetiche: Per ottenere questo effetto, Leopardi utilizza:
- Aggettivi e Avverbi: “Antico”, “lontano”, “silenzioso”, “ermo”, “infinito”, “eterno”, “soave”, “dolce”, “profondo”, “ultimo”.
- Immagini Uditive: Il suono del vento, il canto degli uccelli, il rumore del mare, il silenzio.
- Immagini Visive: La luna, il cielo stellato, il colle, la siepe, le rovine, l’orizzonte.
- Sintassi e Ritmo: L’uso dell’enjambement (spezzatura del verso) per creare sospensione e dilatare il senso; la fluidità del verso (spesso endecasillabo sciolto) che imita il flusso del pensiero.
B) La Lingua Poetica
- Classicismo e Innovazione: La lingua di Leopardi è un mirabile equilibrio tra un classicismo formale (lessico elevato, sintassi complessa ma armoniosa) e un’innovazione espressiva. Egli recupera la tradizione lirica italiana, ma la piega alle sue esigenze di introspezione e riflessione filosofica.
- Musicalità e Sonorità: La scelta delle parole è dettata anche dal loro suono. Leopardi ricerca la musicalità del verso attraverso l’allitterazione, l’assonanza, la consonanza e la combinazione sapiente di vocali e consonanti, creando effetti di dolcezza, malinconia o asprezza a seconda del tema.
C) Le Forme Poetiche
- Gli Idilli: Brevi componimenti lirici (es. L’infinito, La sera del dì di festa, Alla luna) in cui il poeta si confronta con un paesaggio o un’immagine che stimola la sua riflessione interiore e la sua meditazione sul tempo, la memoria, il desiderio e la natura.
- I Grandi Idilli (o Canti Pisano-Recanatesi): Componimenti più ampi e complessi (es. A Silvia, Le ricordanze, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta) che approfondiscono i temi del ricordo, della speranza, della delusione e del ruolo della natura.
- Le Canzoni: Componimenti più elaborati e di tono più elevato, spesso di carattere civile o filosofico (es. All’Italia, A un monumento di Dante, Ultimo canto di Saffo).
- La Ginestra: Poema testamento, in cui il pessimismo cosmico si traduce nell’invito alla solidarietà umana di fronte alla Natura distruttrice.
3. Il Legame Indissolubile tra Ideologia e Poetica
In Leopardi, ideologia e poetica non sono due entità separate, ma due facce della stessa medaglia. Il suo pensiero filosofico non è mai arido o astratto, ma si traduce sempre in un’esperienza emotiva e sensoriale attraverso la poesia. Allo stesso modo, la sua poesia non è mai puramente estetica, ma è sempre intrisa di una profonda riflessione sulla condizione umana.
- La sofferenza diventa materia poetica.
- L’infinito desiderio si esprime attraverso il vago e l’indefinito.
- La Natura indifferente è descritta con immagini di sublime bellezza.
- La caducità è resa con una malinconia struggente.
Questa fusione tra rigore intellettuale e sensibilità lirica rende Leopardi un unicum nel panorama letterario, un poeta-filosofo che ha saputo interrogare i grandi interrogativi dell’esistenza con una lucidità e una bellezza ineguagliabili.