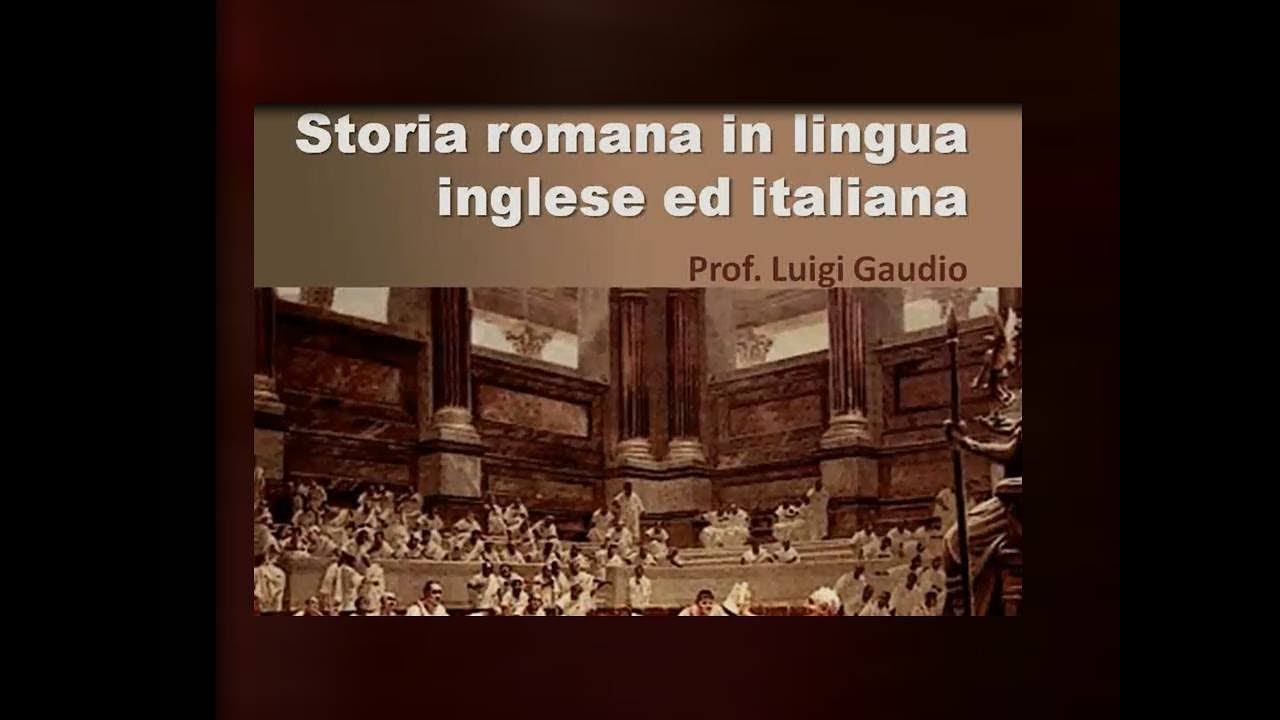
Andare a scuola a Roma
28 Dicembre 2019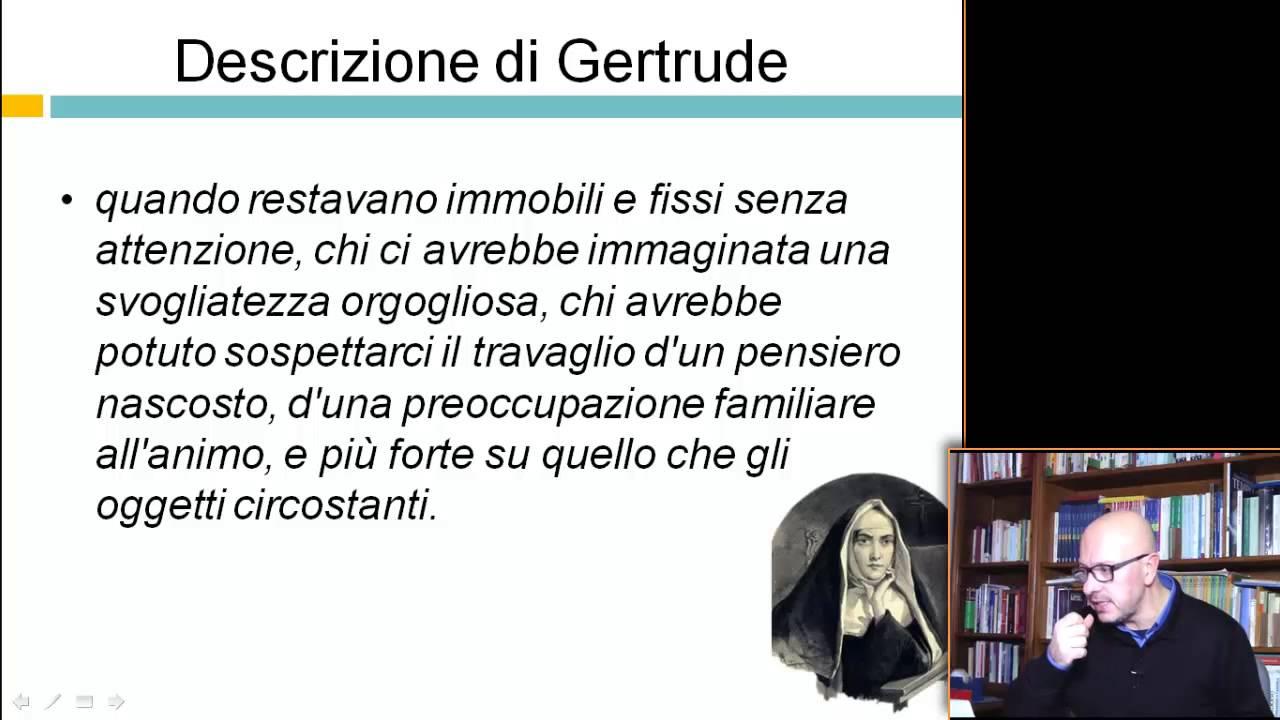
Capitoli nono e decimo dei Promessi Sposi
28 Dicembre 2019Forse nessun periodo come il primo secolo a.C. è stato così denso e foriero di trasformazioni
L’epoca di Pompeo
Il “tempo di Pompeo” si riferisce al periodo cruciale della storia romana che va all’incirca dalla fine delle guerre civili di Silla (primi anni del I secolo a.C.) fino alla sua morte nel 48 a.C., un’epoca caratterizzata da profondi sconvolgimenti politici, sociali e militari che condussero al tramonto della Repubblica Romana e all’ascesa del potere individuale. Gneo Pompeo Magno, figura centrale di questo periodo, fu un generale e politico di straordinario talento, la cui ambizione e le cui azioni modellarono in modo irreversibile il destino di Roma.
1. Introduzione: Gneo Pompeo Magno e l’Epoca di Transizione
Gneo Pompeo Magno (106 a.C. – 48 a.C.) fu uno dei protagonisti indiscussi degli ultimi decenni della Repubblica Romana. La sua carriera, iniziata precocemente con successi militari straordinari, lo portò a essere acclamato come uno dei più grandi generali della sua epoca, guadagnandosi il soprannome di Magnus (“il Grande”). Il “suo tempo” coincide con una fase di transizione violenta e complessa, in cui le istituzioni repubblicane, pensate per una città-stato, si dimostrarono inadeguate a governare un impero sempre più vasto e a gestire le tensioni tra le fazioni aristocratiche, la crescente militarizzazione della politica e le esigenze di un popolo in trasformazione.
2. L’Ascesa al Potere: Il “Giovane Macellaio” e il Conquistatore
La carriera di Pompeo è un esempio lampante di come l’abilità militare potesse fungere da trampolino di lancio per il potere politico nella tarda Repubblica.
- L’Alleato di Silla (anni ’80 a.C.): Pompeo emerse come giovane ma spietato sostenitore di Lucio Cornelio Silla durante le guerre civili contro i populares di Mario. Dimostrò subito una notevole abilità strategica e una brutalità che gli valsero il soprannome di adulescentulus carnifex (“il giovane macellaio”). Silla, riconoscendo il suo talento ma temendone anche l’ambizione, lo ricompensò con un trionfo nel 81 a.C. per le vittorie in Africa, un onore eccezionale per un uomo che non aveva ancora ricoperto alcuna magistratura senatoria.
- La Guerra Sertoriana (76-71 a.C.): Nonostante la sua giovane età e l’assenza di un cursus honorum tradizionale, Pompeo fu inviato in Spagna per combattere Quinto Sertorio, un abile generale mariano che aveva creato uno stato indipendente. La campagna fu lunga e difficile, ma Pompeo, affiancato da Metello Pio, riuscì infine a sconfiggere Sertorio, dimostrando grande tenacia e capacità di comando.
- La Rivolta di Spartaco (73-71 a.C.): Al suo ritorno dalla Spagna, Pompeo si imbatté nei resti dell’esercito di schiavi di Spartaco, già duramente sconfitto da Marco Licinio Crasso. Pompeo rivendicò una parte del merito della vittoria finale, acuendo la rivalità con Crasso. La sua partecipazione, sebbene marginale alla battaglia decisiva, gli permise di accrescere ulteriormente il suo prestigio.
- Consolato e Leggi Speciali (70 a.C. e successivi): Nel 70 a.C., Pompeo e Crasso, nonostante le tensioni reciproche, furono eletti consoli. Durante il loro consolato smantellarono gran parte delle riforme sillane, ripristinando il potere dei tribuni della plebe e dei censori, e riformando il sistema giudiziario. Successivamente, Pompeo ottenne poteri straordinari tramite leggi speciali:
- La Lex Gabinia (67 a.C.): Gli conferì un comando illimitato per tre anni nella lotta contro i pirati che infestavano il Mediterraneo. Pompeo organizzò una campagna fulminea e incredibilmente efficace, debellando la minaccia piratica in soli tre mesi, un successo che gli valse un’enorme popolarità e confermò la sua reputazione di genio militare.
- La Lex Manilia (66 a.C.): Gli assegnò il comando supremo nella guerra contro Mitridate VI del Ponto, un avversario formidabile che aveva a lungo sfidato Roma in Oriente. Pompeo condusse una serie di campagne brillanti, sconfiggendo Mitridate, riorganizzando profondamente le province orientali e annettendo nuovi territori, espandendo significativamente l’influenza romana. Questo trionfo orientale fu il culmine della sua carriera militare.
3. Il Primo Triumvirato: Un’Alleanza Instabile (60-53 a.C.)
Nonostante i suoi successi, Pompeo incontrò resistenze in Senato, in particolare per la ratifica dei suoi provvedimenti in Oriente e per la concessione di terre ai suoi veterani. Questa opposizione lo spinse a cercare un’alleanza informale con due altre figure emergenti:
- Pompeo, Crasso e Cesare: Nel 60 a.C., Pompeo si unì a Marco Licinio Crasso (l’uomo più ricco di Roma) e a Gaio Giulio Cesare (un ambizioso politico emergente con grande influenza popolare) per formare il cosiddetto Primo Triumvirato. Questa alleanza privata, basata su interessi reciproci, mirava a superare l’ostruzionismo del Senato e a garantire a ciascuno dei tre il raggiungimento dei propri obiettivi politici. Pompeo ottenne la ratifica dei suoi atti in Oriente e le terre per i suoi veterani.
- Tensioni e Dissoluzione: Il Triumvirato, pur efficace nel breve termine, era intrinsecamente instabile a causa delle ambizioni personali dei suoi membri. La morte di Crasso nella battaglia di Carre (53 a.C.) e la crescente popolarità e potenza militare di Cesare dopo la conquista della Gallia fecero sì che l’equilibrio di potere si rompesse, portando a una polarizzazione tra Pompeo e Cesare. Il Senato, che aveva inizialmente osteggiato Pompeo, ora lo vide come un contrappeso necessario all’inarrestabile ascesa di Cesare.
4. La Guerra Civile Contro Cesare: La Caduta di un Gigante (49-48 a.C.)
La rivalità tra Pompeo e Cesare divenne insostenibile, sfociando in un’altra devastante guerra civile.
- Il Rubicone (49 a.C.): Quando Cesare, ignorando l’ordine del Senato di sciogliere le sue legioni e tornare a Roma come privato cittadino, attraversò il Rubicone con le sue truppe, pronunciando la famosa frase “Alea iacta est” (il dado è tratto), la guerra fu inevitabile.
- La Campagna e la Sconfitta: Pompeo, forte del sostegno del Senato e di gran parte dell’aristocrazia, inizialmente si ritirò in Grecia per riorganizzare le sue forze, mentre Cesare si assicurava il controllo dell’Italia e della Spagna. Lo scontro decisivo avvenne a Farsalo (48 a.C.), in Tessaglia. Nonostante la superiorità numerica, l’esercito di Pompeo fu sbaragliato da quello di Cesare, più disciplinato e guidato da un generale superiore.
- Morte in Egitto (48 a.C.): Dopo la sconfitta, Pompeo cercò rifugio in Egitto, sperando nell’ospitalità del re Tolomeo XIII. Tuttavia, per ingraziarsi Cesare, Tolomeo ordinò che Pompeo fosse assassinato appena sbarcato, un tradimento ignobile che pose fine alla vita di uno degli uomini più potenti di Roma. Cesare, quando gli fu presentata la testa di Pompeo, fu profondamente addolorato, sia per la tragica fine di un rivale che aveva rispettato, sia per la violazione delle tradizioni romane di ospitalità.
5. Il Contesto Sociopolitico: Una Repubblica in Crisi Terminale
Il “tempo di Pompeo” non può essere compreso senza analizzare il contesto di profonda crisi che stava affliggendo la Repubblica Romana.
- Fragilità Istituzionale: Le istituzioni repubblicane, basate sul potere del Senato e sulle magistrature annuali, si rivelarono sempre più inefficaci di fronte all’espansione territoriale e alle crescenti tensioni sociali. L’esercito, professionalizzato dalle riforme di Mario, divenne un’arma nelle mani di generali ambiziosi, legati più ai loro veterani che allo Stato.
- Lotte di Fazione: La politica romana era dominata da fazioni aristocratiche rivali (gli optimates, conservatori, e i populares, più riformisti), che spesso usavano la violenza e la corruzione per affermare il proprio dominio, erodendo la fiducia nel sistema.
- Disuguaglianze Sociali: Le guerre civili e l’espansione avevano acuito le disuguaglianze. La plebe urbana era spesso soggetta alla manipolazione tramite distribuzioni di grano e spettacoli, mentre la crescente ricchezza di pochi si scontrava con la povertà di molti.
- Il Ruolo dei “Grandi Uomini”: Pompeo, Crasso e Cesare furono figure che, con le loro immense ricchezze, i loro eserciti privati e la loro influenza carismatica, contribuirono a smantellare i principi repubblicani, spostando il potere dalle istituzioni al dominio personale. Il “tempo di Pompeo” è emblematico di questo passaggio dall’oligarchia repubblicana al potere individuale, aprendo la strada all’età degli imperatori.
6. Eredità e Significato
Pompeo Magno fu un generale di indubbia grandezza e un abile politico, la cui carriera rifletteva le opportunità e le contraddizioni della tarda Repubblica. La sua ascesa fu un sintomo della crisi di un sistema che non riusciva più a contenere le ambizioni individuali e le forze disgregatrici. La sua sconfitta e morte a Farsalo non furono solo la fine di un uomo, ma segnarono la fine di un’era, consolidando il cammino verso il principato di Cesare e, in ultima analisi, l’Impero. Il “tempo di Pompeo” è quindi il preludio drammatico alla trasformazione più radicale nella storia di Roma.




