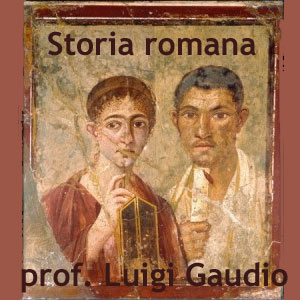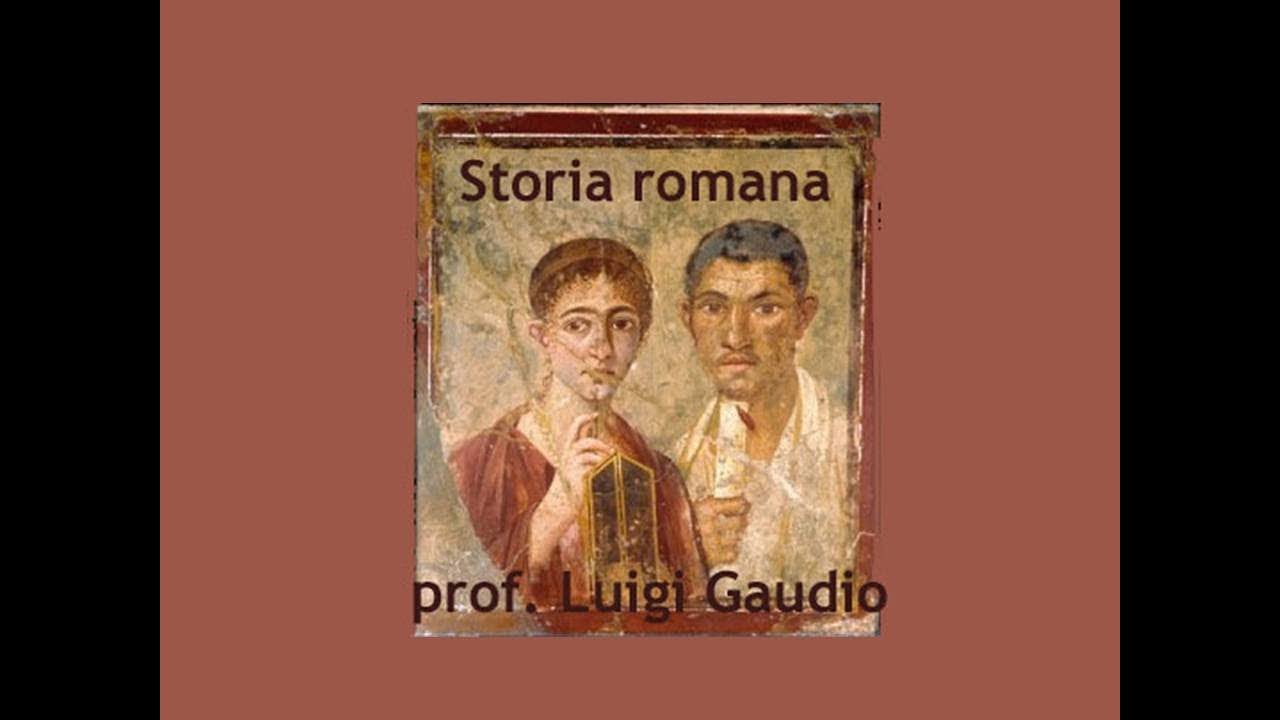
Guerre contro i Sanniti e contro Pirro
28 Dicembre 2019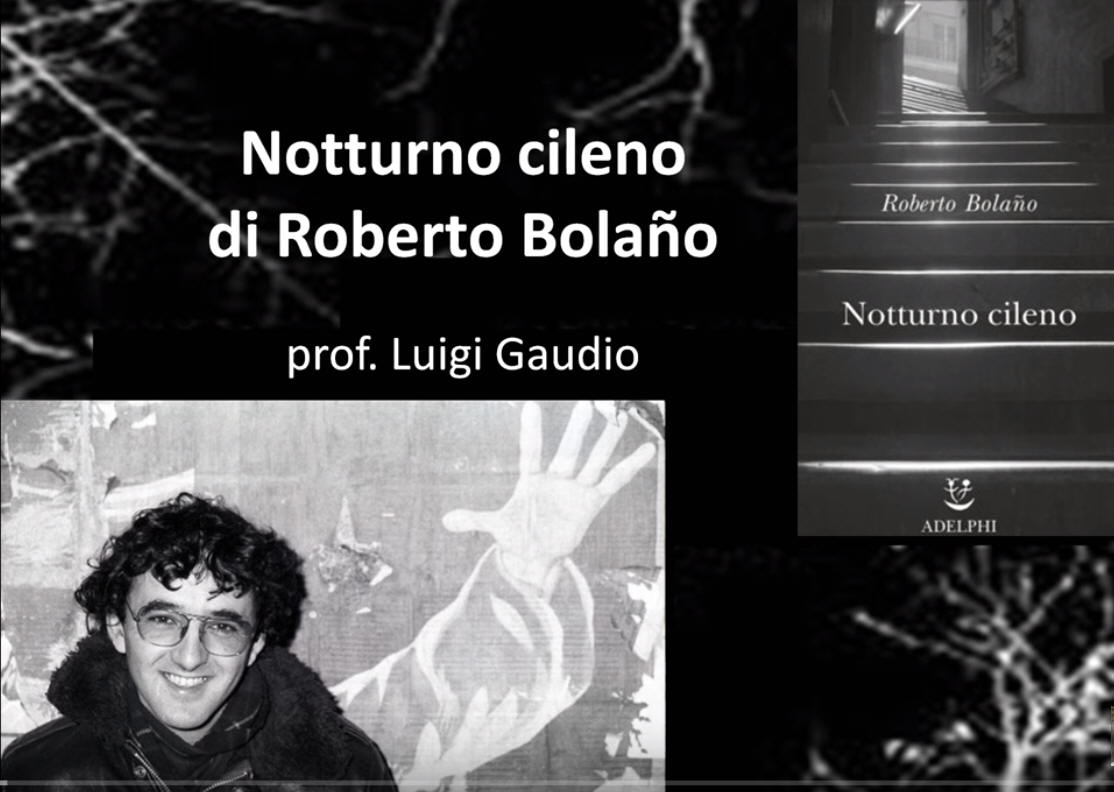
Notturno cileno di Roberto Bolano
28 Dicembre 2019Il III secolo a.C. rappresenta uno dei periodi più decisivi e trasformativi della storia romana, segnando il passaggio di Roma da potenza regionale italica a dominatrice del Mediterraneo.
Questo secolo è caratterizzato da conquiste militari straordinarie, profonde trasformazioni sociali ed economiche, e l’emergere di una nuova consapevolezza politica e culturale che porterà Roma al dominio mondiale.
Il contesto iniziale: Roma dopo le guerre sannitiche All’inizio del III secolo a.C., Roma aveva appena concluso vittoriosamente le guerre sannitiche (343-290 a.C.), stabilendo la propria egemonia sull’Italia centrale e meridionale. Il sistema delle alleanze (foedus) aveva creato una confederazione italica sotto l’egida romana, ma la vera prova di forza doveva ancora arrivare con lo scontro contro le potenze del Mediterraneo.
La società romana del primo III secolo era ancora essenzialmente agricola, dominata dall’aristocrazia patrizio-plebea che aveva raggiunto un equilibrio attraverso le riforme dei secoli precedenti. Il conflitto degli ordini si era sostanzialmente concluso con l’integrazione della plebe ricca nel patriziato e la creazione di una nuova élite dirigente, la nobilitas, basata sul merito politico-militare oltre che sulla nascita.
La guerra di Pirro (280-275 a.C.) Il primo grande scontro internazionale di Roma nel III secolo fu la guerra contro Pirro, re dell’Epiro, chiamato in Italia dalle città greche del Sud minacciate dall’espansione romana. Pirro rappresentava la tradizione militare ellenistica, con i suoi eserciti professionali, la falange macedone e i temibili elefanti da guerra.
Le battaglie di Eraclea (280 a.C.) e Ascoli Satriano (279 a.C.) furono vittorie tattiche di Pirro, ma a costo di perdite così elevate da coniare l’espressione “vittoria di Pirro”. La guerra rivelò le qualità fondamentali del sistema militare romano: la capacità di assorbire le sconfitte senza crollare, il continuo rifornimento di truppe grazie al sistema confederativo, la tenacia strategica che privilegiava gli obiettivi a lungo termine rispetto ai successi tattici immediati.
La vittoria finale romana a Benevento (275 a.C.) e la successiva conquista di Taranto (272 a.C.) completarono l’unificazione dell’Italia peninsulare sotto l’egemonia romana. Roma si trovò così ad essere la potenza dominante di una penisola unificata per la prima volta nella storia, con una popolazione di circa quattro milioni di abitanti e risorse militari immense.
Le guerre puniche: lo scontro per il Mediterraneo Le guerre puniche (264-146 a.C.) dominano la storia del III secolo e rappresentano il conflitto decisivo per il controllo del Mediterraneo occidentale. Cartagine, l’antica colonia fenicia divenuta grande potenza commerciale e navale, controllava il Nord Africa, la Spagna meridionale, la Sardegna, la Corsica e la Sicilia occidentale, costituendo il principale ostacolo all’espansione romana.
La Prima Guerra Punica (264-241 a.C.) Il conflitto iniziò per il controllo di Messina e si trasformò rapidamente in una guerra totale per la supremazia nel Mediterraneo occidentale. Per Roma rappresentò una sfida senza precedenti: dovette trasformarsi da potenza terrestre in potenza navale, costruendo ex novo una flotta capace di competere con quella cartaginese.
L’innovazione del corvus, ponte d’abbordaggio che permetteva ai legionari di combattere sulle navi come sulla terraferma, simboleggia la capacità romana di adattamento tecnologico. Le vittorie navali di Milazzo (260 a.C.) e soprattutto delle Egadi (241 a.C.) assicurarono a Roma il controllo del mare e la vittoria finale.
La conquista della Sicilia (tranne Siracusa, alleata romana) rappresentò il primo territorio extraitalico di Roma, segnando l’inizio dell’imperialismo mediterraneo. L’isola divenne la prima provincia romana, introducendo il nuovo sistema di governo territoriale basato su governatori annuali e tributo fisso.
L’intervallo tra le guerre e l’espansione adriatica Il periodo tra la prima e la seconda guerra punica vide Roma consolidare le proprie conquiste e espandere la propria influenza. La conquista dell’Illiria (229-228 a.C. e 219 a.C.) portò Roma per la prima volta a contatto diretto con il mondo greco, stabilendo protettorati sulle città costiere dalmate e intervenendo nella complessa politica ellenistica.
Contemporaneamente, Roma dovette affrontare l’invasione gallica del 225 a.C., quando una confederazione di tribù celtiche penetrò profondamente in Italia. La vittoria di Telamone dimostrò la maturità del sistema militare romano e aprì la strada alla conquista della Gallia Cisalpina, completata con la fondazione delle colonie di Cremona e Piacenza (218 a.C.).
La Seconda Guerra Punica (218-201 a.C.): la guerra di Annibale La seconda guerra punica rappresenta il momento più drammatico della storia repubblicana, quando Roma rischiò l’esistenza stessa di fronte al genio militare di Annibale Barca. Il giovane generale cartaginese, cresciuto nell’odio verso Roma e formatosi nelle guerre iberiche, concepì il piano audacissimo di attaccare Roma dal Nord attraverso le Alpi.
La traversata alpina (218 a.C.) con un esercito multietnico di oltre 90.000 uomini e 37 elefanti rimane una delle imprese militari più straordinarie dell’antichità. Le vittorie di Annibale al Trebia (218 a.C.), al Trasimeno (217 a.C.) e soprattutto a Canne (216 a.C.) portarono Roma sull’orlo del collasso.
Canne rappresenta il capolavoro tattico di Annibale: utilizzando la famosa manovra a tenaglia (doppio avvolgimento), l’esercito cartaginese annientò completamente due eserciti consolari romani, uccidendo circa 50.000 soldati tra cui il console Lucio Emilio Paolo. Mai nella sua storia Roma aveva subito una sconfitta così devastante.
La reazione romana alla catastrofe rivelò le qualità fondamentali del sistema politico repubblicano. Invece di cercare la pace, il Senato proclamò che nessun romano avrebbe dovuto parlare di resa. La strategia fabian di Quinto Fabio Massimo, basata sull’evitamento dello scontro diretto e l’logoramento del nemico, permise a Roma di sopravvivere al momento più critico.
La guerra si trasformò gradualmente in un conflitto di logoramento. Roma riuscì a mantenere la fedeltà della maggior parte degli alleati italici, dimostrando la solidità del sistema confederativo. Le defezioni più significative (Capua, Taranto, alcune città della Magna Grecia) non furono sufficienti a ribaltare l’equilibrio strategico.
La controffensiva romana e Scipione l’Africano La svolta della guerra arrivò con l’emergere di Publio Cornelio Scipione, poi soprannominato l’Africano. La sua conquista della Spagna cartaginese (210-206 a.C.) privò Cartagine delle risorse iberiche e impedì l’arrivo di rinforzi ad Annibale. La vittoria di Scipione a Ilipa (206 a.C.) dimostrò che i Romani avevano imparato dalle sconfitte, adottando tattiche flessibili capaci di battere i Cartaginesi con le loro stesse armi.
La decisione di portare la guerra in Africa costrinse Cartagine a richiamare Annibale dall’Italia. Lo scontro finale di Zama (202 a.C.) vide la vittoria definitiva di Scipione, che utilizzò la cavalleria numida alleata per sconfiggere gli elefanti cartaginesi e travolgere l’esercito di Annibale.
Le trasformazioni sociali ed economiche Le guerre puniche trasformarono profondamente la società romana. L’afflusso di ricchezze dalle conquiste, sotto forma di bottino, tributi e schiavi, creò nuove opportunità economiche ma anche nuovi squilibri sociali. L’aristocrazia senatoria si arricchì enormemente, investendo in terre e attività commerciali attraverso intermediari.
La piccola proprietà contadina, base tradizionale dell’esercito romano, entrò in crisi a causa della prolungata militarizzazione. I piccoli proprietari, impegnati per anni nelle campagne militari, vedevano le loro terre impoverirsi o venire acquistate dai ricchi per formare grandi latifondi lavorati da schiavi.
L’urbanizzazione di Roma accelerò drammaticamente. La popolazione della città crebbe rapidamente, alimentata dall’immigrazione italica e dall’afflusso di schiavi liberati. Nacquero nuovi quartieri, si svilupparono nuove attività artigianali e commerciali, si creò una plebe urbana sempre più numerosa e politicamente influente.
L’evoluzione del sistema militare Il III secolo vide la maturazione definitiva del sistema legionario romano. La legione manipolare, basata su tre linee di combattenti (hastati, principes, triarii) organizzati in manipoli, si dimostrò superiore alla falange macedone per flessibilità e adattabilità al terreno. L’armamento standardizzato (gladio, scutum, pilum) e l’addestramento intensivo creavano un soldato di qualità eccezionale.
Il prolungamento delle campagne militari portò alla progressiva professionalizzazione dell’esercito. I soldati restavano sotto le armi per anni, acquisendo esperienza e coesione ma perdendo il legame con la vita civile. Questo processo preparava le trasformazioni dell’età di Mario e le guerre civili del I secolo.
L’espansione nel Mediterraneo orientale Nella seconda metà del III secolo, Roma iniziò il suo coinvolgimento nella politica del Mediterraneo orientale. Le guerre macedoniche (214-148 a.C.) nascevano formalmente dalla necessità di contrastare l’alleanza tra Filippo V di Macedonia e Annibale, ma riflettevano la nuova dimensione imperiale della politica romana.
La Prima Guerra Macedonica (214-205 a.C.) fu essenzialmente un conflitto secondario rispetto alla guerra annibalica, ma stabilì la presenza romana in Grecia. Roma si alleò con la Lega Etolica e altre città greche, presentandosi come liberatrice dall’oppressione macedone.
Le trasformazioni culturali Il contatto con il mondo greco-ellenistico innescò una rivoluzione culturale a Roma. L’arrivo di prigionieri di guerra colti, maestri greci, opere d’arte e libri trasformò i gusti e gli interessi dell’aristocrazia romana. Iniziò quel processo di “grecizzazione” della cultura romana che Orazio avrebbe sintetizzato nel celebre verso “Graecia capta ferum victorem cepit”.
La letteratura romana nacque proprio nel III secolo con Livio Andronico, che tradusse l’Odissea in latino e scrisse le prime tragedie romane. Nevio creò l’epica nazionale con il Bellum Poenicum, mentre Plauto iniziò la grande tradizione comica romana. Quinto Ennio, verso la fine del secolo, scrisse gli Annales, il primo grande poema epico originalmente romano.
L’evoluzione delle istituzioni Le sfide del III secolo provocarono adattamenti significativi nelle istituzioni repubblicane. Il Senato rafforzò la propria autorità, diventando di fatto l’organo direttivo della politica estera e militare. La gestione delle province creò nuove magistrature (preture) e prolungò i comandi (prorogatio imperii), anticipando i problemi del I secolo.
Il sistema giuridico si evolse per affrontare i rapporti con stranieri e popoli sottomessi. Nacque lo ius gentium, diritto internazionale che regolava i rapporti tra popoli diversi, mentre il pretore peregrino amministrava la giustizia tra cittadini romani e stranieri.
La religione e l’identità romana Le guerre puniche influenzarono profondamente la religiosità romana. L’introduzione di culti orientali (Cibele nel 204 a.C.) rispondeva alle necessità psicologiche di una società sotto stress, mentre la consultazione sempre più frequente dei Libri Sibillini dimostrava la ricerca di sostegno divino nelle crisi.
Contemporaneamente si rafforzò l’ideologia della missione romana. La vittoria su Annibale fu interpretata come segno del favore divino e della superiorità morale romana. Nacque la concezione della “guerra giusta” (bellum iustum) che avrebbe giustificato le future conquiste.
Conclusione: Roma alla fine del III secolo Al termine del III secolo a.C., Roma si presentava completamente trasformata rispetto ai suoi inizi. Da città-stato italica era divenuta la potenza egemone del Mediterraneo occidentale, con domini che si estendevano dalla Spagna alla Grecia, dall’Africa settentrionale alle Alpi.
Le istituzioni repubblicane avevano dimostrato straordinaria capacità di adattamento, ma già emergevano le tensioni che avrebbero caratterizzato il secolo successivo. La società romana era più ricca e complessa, ma anche più stratificata e conflittuale. L’esercito era più efficiente e professionale, ma sempre meno legato ai valori civici tradizionali.
Il III secolo a.C. rimane il secolo cruciale della storia romana, quello che determinò il destino di Roma come potenza mondiale e pose le basi per la creazione di quell’impero che avrebbe dominato il Mediterraneo per i successivi sei secoli. Le sfide affrontate e superate in questo periodo formarono il carattere nazionale romano e crearono il mito della invincibilità che avrebbe accompagnato Roma fino alla fine dell’Impero.
🎤🎧 Audio Lezioni, ascolta il podcast di Storia Romana del prof. Gaudio
Ascolta “Storia Romana” su Spreaker.