
Biografia di Eugenio Montale
28 Dicembre 2019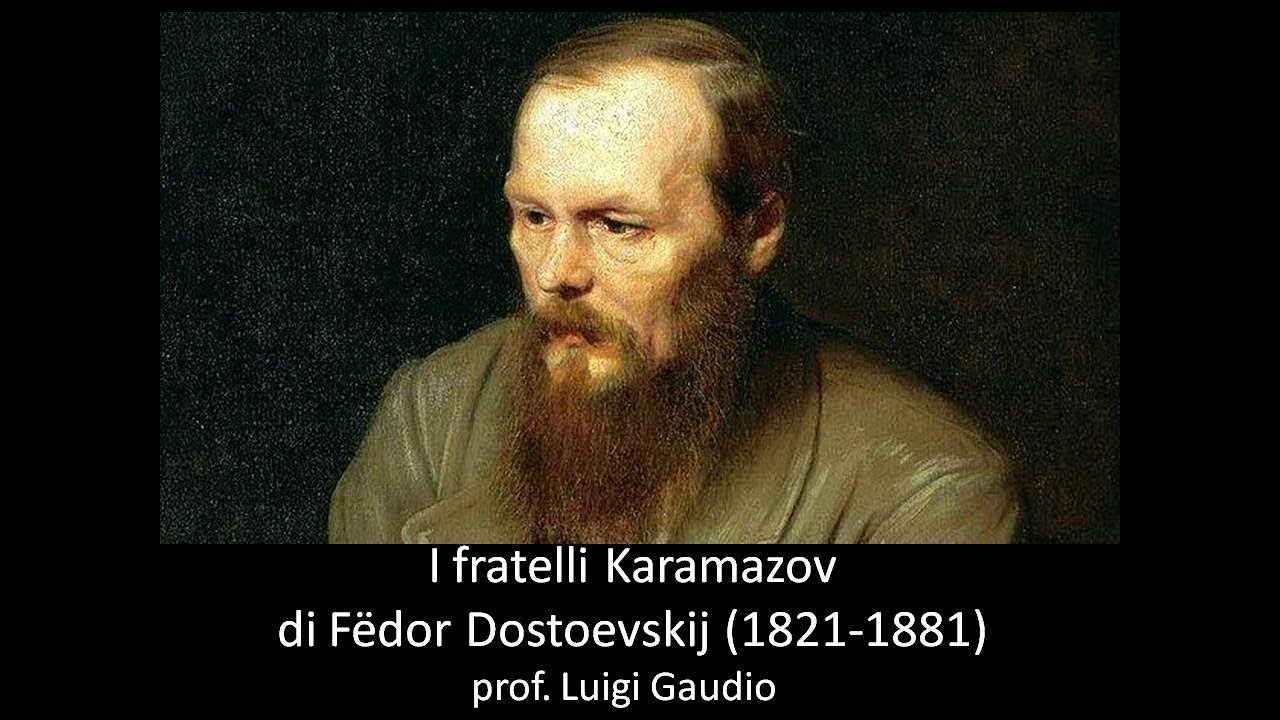
I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij
28 Dicembre 2019Testo e analisi della poesia Il tramonto della luna di Giacomo Leopardi
Testo di Giacomo Leopardi – Canti (1831) XXXIII – Il tramonto della luna
Il tramonto della luna
Quale in notte solinga,
sovra campagne inargentate ed acque,
lá ’ve zefiro aleggia,
e mille vaghi aspetti
e ingannevoli obbietti 5
fingon l’ombre lontane
infra l’onde tranquille
e rami e siepi e collinette e ville;
giunta al confin del cielo,
dietro Apennino od Alpe, o del Tirreno 10
nell’infinito seno
scende la luna; e si scolora il mondo;
spariscon l’ombre, ed una
oscuritá la valle e il monte imbruna;
orba la notte resta, 15
e cantando, con mesta melodia,
l’estremo albor della fuggente luce,
che dianzi gli fu duce,
saluta il carrettier dalla sua via;
tal si dilegua, e tale 20
lascia l’etá mortale
la giovinezza. In fuga
van l’ombre e le sembianze
dei dilettosi inganni; e vengon meno
le lontane speranze, 25
ove s’appoggia la mortal natura.
Abbandonata, oscura
resta la vita. In lei porgendo il guardo,
cerca il confuso viatore invano
del cammin lungo che avanzar si sente 30
meta o ragione; e vede
ch’a sé l’umana sede,
esso a lei veramente è fatto estrano.
Troppo felice e lieta
nostra misera sorte 35
parve lassú, se il giovanile stato,
dove ogni ben di mille pene è frutto
durasse tutto della vita il corso.
Troppo mite decreto
quel che sentenzia ogni animale a morte, 40
s’anco mezza la via
lor non si desse in pria,
della terribil morte assai piú dura.
D’intelletti immortali
degno trovato, estremo 45
di tutti i mali, ritrovâr gli eterni
la vecchiezza, ove fosse
incolume il desio, la speme estinta,
secche le fonti del piacer, le pene
maggiori sempre, e non piú dato il bene. 50
Voi, collinette e piagge,
caduto lo splendor che all’occidente
inargentava della notte il velo,
orfane ancor gran tempo
non resterete, che dall’altra parte 55
tosto vedrete il cielo
imbiancar nuovamente, e sorger l’alba:
alla qual poscia seguitando il sole,
e folgorando intorno
con sue fiamme possenti, 60
di lucidi torrenti
inonderá con voi gli eterei campi.
Ma la vita immortal, poi che la bella
giovinezza sparí, non si colora
d’altra luce giammai, né d’altra aurora. 65
Vedova è insino al fine; ed alla notte
che l’altre etadi oscura,
segno poser gli dèi la sepoltura.

Analisi de “Il tramonto della luna”
“Il tramonto della luna” (1831) è uno degli ultimi Canti di Giacomo Leopardi e si colloca cronologicamente dopo “La Ginestra”, ma viene tradizionalmente inserito prima per motivi tematici, costituendo un addio malinconico alla speranza e alla giovinezza. Il componimento sviluppa una lunga similitudine tra il fenomeno naturale del tramonto lunare e il declino della vita umana, in particolare il sopraggiungere della vecchiaia.
Struttura e Temi Principali
Il Canto è diviso in quattro strofe, ciascuna con un preciso sviluppo logico e tematico:
- Prima Stanza (vv. 1-19): Il Tramonto della Luna. La poesia si apre con una descrizione evocativa e suggestiva del tramonto della luna in una notte solitaria. La luna “inargentata” (v. 2) crea un paesaggio suggestivo, in cui le ombre generano “mille vaghi aspetti e ingannevoli obbietti” (vv. 4-5). Questo mondo di illusioni ottiche, tipico dell’esperienza giovanile, svanisce con lo scendere della luna dietro le montagne o nel mare. La progressiva scomparsa della luce è accompagnata dall’imbrunire del mondo (“si scolora il mondo”, v. 12; “la valle e il monte imbruna”, v. 14). La notte resta “orba” (v. 15), privata della sua guida. Il canto malinconico del carrettiere, che saluta l’ultimo barlume della luce, simboleggia la consapevolezza della perdita e l’ineluttabilità del passaggio. Questa prima parte stabilisce il terreno metaforico del componimento: la luna è la giovinezza, il paesaggio illuminato sono le illusioni e le speranze, la loro scomparsa è il declino.
- Seconda Stanza (vv. 20-33): Il Tramonto della Giovinezza Umana. La seconda strofa è il tertium comparationis, dove la similitudine viene esplicitata: “tal si dilegua, e tale / lascia l’etá mortale / la giovinezza” (vv. 20-22). Le “ombre e le sembianze dei dilettosi inganni” (vv. 23-24), ovvero le illusioni giovanili (amore, gloria, felicità), svaniscono. Le “lontane speranze” (v. 25), su cui si fonda la natura umana per sopportare la vita, vengono meno. La vita, senza queste illusioni, resta “Abbandonata, oscura” (vv. 27-28). L’uomo, il “confuso viatore” (v. 29) sul “cammin lungo”, cerca invano “meta o ragione” (v. 31), perché la vecchiaia lo rende estraneo alla propria stessa esistenza e al mondo (“ch’a sé l’umana sede, / esso a lei veramente è fatto estrano”, vv. 32-33). Questo riflette la visione leopardiana del progressivo disinganno e della perdita di significato nella vita adulta e nella vecchiaia.
- Terza Stanza (vv. 34-50): La Crudele Invención della Vecchiaia. Questa strofa è una delle più amare e pessimistiche. Leopardi argomenta con sarcasmo che la condizione umana sarebbe stata “Troppo felice e lieta” (v. 34) se la giovinezza, pur “frutto di mille pene” (v. 37), durasse per sempre. Ma la natura, o il Fato, ha riservato agli esseri viventi un “decreto” ancora più crudele della morte stessa: la vecchiezza. Definita “D’intelletti immortali / degno trovato, estremo / di tutti i mali” (vv. 44-46), la vecchiaia è il peggiore dei mali perché comporta la sopravvivenza del desiderio (“incolume il desio”, v. 47) a fronte della speranza estinta (“la speme estinta”, v. 48), delle “fonti del piacer” (v. 49) inaridite, delle pene sempre maggiori e dell’assenza di bene. È un’esistenza di pura sofferenza, senza la possibilità di godimento o la spinta vitale.
- Quarta Stanza (vv. 51-68): Il Contrasto tra Natura e Uomo. L’ultima strofa riprende la similitudine iniziale, ma con una differenza fondamentale e dolorosa. Le “collinette e piagge” (v. 51), pur private della luce lunare, non resteranno “orfane” (v. 54) a lungo: presto vedranno sorgere una nuova alba e poi il sole, inondando “con voi gli eterei campi” (v. 62) di luce. La Natura, nel suo ciclo eterno, ritrova sempre la luce e la bellezza. Ma non così per l’uomo: “Ma la vita immortal, poi che la bella / giovinezza sparí, non si colora / d’altra luce giammai, né d’altra aurora” (vv. 63-65). La vita umana, una volta persa la giovinezza, non riceve più alcuna luce o speranza. Resta “Vedova” (v. 66) fino alla fine, e il “segno” posto dagli dèi alla “notte che l’altre etadi oscura” (vv. 66-67) è la sepoltura. La morte è l’unica vera liberazione da una vecchiaia intesa come lunga agonia.
Aspetti Stilistici
- Similitudine estesa: L’intero Canto è costruito su una grandiosa similitudine che domina le strofe, creando un parallelismo costante tra il fenomeno naturale e la condizione umana.
- Linguaggio e Lessico: Leopardi usa un linguaggio sublime e ricercato (“inargentate”, “ingannevoli obbietti”, “albor”, “dilettosi inganni”), ma anche termini più diretti per esprimere il dolore (“orba”, “oscura”, “estrano”, “misera”, “terribil morte”). L’uso di aggettivi evocativi contribuisce a creare atmosfere malinconiche e contemplative.
- Musica e Ritmo: La melodia del Canto è data dalla sapiente alternanza di endecasillabi e settenari, con rime libere e assonanze che conferiscono fluidità e un tono elegiaco. Il ritmo si adatta al contenuto, rallentando nei momenti di malinconia e accelerando nella descrizione degli assalti della vecchiaia.
- Contrasti: Il componimento è ricco di contrasti: luce/ombra, giovinezza/vecchiaia, speranza/disinganno, ciclo eterno della natura/linearità della vita umana.
Significato Generale
“Il tramonto della luna” è uno dei Canti più emblematici del pessimismo cosmico leopardiano. La Natura non è più madre benevola (come in parte nei primi Canti), ma una forza indifferente o addirittura crudele, che ha predisposto per l’uomo una sorte peggiore della morte stessa: la vecchiaia, un periodo di progressivo svuotamento e sofferenza, privo delle illusioni giovanili che rendevano la vita sopportabile. L’unico sollievo è la sepoltura, che mette fine a questa lunga e dolorosa “notte”. Il Canto esprime una disillusione profonda e un’amara accettazione della condizione umana.
Questo Canto, con la sua bellezza formale e la sua profondità filosofica, offre uno sguardo toccante sull’esperienza umana del tempo e della perdita.




