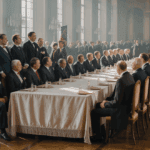
La Conferenza di Pace di Genova del 1922
10 Giugno 2025
Perché insegnare la storia dell’arte
11 Giugno 2025Traccia e svolgimento di un tema argomentativo sulla potenza inarrestabile e preoccupante dell’opinione
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – PROVA DI ITALIANO – Sessione Straordinaria 2022
TRACCIA
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B
PROPOSTA B2
Testo tratto da: Giuseppe De Rita, Corriere della Sera, 29 marzo 2022, p. 26.
La potenza dell’opinione, inarrestabile e preoccupante
Dicevano i nostri vecchi che «la matematica non è un’opinione», sicuri che le verità indiscutibili non possono essere scalfite da ondeggianti valutazioni personali, spesso dovute a emozioni interne e collettive.
Temo che quella sicurezza non abbia più spazio nell’attuale dinamica culturale. Se qualcuno si esponesse a dire che due più due fa quattro, si troverebbe subito di fronte qualcun altro che direbbe «questo lo dice lei», quasi insinuando il dubbio che non si tratta di una verità, ma di una personale opinione. Vige ormai da tempo qui da noi la regola «uno vale uno». Non ci sono verità che non possano essere messe in dubbio: tu la pensi così, ma io la penso al contrario e pari siamo. Non ci sono santi, dogmi, decreti, ricerche di laboratorio, tabelle statistiche; vale e resta dominante il primato dell’opinione personale.
Siamo così diventati un popolo prigioniero dell’opinionismo […]. Basta comprare al mattino un quotidiano e si rimane colpiti da prime pagine piene di riferimenti che annunciano tanti articoli interni, quasi tutti rigorosamente legati a fatti d’opinione, a personaggi d’opinione, a polemiche d’opinione, in un inarrestabile primato dell’Opinione regina mundi. […]
Non ci rendiamo però conto che restiamo tutti prigionieri di livelli culturali bassi, inchiodati alle proprie opinioni, refrattari a livelli più alti di conoscenza, restii all’approfondimento, al confronto, alla dialettica. Non interessa la dimensione scientifica di una malattia, vale l’onda d’opinione che su quella malattia si è formata o si può formare; non interessa la dimensione complessa di un testo di legge o di una sentenza, vale l’onda d’opinione che si forma su di esse; non interessa la incontrovertibilità di un dato economico o di una tabella statistica, vale l’onda d’opinione che ci si può costruire sopra; non interessa la lucidità di una linea di governo del sistema, vale lo scontro di opinioni […] che su di essa si scatena. Ma senza confronto e senza dialettica non si fa cultura, non si fa sintesi politica, non si fa governo delle cose; con l’effetto finale che nel segreto del dominio dell’opinione si attua una trasfigurazione in basso e banale della realtà.
Viene addirittura il sospetto che si sia in presenza di un uso primordiale ma sofisticato dell’opinione; e non si sa chi e come la gestisce.
[…] Non c’è dato comunque di sapere (visto che pochi lo studiano) dove potrebbe portarci la progressiva potenza dell’Opinione […]. Converrà però cominciare a pensarci sopra, magari partendo dal preoccuparci che la nostra comunicazione di massa si ingolfa troppo nell’opinionismo autoalimentato e senza controllo.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.
- Esponi in sintesi il contenuto del testo, evidenziandone i punti-chiave.
- Definisci il concetto di «opinionismo» così come emerge dal testo.
- L’autore allude ai valori dell’«approfondimento», del «confronto», della «dialettica»: chiarisci in che modo questi fattori possono contribuire al raggiungimento di «livelli più alti di conoscenza».
- Illustra quali sono le preoccupazioni dell’autore rispetto alla “progressiva potenza dell’Opinione”.
Produzione
Il testo richiede una riflessione sul diritto alla libertà di pensiero e sul diritto di nutrire dubbi. Tenendo presenti questi singoli aspetti e le diverse onde di opinione elencate dall’autore, prendi posizione sull’affermazione «… senza confronto e senza dialettica non si fa cultura, non si fa sintesi politica, non si fa governo delle cose» e, in particolare, sul pericolo che «nel segreto del dominio dell’opinione si attua una trasfigurazione in basso e banale della realtà».
Elabora un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

SVOLGIMENTO del tema argomentativo
Analisi dell’articolo “La potenza dell’opinione, inarrestabile e preoccupante” di Giuseppe De Rita
L’articolo di Giuseppe De Rita sul “Corriere della Sera” si configura come un’allarmata e lucida critica alla preminenza dell’opinione personale nella cultura contemporanea, fenomeno che l’autore definisce “opinionismo”. De Rita denuncia una perdita di valore della verità oggettiva e del dato di fatto, a favore di valutazioni soggettive che, a suo avviso, ostacolano il progresso culturale, la sintesi politica e la capacità di governare la realtà.
Comprensione e Analisi
1. Esponi in sintesi il contenuto del testo, evidenziandone i punti-chiave.
Giuseppe De Rita lamenta la perdita di un tempo in cui le verità indiscutibili, come quelle matematiche, erano al riparo dalle valutazioni personali. Oggi, al contrario, prevale la logica del “uno vale uno”, secondo cui ogni opinione personale ha la stessa validità di un dato oggettivo o di una verità scientifica. Questa tendenza, definita “opinionismo”, porta a un dominio inarrestabile dell’Opinione, che l’autore vede trionfare anche sulle prime pagine dei quotidiani. La conseguenza più preoccupante di questo fenomeno è il mantenimento di “livelli culturali bassi”, caratterizzati dalla refrattarietà all’approfondimento, al confronto e alla dialettica. De Rita osserva che per i problemi complessi (malattie, leggi, dati economici, linee di governo) si preferisce l’onda d’opinione alla dimensione scientifica o all’incontrovertibilità dei dati, il che impedisce la formazione di cultura, la sintesi politica e il governo efficace delle cose, traducendosi in una “trasfigurazione in basso e banale della realtà”. L’autore esprime il sospetto che questo sia un “uso primordiale ma sofisticato” dell’opinione, gestito da poteri sconosciuti, e invita a riflettere sulla “progressiva potenza dell’Opinione” e sulla tendenza della comunicazione di massa a ingolfarsi nell’opinionismo autoalimentato.
I punti-chiave sono:
- Declino della verità oggettiva: La matematica non è più l’unica certezza, ogni affermazione è soggetta a “questo lo dice lei”.
- Primato dell’opinione personale (“uno vale uno”): La convinzione che ogni opinione abbia pari valore, indipendentemente dalla sua fondatezza.
- Fenomeno dell’opinionismo: La sua pervasività nella comunicazione di massa (quotidiani, polemiche).
- Conseguenze negative:
- Abbassamento del livello culturale.
- Rifiuto dell’approfondimento, del confronto, della dialettica.
- Mancanza di cultura, sintesi politica, governo delle cose.
- “Trasfigurazione in basso e banale della realtà”.
- Sospetto di manipolazione: L’opinionismo come strumento sofisticato gestito da forze ignote.
- Appello alla riflessione: L’urgenza di considerare i pericoli di una comunicazione dominata dall’opinionismo senza controllo.
2. Definisci il concetto di «opinionismo» così come emerge dal testo.
Il concetto di “opinionismo”, così come emerge dal testo di Giuseppe De Rita, descrive una deriva culturale e sociale in cui il primato assoluto è assegnato all’opinione personale, a discapito della verità oggettiva, dei dati di fatto e del sapere fondato. È la convinzione che “uno vale uno”, nel senso che ogni individuo, indipendentemente dalle proprie competenze o dalla fondatezza delle proprie argomentazioni, detiene un’opinione che ha pari dignità e valore di qualsiasi altra, anche di quelle basate su ricerca scientifica, dati statistici o analisi esperte.
L’opinionismo si manifesta come una tendenza:
- Alla refrattarietà al confronto e alla dialettica: Non si è interessati a mettere in discussione le proprie convinzioni o ad approfondire, poiché la propria opinione è ritenuta sufficiente e incontrovertibile per il solo fatto di essere propria.
- Alla superficialità: La complessità di una malattia, di una legge o di un dato economico viene ignorata, perché l’attenzione è focalizzata sull'”onda d’opinione” che si può creare su di essi, spesso attraverso polemiche e semplificazioni.
- Alla banalizzazione della realtà: Tutto viene ricondotto a uno scontro di opinioni, trasfigurando la realtà in modo “in basso e banale”, distorcendone la complessità e la profondità.
- Alla pervasività mediatica: I quotidiani e la comunicazione di massa sono “pieni di riferimenti… legati a fatti d’opinione, a personaggi d’opinione, a polemiche d’opinione”, rendendo l’Opinione la “regina mundi”.
In sintesi, l’opinionismo è la patologia di una società in cui la soggettività e la percezione individuale prevalgono sul metodo scientifico, sul rigore dell’analisi e sulla necessità di una discussione basata sui fatti, con conseguenze dannose per la cultura, la politica e la gestione della realtà.
3. L’autore allude ai valori dell’«approfondimento», del «confronto», della «dialettica»: chiarisci in che modo questi fattori possono contribuire al raggiungimento di «livelli più alti di conoscenza».
I valori dell’«approfondimento», del «confronto» e della «dialettica» sono presentati da De Rita come gli antidoti all’opinionismo e le vie maestre per il raggiungimento di «livelli più alti di conoscenza».
-
Approfondimento: Contribuisce a raggiungere livelli più alti di conoscenza perché implica la ricerca della complessità e della verità oltre la superficie. Significa non accontentarsi di un’informazione sommaria o di una prima impressione, ma scavare, studiare, analizzare i dati, le fonti, le diverse prospettive. È la consapevolezza che la “dimensione scientifica di una malattia” o la “dimensione complessa di un testo di legge” richiedono uno sforzo intellettuale per essere comprese a fondo, superando l’onda d’opinione effimera. L’approfondimento è il rifiuto della banalità e della semplificazione eccessiva.
-
Confronto: Permette di raggiungere livelli più alti di conoscenza perché costringe a mettere in discussione le proprie certezze e a riconoscere i propri limiti. Bonazzi, in un altro articolo (“Saper dialogare è vitale”), dice che “non c’è conoscenza fino a che il nostro pensiero non riesce a specchiarsi nel pensiero altrui”. Il confronto espone le proprie idee al vaglio critico degli altri, rivelando i punti deboli delle argomentazioni personali e le lacune nella propria conoscenza. Permette di acquisire nuove prospettive e di vedere aspetti che da soli non si erano considerati.
-
Dialettica: È la sintesi superiore che nasce dall’approfondimento e dal confronto. La dialettica è il processo di superamento delle contraddizioni e delle posizioni opposte attraverso un dibattito razionale e argomentato, che mira a una comprensione più completa e a una soluzione condivisa. Non è uno scontro per affermare la propria opinione, ma un percorso per costruire una sintesi che incorpora le diverse sfumature della realtà. Nel testo, l’autore lamenta che “senza confronto e senza dialettica non si fa cultura, non si fa sintesi politica, non si fa governo delle cose”, indicando che la dialettica è essenziale per la costruzione collettiva di sapere e decisioni efficaci.
Insieme, questi tre fattori permettono di superare la “conoscenza illusoria perché parziale, limitata” prodotta dall’opinionismo, elevando il dibattito dal piano del “io la penso così, tu la pensi al contrario e pari siamo” a quello di una ricerca collettiva della verità e della soluzione migliore per il bene comune.
4. Illustra quali sono le preoccupazioni dell’autore rispetto alla “progressiva potenza dell’Opinione”.
Le preoccupazioni dell’autore rispetto alla “progressiva potenza dell’Opinione” sono profonde e investono diversi ambiti della vita sociale e democratica:
- Abbassa i livelli culturali: Il dominio dell’opinione personale porta a una generale refrattarietà all’approfondimento e alla complessità, inchiodando le persone a “livelli culturali bassi” e impedendo una vera acquisizione di conoscenza.
- Impedisce la cultura e la sintesi politica: Se tutto si riduce a opinioni paritetiche e non si ammette il confronto e la dialettica, non si può costruire vera cultura (intesa come sapere condiviso e critico), né raggiungere quella “sintesi politica” necessaria per decisioni efficaci.
- Compromette il “governo delle cose”: L’autore teme che l’opinionismo impedisca una “lucidità di una linea di governo del sistema” e che le decisioni siano influenzate più dallo “scontro di opinioni” che da dati incontrovertibili o da analisi complesse. Questo rende difficile affrontare problemi reali con soluzioni basate sull’evidenza.
- Trasfigura la realtà in modo “in basso e banale”: La preoccupazione più inquietante è che il dominio dell’opinione, nel suo “segreto”, porti a una distorsione della realtà, rendendola più semplice, più banale, più superficiale di quanto non sia. Ciò che è complesso viene ridotto a uno scontro di narrazioni.
- Sospetto di manipolazione: De Rita esprime un forte sospetto che la “progressiva potenza dell’Opinione” non sia un fenomeno spontaneo, ma un “uso primordiale ma sofisticato dell’opinione”, e si chiede “non si sa chi e come la gestisce”. Questa è la preoccupazione che l’opinionismo possa essere uno strumento di controllo e manipolazione da parte di poteri occulti o non identificati, che beneficiano della confusione e della mancanza di discernimento.
- Futuro incerto e pericoloso: L’autore conclude con un senso di allarme, sottolineando che “non c’è dato comunque di sapere (visto che pochi lo studiano) dove potrebbe portarci la progressiva potenza dell’Opinione”, invitando a “cominciare a pensarci sopra” e a preoccuparsi della comunicazione di massa che “si ingolfa troppo nell’opinionismo autoalimentato e senza controllo”.
In sintesi, De Rita teme che il primato dell’opinione personale stia erodendo le basi razionali e culturali della società, rendendola più vulnerabile alla manipolazione e meno capace di affrontare le proprie sfide con lucidità e coesione.
Produzione
Il Trionfo dell’Opinione: Un Pericolo per la Conoscenza e la Democrazia
L’articolo di Giuseppe De Rita mette in luce un aspetto cruciale e preoccupante della società contemporanea: l’inarrestabile ascesa del primato dell’opinione personale, che egli definisce “opinionismo”. La sua affermazione che “senza confronto e senza dialettica non si fa cultura, non si fa sintesi politica, non si fa governo delle cose” e il pericolo che “nel segreto del dominio dell’opinione si attua una trasfigurazione in basso e banale della realtà” sono, a mio parere, un’analisi lucida e purtroppo veritiera delle derive del nostro tempo. Pur riconoscendo il valore inestimabile della libertà di pensiero e il diritto di nutrire dubbi, è fondamentale distinguere questi principi cardine della democrazia da una deriva che equipara ogni opinione, ignorando la necessità di fondarla su dati, fatti e un rigoroso processo di confronto.
Il diritto alla libertà di pensiero e il diritto al dubbio sono pilastri di ogni società democratica e libera. Permettono la ricerca della verità, l’innovazione, la critica al potere e la diversità di visioni. Senza il dubbio, la conoscenza ristagna e si trasforma in dogma. Senza la libertà di pensiero, la società si conforma e perde la sua vitalità. Tuttavia, come ogni diritto, anche questi devono essere esercitati con responsabilità e consapevolezza. Il problema nasce quando la libertà di esprimere un’opinione si trasforma nella pretesa che tale opinione abbia lo stesso peso di una verità scientificamente provata o di un dato incontrovertibile, solo perché “io la penso così”. Questo è il cuore dell’opinionismo di cui parla De Rita, e le sue conseguenze sono gravi.
Innanzitutto, il dominio dell’opinione mina le basi della cultura e della conoscenza. Se il principio “uno vale uno” viene applicato senza discernimento, si erode la fiducia nell’expertise, nella ricerca scientifica, nel metodo. Non interessa più la “dimensione scientifica di una malattia” o la “incontrovertibilità di un dato economico”; ciò che conta è l'”onda d’opinione” che si crea. Questo porta a una pervasiva superficialità: si preferisce una notizia sensazionalistica e parziale a un approfondimento complesso, un titolo accattivante a un’analisi articolata. Sui social media, la mia esperienza quotidiana mi mostra come spesso prevalga la logica dell’algoritmo, che amplifica le voci più estreme e le narrazioni più semplici, creando “bolle” di consenso in cui le proprie opinioni vengono costantemente rinforzate, senza esposizione a visioni diverse. Questo ambiente è fertile per la “trasfigurazione in basso e banale della realtà”: concetti complessi vengono ridotti a slogan, i fatti a mere opinioni, e la disinformazione prolifera, rendendo sempre più difficile discernere il vero dal falso.
In secondo luogo, l’opinionismo ha un impatto devastante sulla sintesi politica e sul governo delle cose. La politica, per sua natura, richiede la capacità di mediare, di negoziare, di trovare soluzioni condivise a problemi complessi. Se ogni parte si arrocca dietro la propria opinione, considerandola inattaccabile, il confronto si trasforma in scontro sterile e la dialettica muore. “Non interessa la lucidità di una linea di governo del sistema, vale lo scontro di opinioni”. Questo paralizza il processo decisionale, impedendo l’attuazione di politiche efficaci, specialmente quelle che richiedono sacrifici o visioni a lungo termine (si pensi, ad esempio, alla gestione della crisi climatica o alle riforme strutturali). La politica diventa allora un palcoscenico per polemiche e affermazioni personalistiche, piuttosto che un luogo di costruzione di consenso e di azione concreta. Ho osservato nei dibattiti pubblici come la complessità di un problema venga spesso appiattita per renderla più appetibile al consumo dell’opinione, sacrificando la nuance e il rigore a favore della battuta a effetto.
La preoccupazione di De Rita per la “progressiva potenza dell’Opinione”, e il sospetto che sia un “uso primordiale ma sofisticato” gestito da forze ignote, è particolarmente inquietante. In un mondo dove l’informazione è potere, la manipolazione dell’opinione pubblica attraverso la semplificazione, la disinformazione o la creazione di narrazioni polarizzanti, è un rischio concreto. L’anonimato della rete e la velocità di diffusione dei contenuti facilitano questa manipolazione, rendendo difficile risalire all’origine e alle intenzioni di certe “onde d’opinione”.
In conclusione, la riflessione di De Rita è un monito cruciale. Il diritto alla libertà di pensiero e al dubbio è irrinunciabile, ma esso è efficace solo se accompagnato dalla responsabilità intellettuale e dalla volontà di confrontarsi con la realtà e con le altre prospettive in modo costruttivo. Senza l’approfondimento, il confronto e la dialettica, non solo non si può fare cultura, sintesi politica o governo delle cose, ma si rischia di cadere in una “trasfigurazione in basso e banale della realtà”, dove la verità è un optional e la manipolazione un pericolo costante. È imperativo, per la salute della nostra democrazia e per la qualità della nostra conoscenza, riaffermare il valore del rigore intellettuale, della complessità e del dialogo, per non diventare un “popolo prigioniero dell’opinionismo” autoalimentato e senza controllo.





