Brani tradotti dal Satyricon di Petronio
28 Dicembre 2019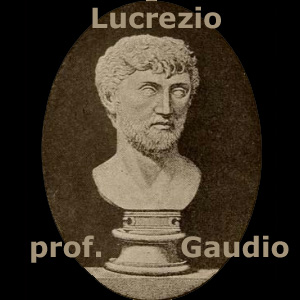
La passione d’amore dal De rerum natura di Lucrezio, IV, 1141-1159
28 Dicembre 2019Introduzione al Brano La Passione d’Amore dal De Rerum Natura di Lucrezio, Libro Quarto
Il De Rerum Natura (“Sulla Natura delle Cose”) di Tito Lucrezio Caro è uno dei capolavori della letteratura latina e una delle più importanti opere filosofiche antiche. Composto in sei libri in esametri, questo poema didascalico si propone di esporre in versi la complessa filosofia di Epicuro, con l’obiettivo ultimo di liberare gli uomini dalla paura degli dèi, della morte e del dolore, per condurli alla serenità dell’anima (atarassia) e all’assenza di dolore fisico (aponia).
1. Il Contesto del Libro Quarto: Sensi, Mente e Illusioni
Il Libro Quarto del De Rerum Natura è dedicato allo studio dei sensi e della conoscenza. Lucrezio spiega come percepiamo il mondo esterno attraverso i “simulacra” o “immagini” (eidola in greco), cioè sottilissime pellicole di atomi che si staccano dagli oggetti e colpiscono i nostri organi di senso. In questo contesto, il poeta analizza fenomeni come la visione, l’udito, il gusto e l’olfatto, ma anche i sogni e, in modo cruciale per il nostro brano, la passione amorosa.
La discussione sull’amore non è una digressione romantica, ma una coerente prosecuzione dell’analisi delle percezioni e delle illusioni mentali. Per Lucrezio, l’amore passionale è, infatti, una delle più grandi illusioni che turbano la serenità dell’anima, una vera e propria “malattia” che impedisce il raggiungimento della felicità epicurea.
2. La Visione Epicurea dell’Amore: Un Pericolo per l’Atarassia
La filosofia di Epicuro, che Lucrezio segue fedelmente, pone al centro della vita umana la ricerca del piacere, inteso però non come sfrenata ricerca dei godimenti sensuali, ma come assenza di dolore fisico e di turbamento dell’anima. Per raggiungere questo stato di atarassia, è fondamentale evitare tutte le passioni che, per la loro natura intrinsecamente eccessiva e incontrollabile, generano ansia, inquietudine e sofferenza.
L’amore passionale, o furor amoris (follia d’amore), rientra proprio in questa categoria di piaceri da cui guardarsi con attenzione. Lucrezio lo considera un’ossessione che lega l’individuo a un oggetto esterno, rendendolo schiavo del desiderio e della gelosia, e distogliendolo dalla vera felicità. L’amore non porta appagamento duraturo, ma un ciclo vizioso di desiderio, illusione e frustrazione.
- L’Illusione Sensuale: L’amore nasce da un’illusione dei sensi, da un’immagine che colpisce la mente e genera desiderio. Ma questo desiderio, se non controllato, degenera in una bitta incessante di infelicità.
- La Negazione della Razionalità: La passione offusca la ragione, impedendo all’amante di vedere la realtà oggettiva e di agire in modo equilibrato. L’individuo accecato dal desiderio non riesce a riconoscere i difetti della persona amata e si abbandona a comportamenti irrazionali e autodistruttivi.
- La Dipendenza e la Sofferenza: L’amante diventa dipendente dalla persona amata, sacrificando la propria libertà, il proprio tempo, le proprie risorse e persino la propria dignità, solo per ottenere un piacere effimero che porta con sé una coda di amarezza e rimpianto.
3. Lo Scopo Didattico e la “Terapia” Lucreziana
L’analisi dell’amore nel De Rerum Natura non è fine a se stessa, ma ha un chiaro scopo didattico e terapeutico. Lucrezio non si limita a descrivere i mali dell’amore, ma offre anche una cura o una via di salvezza per chi ne è afflitto. Questa “terapia” si basa sulla:
- Conoscenza Razionale: Comprendere le cause atomistiche e naturali dell’amore (il meccanismo del “simulacro” e del desiderio) e, di conseguenza, i suoi effetti negativi.
- Disincanto: Smascherare le illusioni che la passione crea, imparando a vedere la persona amata per quello che è realmente, con i suoi difetti fisici e morali. Lucrezio suggerisce di osservare l’amata in momenti non “romantici” per coglierne la normalità, o addirittura la volgarità.
- Prevenzione: La migliore difesa è evitare di cadere nella trappola fin dall’inizio, mantenendo la ragione lucida e non lasciandosi adescare dalle prime attrazioni.
In questo, Lucrezio si distingue da altri poeti latini che hanno cantato l’amore, come Catullo o gli elegiaci, che spesso celebrano la passione in tutte le sue sfumature, comprese quelle dolorose e ossessive, facendone il centro della loro esperienza vitale. Per Lucrezio, invece, l’amore ossessivo è un’aberrazione, un ostacolo al vero benessere, e la sua poesia serve a svelarne la vera natura distruttiva.
4. Temi Annunciati nel Brano e Rilevanza
Il brano in questione (IV, vv. 1121-1159) introduce e sviluppa proprio queste tematiche:
- Lo Sperpero Economico: L’amore porta alla dissipazione del patrimonio in beni di lusso per compiacere l’amante.
- La Perdita di Dignità e Fama: La passione distoglie dagli impegni civili e dalla cura di sé.
- L’Illusione della Bellezza: La capacità dell’amore di far apparire belli anche individui oggettivamente “brutti o deformi”.
- L’Amaro nel Piacere: Il concetto centrale che dalla fonte stessa del piacere sorge sempre qualcosa di amaro (gelosia, sospetto, rimorso).
- La Schiavitù e la Dipendenza: L’amante è succube della persona amata.
- L’Autoinganno: Gli amanti, pur riconoscendo la follia negli altri, non riescono a vedere la propria.
In conclusione, l’analisi dell’amore nel Libro Quarto del De Rerum Natura non è un inno alla passione, ma una severa e lucida diagnosi delle sue illusioni e dei suoi pericoli, offerta al lettore come via per raggiungere la vera pace interiore secondo i dettami della filosofia epicurea. È un esempio emblematico della profonda originalità di Lucrezio, che unisce la profondità del pensiero filosofico alla potenza evocativa della poesia.
Immagine di un busto di Lucrezio, il filosofo-poeta autore del De Rerum Natura.



