
Biografia di Eugenio Montale
28 Dicembre 2019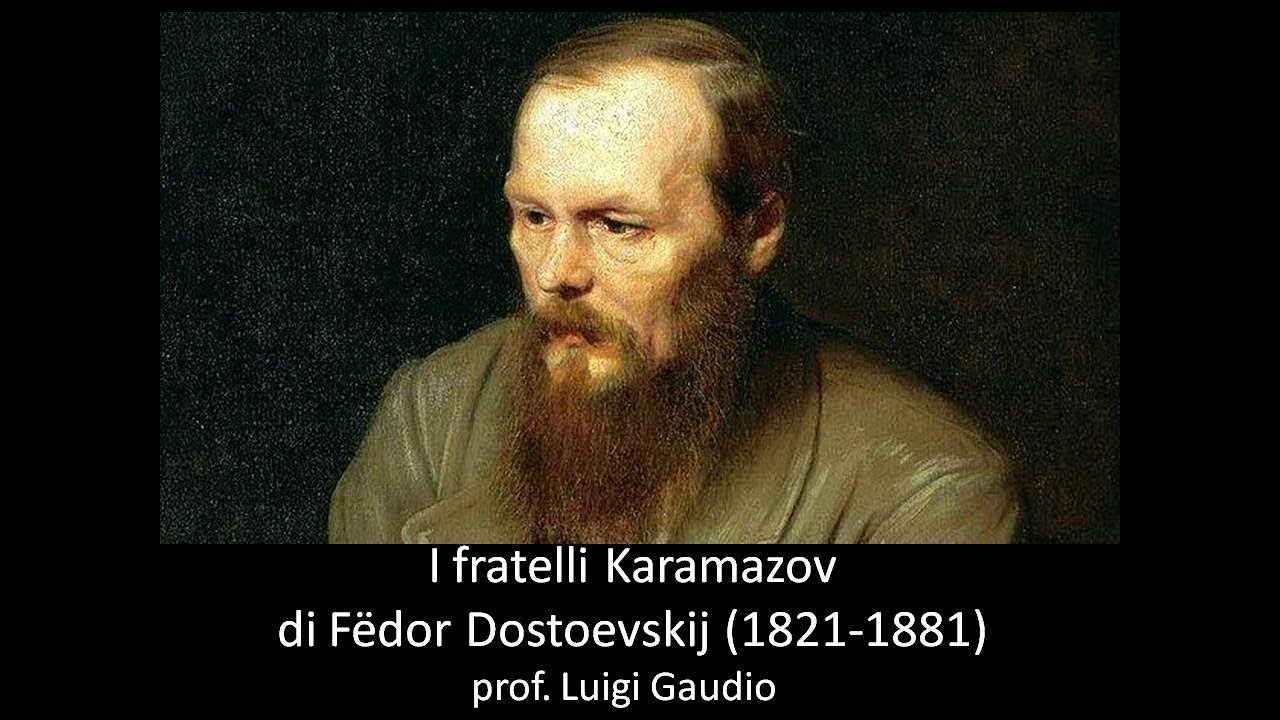
I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij
28 Dicembre 2019Testo, traduzione e analisi del brano del VII libro dell’Eneide, che narra l’arrivo di Enea nel Lazio.

Testo e Traduzione
|
Testo di Virgilio:
Tu quoque litoribus nostris, Aeneia nutrix,
aeternam moriens famam, Caieta, dedisti; et nunc seruat honos sedem tuus, ossaque nomen Hesperia in magna, si qua est ea gloria, signat.At pius exsequiis Aeneas rite solutis, 5 aggere composito tumuli, postquam alta quierunt aequora, tendit iter uelis portumque relinquit. aspirant aurae in noctem nec candida cursus luna negat, splendet tremulo sub lumine pontus. proxima Circaeae raduntur litora terrae, 10 diues inaccessos ubi Solis filia lucos adsiduo resonat cantu, tectisque superbis urit odoratam nocturna in lumina cedrum arguto tenuis percurrens pectine telas. hinc exaudiri gemitus iraeque leonum 15 uincla recusantum et sera sub nocte rudentum, saetigerique sues atque in praesepibus ursi saeuire ac formae magnorum ululare luporum, quos hominum ex facie dea saeua potentibus herbis induerat Circe in uultus ac terga ferarum. 20 quae ne monstra pii paterentur talia Troes delati in portus neu litora dira subirent, Neptunus uentis impleuit uela secundis, atque fugam dedit et praeter uada feruida uexit.Iamque rubescebat radiis mare et aethere ab alto 25 Aurora in roseis fulgebat lutea bigis, cum uenti posuere omnisque repente resedit flatus, et in lento luctantur marmore tonsae. atque hic Aeneas ingentem ex aequore lucum prospicit. hunc inter fluuio Tiberinus amoeno 30 uerticibus rapidis et multa flauus harena in mare prorumpit. uariae circumque supraque adsuetae ripis uolucres et fluminis alueo aethera mulcebant cantu lucoque uolabant. flectere iter sociis terraeque aduertere proras 35 imperat et laetus fluuio succedit opaco.Nunc age, qui reges, Erato, quae tempora, rerum quis Latio antiquo fuerit status, aduena classem cum primum Ausoniis exercitus appulit oris, expediam, et primae reuocabo exordia pugnae. 40 tu uatem, tu, diua, mone. dicam horrida bella, dicam acies actosque animis in funera reges, Tyrrhenamque manum totamque sub arma coactam Hesperiam. maior rerum mihi nascitur ordo, maius opus moueo. 45Rex arua Latinus et urbes iam senior longa placidas in pace regebat. hunc Fauno et nympha genitum Laurente Marica accipimus; Fauno Picus pater, isque parentem te, Saturne, refert, tu sanguinis ultimus auctor. filius huic fato diuum prolesque uirilis 50 nulla fuit, primaque oriens erepta iuuenta est. sola domum et tantas seruabat filia sedes iam matura uiro, iam plenis nubilis annis. multi illam magno e Latio totaque petebant Ausonia; petit ante alios pulcherrimus omnis 55 Turnus, auis atauisque potens, quem regia coniunx adiungi generum miro properabat amore; sed uariis portenta deum terroribus obstant. laurus erat tecti medio in penetralibus altis sacra comam multosque metu seruata per annos, 60 quam pater inuentam, primas cum conderet arces, ipse ferebatur Phoebo sacrasse Latinus, Laurentisque ab ea nomen posuisse colonis. huius apes summum densae (mirabile dictu) stridore ingenti liquidum trans aethera uectae 65 obsedere apicem, et pedibus per mutua nexis examen subitum ramo frondente pependit. continuo uates ‘externum cernimus’ inquit ‘aduentare uirum et partis petere agmen easdem partibus ex isdem et summa dominarier arce.’ 70 praeterea, castis adolet dum altaria taedis, et iuxta genitorem astat Lauinia uirgo, uisa (nefas) longis comprendere crinibus ignem atque omnem ornatum flamma crepitante cremari, regalisque accensa comas, accensa coronam 75 insignem gemmis; tum fumida lumine fuluo inuolui ac totis Volcanum spargere tectis. id uero horrendum ac uisu mirabile ferri: namque fore inlustrem fama fatisque canebant ipsam, sed populo magnum portendere bellum. 80At rex sollicitus monstris oracula Fauni, fatidici genitoris, adit lucosque sub alta consulit Albunea, nemorum quae maxima sacro fonte sonat saeuamque exhalat opaca mephitim. hinc Italae gentes omnisque Oenotria tellus 85 in dubiis responsa petunt; huc dona sacerdos cum tulit et caesarum ouium sub nocte silenti pellibus incubuit stratis somnosque petiuit, multa modis simulacra uidet uolitantia miris et uarias audit uoces fruiturque deorum 90 conloquio atque imis Acheronta adfatur Auernis. hic et tum pater ipse petens responsa Latinus centum lanigeras mactabat rite bidentis, atque harum effultus tergo stratisque iacebat uelleribus: subita ex alto uox reddita luco est: 95 ‘ne pete conubiis natam sociare Latinis, o mea progenies, thalamis neu crede paratis; externi uenient generi, qui sanguine nostrum nomen in astra ferant, quorumque a stirpe nepotes omnia sub pedibus, qua sol utrumque recurrens 100 aspicit Oceanum, uertique regique uidebunt.’ haec responsa patris Fauni monitusque silenti nocte datos non ipse suo premit ore Latinus, sed circum late uolitans iam Fama per urbes Ausonias tulerat, cum Laomedontia pubes 105 gramineo ripae religauit ab aggere classem.
|
Traduzione
1-4 Anche tu, o nutrice di Enea, o Caieta, morendo desti eterna fama alle nostre spiagge; e ora il tuo onore conserva quel luogo, e il tuo nome segna le ossa nella grande Esperia, se ciò è gloria. 5-7 Ma il pio Enea, celebrate secondo il rito le esequie, composto il tumulo di terra, dopo che le acque profonde si furono acquietate, tende il viaggio con le vele e abbandona il porto. 8-9 I venti spirano nella notte e la bianca luna non nega il percorso, il mare risplende sotto la luce tremolante. 10-24 Si costeggiano le vicine spiagge della terra di Circe, dove la figlia del Sole, ricca, fa risuonare di canto continuo i boschi inaccessibili, e nelle superbe dimore brucia odoroso cedro per le luci notturne, percorrendo con il sottile pettine le tele sonore. Di qui si potevano udire i gemiti e le ire di leoni che rifiutavano le catene e ruggivano a tarda notte, e cinghiali setolosi e orsi nelle stalle inferocire e ululare le forme di grandi lupi, che la dea Circe, con potenti erbe, aveva trasformato da volti umani in volti e dorsi di fiere. Affinché i pii Troiani, giunti nei porti, non subissero tali mostri e non approdassero a quelle spiagge funeste, Nettuno gonfiò le vele con venti propizi, e diede loro la fuga e li trasportò oltre i guadi incandescenti. 25-36 E già il mare arrossiva ai raggi e dall’alto cielo l’Aurora fulgeva di giallo sulle sue bighe rosee, quando i venti si placarono e ogni soffio si spense all’improvviso, e i remi lottano sulla lenta superficie marina. E qui Enea scorge dall’acqua un immenso bosco. In mezzo a questo, il Tevere, con le sue rapide correnti e molta sabbia gialla, si getta nel mare in un fiume ameno. Intorno e sopra, uccelli di vario genere, abituati alle rive e all’alveo del fiume, addolcivano l’aria con il canto e volavano nel bosco. Enea ordina ai compagni di cambiare rotta e di dirigere le prore verso terra e, lieto, risale il fiume ombroso. 37-45 Ora, o Erato, dimmi chi erano i re, quali i tempi, quale fosse la condizione delle cose nel Lazio antico, quando l’esercito straniero per la prima volta approdò alle coste ausonie, lo spiegherò, e rievocherò gli inizi della prima guerra. Tu, o dea, ammonisci il vate. Dirò guerre orrende, dirò schiere e re spinti dalla furia alla morte, e la schiera tirrenica e tutta l’Esperia costretta alle armi. Un ordine maggiore di eventi mi nasce, un’opera più grande intraprendo. 46-53 Il re Latino, già anziano, governava pacificamente terre e città in lunga pace. Lo abbiamo ricevuto come figlio di Fauno e della ninfa Laurentina Marica; Fauno ha per padre Pico, e questi riferisce te, o Saturno, come genitore, tu ultimo autore del suo sangue. A lui per volere degli dèi e per il fato non vi fu alcun figlio maschio, e la primogenita gli fu tolta nella sua prima giovinezza. Solo una figlia salvava la casa e le tante sedi, già matura per un marito, già nubile in anni pieni. 54-58 Molti da tutto il grande Lazio e dall’intera Ausonia la chiedevano in sposa; prima di tutti la chiedeva il bellissimo Turno, potente per avi e trisavoli, che la sposa regina (Amata) si affrettava con mirabile amore ad unire come genero; ma vari portenti divini si oppongono con terrore. 59-70 Vi era un alloro nel mezzo della casa, negli alti penetrali, sacro per la sua chioma e conservato con timore per molti anni, che il padre Latino stesso, si diceva, aveva consacrato a Febo (Apollo) quando fondava le prime rocche, e da esso aveva dato il nome ai coloni di Laurento. Api dense (mirabile a dirsi), giunte attraverso l’aria liquida con un ronzio immenso, si posarono sulla cima, e, con le zampe intrecciate tra loro, uno sciame improvviso pendeva da un ramo frondoso. Subito il vate disse: “Vediamo un uomo straniero arrivare e la schiera cercare le stesse parti dalle stesse parti e dominare dall’alta rocca.” 71-80 Inoltre, mentre la vergine Lavinia pura bruciava incensi sugli altari e stava accanto al padre, fu vista (orrendo a dirsi) prendere fuoco con le lunghe chiome e bruciare tutto il suo ornamento con fiamma crepitante, e le regali chiome in fiamme, e in fiamme la corona insigne di gemme; poi avvolgersi in fumo con luce giallastra e spargere fuoco (Vulcano) per tutta la reggia. Questo invero fu portato come orrendo e mirabile a vedersi: e infatti cantavano che essa (Lavinia) sarebbe stata illustre per fama e per i fati, ma avrebbe preannunciato una grande guerra al popolo. 81-91 Ma il re, preoccupato per i prodigi, si reca agli oracoli di Fauno, suo padre vaticinante, e consulta i boschi sotto l’alta Albunea, che risuona, massima tra i boschi, con la sua fonte sacra ed esala una mefite crudele e oscura. Di qui le genti italiche e tutta la terra Enotria cercano responsi nei momenti difficili; qui il sacerdote, dopo aver portato doni e essersi steso sulle pelli di pecore immolate nella notte silenziosa e aver cercato il sonno, vede molte immagini volare in modi mirabili e ode voci diverse e gode del colloquio degli dèi e si rivolge ad Acheronte dagli Inferi più profondi. 92-101 Qui e allora lo stesso padre Latino, cercando responsi, immolava secondo il rito cento agnelle lanose, e giaceva, appoggiato sul dorso di queste e sulle lane stese: all’improvviso dall’alto bosco fu resa una voce: “Non cercare di unire in matrimonio tua figlia con Latini, o mia discendenza, né affidarti a nozze già preparate; verranno generi stranieri, che con il loro sangue porteranno il nostro nome alle stelle, e dalla cui stirpe i nipoti vedranno ogni cosa sotto i loro piedi, dove il sole, scorrendo da una parte all’altra, guarda l’Oceano, e saranno mutati e governati.” 102-106 Queste risposte del padre Fauno e gli ammonimenti dati nella notte silenziosa Latino stesso non li tiene nascosti con la sua bocca, ma ormai la Fama, volando largamente per le città Ausonie, li aveva portati, quando la gioventù di Laomedonte (i Troiani) legò la flotta alla banchina erbosa dalla sponda. |
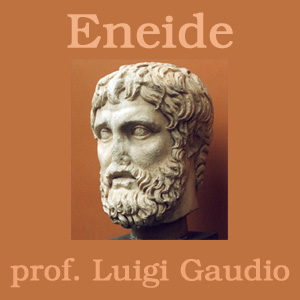
Analisi del Brano
Questo lungo e significativo brano apre il Settimo Libro dell’Eneide, segnando un momento cruciale nel poema: l’arrivo di Enea nel Lazio, la terra promessa. Virgilio abbandona la narrazione delle peripezie marittime (l’Odissea di Enea) per introdurre la seconda parte dell’opera, quella più legata all’Iliade, incentrata sui conflitti e la fondazione.
1. Il viaggio finale e l’approdo (vv. 1-36)
- La morte di Caieta (vv. 1-4): Il brano si apre con un omaggio a Caieta, la nutrice di Enea, morta e sepolta sulle coste che prenderanno il suo nome (l’attuale Gaeta). Questo dettaglio, apparentemente minore, ha una duplice funzione: chiude simbolicamente la fase del viaggio e la serie di lutti che hanno accompagnato Enea, e rafforza il tema della pietas del protagonista, che onora i suoi cari anche in circostanze difficili. Inoltre, l’idea che il nome sia una “gloria” per le ossa anticipa il tema della fama e della gloria che sarà centrale nella fondazione di Roma.
- La navigazione notturna (vv. 5-9): Dopo i riti funebri, Enea riprende il mare. L’immagine della notte illuminata dalla luna e dal mare scintillante crea un’atmosfera serena e quasi magica, un contrasto con le difficoltà precedenti. I “venti spirano propizi” (aspirant aurae in noctem) suggeriscono un viaggio guidato da forze superiori.
- La terra di Circe (vv. 10-24): L’incontro con la terra di Circe è un momento di grande suggestione e pericolo. Virgilio descrive il regno della maga con dettagli vividi: i boschi inaccessibili, il canto continuo, l’odore del cedro bruciato. Ma soprattutto, i suoni degli animali trasformati (leoni, cinghiali, orsi, lupi) che “rifiutano le catene” evocano un senso di terrore e disumanizzazione. La dea Circe, figlia del Sole, è presentata come una figura potente e ambigua. L’intervento di Nettuno, che allontana la nave di Enea da quei pericoli, sottolinea ancora una volta la protezione divina sul destino dell’eroe. Questo episodio serve a mostrare come Enea sia destinato a un futuro diverso, non quello della trasformazione e della regressione alla bestialità, ma quello della fondazione e della civiltà.
- L’alba e l’approdo nel Tevere (vv. 25-36): Il passaggio dall’oscurità e dal pericolo della notte all’alba (“Aurora in roseis fulgebat lutea bigis”) è un simbolo di speranza e di un nuovo inizio. La descrizione del fiume Tevere (“Tiberinus”) è ricca di dettagli che ne esaltano la bellezza e la vitalità: le correnti rapide, la sabbia gialla, gli uccelli che addolciscono l’aria con il loro canto. L’immagine del bosco immenso (“ingentem ex aequore lucum”) e del fiume “ameno” crea un’atmosfera di pace e fertilità. L’ordine di Enea di dirigere le prore verso terra e la sua gioia (“laetus fluvio succedit opaco”) segnano l’apice di questa fase, l’arrivo nella terra promessa.

2. L’invocazione alla Musa e la “maior rerum ordo” (vv. 37-45)
- L’invocazione a Erato: Con l’arrivo nel Lazio, Virgilio sente il bisogno di invocare una nuova Musa, Erato, la Musa della poesia lirica e amorosa (ma qui invocata per i temi “guerreschi” che seguiranno). Questo è un secondo proemio dell’Eneide, che segna una svolta tematica.
- La “maior rerum ordo”: Virgilio dichiara esplicitamente che sta per iniziare un’opera di maggiore importanza e complessità (“maior rerum mihi nascitur ordo, maius opus moueo”). Questo riflette il passaggio dalla narrazione del viaggio (ispirata all’Odissea) alla descrizione delle guerre e della fondazione di una nuova civiltà (ispirata all’Iliade). Si preannunciano “guerre orrende” e “re spinti dalla furia alla morte”, preparando il lettore al tono epico e drammatico dei libri successivi.
3. Il regno di Latino e i prodigi (vv. 46-80)
- Re Latino e la sua stirpe (vv. 46-53): Viene introdotto il re Latino, figura simbolo di pace e saggezza (“longa placidas in pace regebat”). La sua genealogia, che risale a Saturno attraverso Fauno e Pico, lo lega alle antiche divinità italiche e alla tradizione autoctona del Lazio, sottolineando il carattere sacro e antico di questa terra. La mancanza di eredi maschi e l’unica figlia, Lavinia, “già matura per un marito”, pongono le premesse per il conflitto.
- Lavinia e Turno (vv. 54-58): Lavinia è l’unica erede e molti la desiderano in sposa. Tra i pretendenti spicca Turno, figura potente e di nobile stirpe. L’amore della regina Amata per Turno come genero crea un forte legame che si opporrà all’arrivo di Enea.
- I prodigi (vv. 58-80): La narrazione si concentra su due prodigi che preannunciano l’arrivo dello straniero e la guerra:
- L’alloro e le api (vv. 59-70): Un alloro sacro, simbolo di Apollo (divinità profetica), si trova al centro della reggia. Lo sciame di api che si posa sulla sua cima è interpretato da un vate come l’arrivo di “un uomo straniero” (externum uirum) che dominerà la rocca. Questo presagio è chiaro e diretto.
- I capelli di Lavinia in fiamme (vv. 71-80): Il prodigio più suggestivo e inquietante è quello di Lavinia, i cui capelli prendono fuoco mentre offre sacrifici. Questo è un “horrendum ac uisu mirabile” segno. La fiamma che la avvolge simboleggia la sua futura fama (“fore inlustrem fama fatisque canebant ipsam”), ma anche la grande guerra (“magnum portendere bellum”) che la sua unione con Enea provocherà al popolo. Il fuoco, elemento di distruzione, ma anche di purificazione e rivelazione, è qui un potente simbolo del destino.
4. L’oracolo di Fauno (vv. 81-106)
- Re Latino consulta Fauno (vv. 81-91): Preoccupato dai prodigi, Latino si reca al sacro bosco di Albunea per consultare l’oracolo di suo padre, Fauno. Il rito è descritto con dettagli vividi: l’offerta di doni, il riposo sulle pelli delle pecore sacrificate e la visione di “immagini volanti” e “voci diverse”. Questo “sonno incubatorio” è una pratica comune nell’antichità per ottenere responsi divini.
- Il responso dell’oracolo (vv. 92-101): La voce di Fauno, che giunge “dall’alto bosco”, è perentoria: Lavinia non deve sposare un latino (“ne pete conubiis natam sociare Latinis”). Devono arrivare “generi stranieri” (externi uenient generi) che porteranno il nome della stirpe di Latino alle stelle e i cui discendenti domineranno il mondo. Questo oracolo conferma la volontà divina e il destino di Enea, predestinato a fondare la stirpe che darà origine all’Impero Romano.
- La diffusione della Fama (vv. 102-106): Il brano si chiude con la Fama (personificazione della voce pubblica, del rumore che si diffonde) che immediatamente porta la notizia dell’oracolo per le città ausonie. La Fama è una figura potente e veloce, che accelera lo svolgersi degli eventi, quasi in simultanea con l’arrivo dei Troiani. L’immagine finale dei Troiani che legano la flotta alla banchina chiude il cerchio, collegando l’oracolo all’arrivo effettivo di Enea, suggellando il suo destino.
In questo brano, Virgilio intreccia magistralmente elementi mitologici, descrizioni paesaggistiche, presagi divini e la volontà del Fato per preparare il lettore al grande conflitto che sta per scoppiare e alla fondazione di Roma. L’arrivo di Enea non è un semplice sbarco, ma l’inizio di una nuova era, guidata dalla volontà divina e preannunciata da segni inequivocabili.





