
Lavorare con passione e fantasia
12 Giugno 2025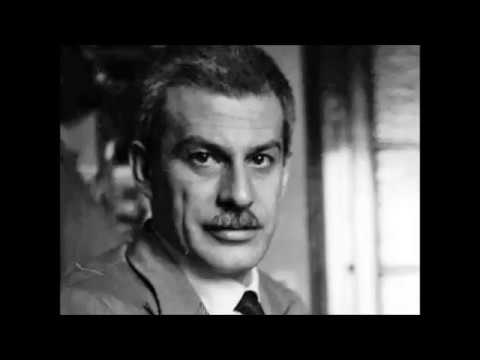
Traccia e schema di svolgimento di una analisi testuale da Conversazione in Sicili…
13 Giugno 2025Traccia e svolgimento di una analisi della poesia La bambina di Pompei di Primo Levi

TRACCIA
PRIMA PROVA SCRITTA
SESSIONE STRAORDINARIA 2023 – Ministero dell’istruzione e del merito
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A1
Primo Levi, La bambina di Pompei, in Ad ora incerta, Garzanti, Milano, 2013.
Testo
Poiché l’angoscia di ciascuno è la nostra
Ancora riviviamo la tua, fanciulla scarna
Che ti sei stretta convulsamente a tua madre
Quasi volessi ripenetrare in lei
Quando al meriggio il cielo si è fatto nero.
Invano, perché l’aria volta in veleno
È filtrata a cercarti per le finestre serrate
Della tua casa tranquilla dalle robuste pareti
Lieta già del tuo canto e del tuo timido riso.
Sono passati i secoli, la cenere si è pietrificata
A incarcerare per sempre codeste membra gentili.
Così tu rimani tra noi, contorto calco di gesso,
Agonia senza fine, terribile testimonianza
Di quanto importi agli dèi l’orgoglioso nostro seme.
Ma nulla rimane fra noi della tua lontana sorella,
Della fanciulla d’Olanda murata fra quattro mura
Che pure scrisse la sua giovinezza senza domani:
La sua cenere muta è stata dispersa dal vento,
La sua breve vita rinchiusa in un quaderno sgualcito.
Nulla rimane della scolara di Hiroshima,
Ombra confitta nel muro dalla luce di mille soli,
Vittima sacrificata sull’altare della paura.
Potenti della terra padroni di nuovi veleni,
Tristi custodi segreti del tuono definitivo,
Ci bastano d’assai le afflizioni donate dal cielo.
Prima di premere il dito, fermatevi e considerate.
20 novembre 1978
Nota biografica
Primo Levi (1919-1987) ha narrato nel romanzo-testimonianza Se questo è un uomo la dolorosa esperienza personale della deportazione e della detenzione ad Auschwitz. La raccolta Ad ora incerta, pubblicata nel 1984, contiene testi poetici scritti nell’arco di tutta la sua vita.
COMPRENSIONE E ANALISI
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.
- Presenta sinteticamente il contenuto della poesia, indicandone i temi.
- Quali analogie e quali differenze riscontri tra la vicenda della ‘bambina di Pompei’ e quelle della ‘fanciulla d’Olanda’ e della ‘scolara di Hiroshima’?
- ‘Poiché l’angoscia di ciascuno è la nostra’: qual è la funzione del primo verso e quale relazione presenta con il resto della poesia?
- Spiega il significato che Primo Levi intendeva esprimere con ‘Terribile testimonianza/Di quanto importi agli dèi l’orgoglioso nostro seme’.
INTERPRETAZIONE
Proponi un’interpretazione della poesia, mettendola in relazione con altre opere dell’autore, se le conosci, o con le tragiche vicende della Seconda guerra mondiale che vengono ricordate nel testo e spiega anche quale significato attribuiresti agli ultimi quattro versi.

SVOLGIMENTO
Analisi di ‘La bambina di Pompei’ di Primo Levi
La poesia “La bambina di Pompei”, inclusa nella raccolta Ad ora incerta (1984) di Primo Levi, è una lirica di profonda riflessione sulla sofferenza umana, la violenza storica e la fragilità dell’esistenza. Attraverso il ricordo di vittime di tragedie passate e recenti, Levi, con la sua inconfondibile lucidità morale, lancia un monito ai “Potenti della terra”, riaffermando la necessità della memoria e della responsabilità.
Comprensione e Analisi
1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia, indicandone i temi.
La poesia si apre con un’affermazione di solidarietà universale nel dolore (“Poiché l’angoscia di ciascuno è la nostra”), per poi evocare la tragica fine di una “fanciulla scarna” di Pompei, il cui calco di gesso testimonia l’agonia mentre cerca rifugio nella madre durante l’eruzione del Vesuvio. La sua morte è presentata come un segno di quanto l'”orgoglioso nostro seme” importi agli dèi. Il poeta poi sposta l’attenzione su altre due figure di vittime innocenti: la “lontana sorella” d’Olanda, un’allusione ad Anna Frank, di cui nulla rimane se non il suo quaderno sgualcito; e la “scolara di Hiroshima”, ridotta a un'”ombra confitta nel muro” dalla luce atomica, vittima della paura. La poesia si conclude con un appello ai “Potenti della terra”, detentori di nuovi veleni e del “tuono definitivo”, affinché si fermino a riflettere prima di agire, riconoscendo che le afflizioni donate dal cielo sono già sufficienti.
I temi principali della poesia sono:
- La sofferenza universale e la solidarietà umana di fronte alla tragedia.
- La memoria delle vittime innocenti di eventi catastrofici (naturali e antropici).
- La crudeltà e l’arbitrio della storia, spesso determinati dal potere.
- La responsabilità della scienza e della politica nell’era delle armi di distruzione di massa.
- La fragilità dell’esistenza umana di fronte a forze soverchianti.
- Il monito contro la guerra nucleare e l’abuso di potere.
2. Quali analogie e quali differenze riscontri tra la vicenda della ‘bambina di Pompei’ e quelle della ‘fanciulla d’Olanda’ e della ‘scolara di Hiroshima’?
Tra la vicenda della “bambina di Pompei” e quelle della “fanciulla d’Olanda” e della “scolara di Hiroshima” si riscontrano profonde analogie e significative differenze:
Analogie:
- Innocenza e vulnerabilità: Tutte e tre sono figure di fanciulle, simbolo di innocenza e vulnerabilità. La loro giovane età le rende vittime indifese di forze maggiori di loro.
- Morte violenta e tragica: Tutte sono morte in circostanze tragiche e violente, non per cause naturali, ma per eventi catastrofici (eruzione, sterminio, bomba atomica).
- Angoscia e sofferenza universali: La loro sorte, pur specifica, evoca un’angoscia che il poeta definisce “di ciascuno” e “la nostra”, rendendole simboli universali del dolore innocente.
- Testimonianza: Tutte, a loro modo, lasciano una testimonianza della loro tragedia. La bambina di Pompei è un “contorto calco di gesso”, una testimonianza fisica e diretta. La fanciulla d’Olanda (Anna Frank) è ricordata attraverso il suo “quaderno sgualcito”, una testimonianza scritta. La scolara di Hiroshima è un'”ombra confitta nel muro”, una testimonianza visiva, spettrale.
Differenze:
- Natura della causa della morte:
- La bambina di Pompei è vittima di una catastrofe naturale (l’eruzione vulcanica), un evento “donato dal cielo”.
- La fanciulla d’Olanda (Anna Frank) è vittima di una persecuzione umana e dello sterminio sistematico (l’Olocausto).
- La scolara di Hiroshima è vittima della tecnologia umana e del suo uso distruttivo (la bomba atomica), espressione di una paura e di una volontà di dominio.
- Permanenza della testimonianza:
- Il calco di Pompei è una presenza fisica, un “contorto calco di gesso” che “rimane tra noi”.
- Della fanciulla d’Olanda “nulla rimane” del corpo, ma la sua vita è “rinchiusa in un quaderno sgualcito” (memoria letteraria).
- Della scolara di Hiroshima “nulla rimane” del corpo, solo un'”ombra confitta nel muro”, una traccia evanescente (memoria fisica svanita).
- Significato teologico/morale: La bambina di Pompei sembra essere una vittima degli “dèi”, un monito sulla superbia umana di fronte al divino. Le altre due sono vittime di una violenza puramente umana, ponendo la questione della responsabilità dell’uomo verso sé stesso e le proprie creazioni.
Il passaggio dalla tragedia naturale a quella umana e tecnologica sottolinea un’escalation della responsabilità e della violenza esercitata dall’uomo.
3. ‘Poiché l’angoscia di ciascuno è la nostra’: qual è la funzione del primo verso e quale relazione presenta con il resto della poesia?
Il primo verso, “Poiché l’angoscia di ciascuno è la nostra”, ha una funzione di prologo e di dichiarazione universale, stabilendo il tono e la prospettiva etica dell’intera poesia.
- Funzione di prologo/premessa: Introduce il tema generale della solidarietà nel dolore e della condivisione della condizione umana. Non è solo un’osservazione, ma quasi un’affermazione filosofica che funge da fondamento per tutto ciò che seguirà.
- Stabilisce una connessione universale: Il “ciascuno” indica l’individuo nella sua singolarità, mentre il “nostra” coinvolge il lettore e l’intera umanità. Il dolore di uno non è isolato, ma risuona in tutti, creando un senso di comune vulnerabilità e interdipendenza.
- Giustifica la rievocazione delle tragedie: È il motivo per cui il poeta si sente in dovere di rivivere e di narrare le angosce di queste fanciulle. Poiché la loro sofferenza è anche la nostra, è imperativo ricordarle e imparare dalla loro storia.
- Relazione con il resto della poesia: Questo verso è il filo rosso che lega le tre vicende apparentemente distanti nel tempo e nello spazio. L’angoscia della bambina di Pompei, quella della fanciulla d’Olanda e della scolara di Hiroshima, pur diverse nelle loro cause, sono presentate come manifestazioni di un’unica, universale angoscia umana. Il verso iniziale eleva le singole tragedie a simbolo di una condizione esistenziale condivisa e motiva l’appello finale alla responsabilità dei potenti, poiché le loro azioni hanno ripercussioni sull’angoscia di tutti.
4. Spiega il significato che Primo Levi intendeva esprimere con ‘Terribile testimonianza/Di quanto importi agli dèi l’orgoglioso nostro seme’.
L’espressione “Terribile testimonianza / Di quanto importi agli dèi l’orgoglioso nostro seme” (vv. 13-14), riferita al calco della bambina di Pompei, esprime un significato complesso e ambiguo, tipico della riflessione di Levi sulla sofferenza e sul destino umano.
- “Terribile testimonianza”: Il calco è la prova concreta, fisica e sconvolgente, di un’agonia. La sua “terribilità” non è solo per la sofferenza che evoca, ma anche per il suo essere un monito, una lezione brutale sull’ineluttabilità della morte e sulla fragilità della vita.
- “Di quanto importi agli dèi”: Questa è l’espressione più ambigua. Può essere letta in più modi:
- Ironia/Sarcasmo: In un senso laico, potrebbe essere un’affermazione sarcastica sulla presunta indifferenza o crudeltà divina. Se agli dèi “importa” il nostro “seme” (l’umanità, la sua prole, il suo futuro), allora lo fanno in modo crudele, permettendo o causando tali tragedie. L’importanza si manifesta non con protezione, ma con una punizione o un’indifferenza che sottolinea la nostra insignificanza o la nostra presunzione.
- Monito divino contro la superbia umana: L’espressione “orgoglioso nostro seme” si riferisce alla superbia, alla presunzione dell’uomo nel costruire, nel dominare, nel credersi al di sopra delle forze naturali o divine. La catastrofe di Pompei sarebbe, in questa lettura, una punizione o un avvertimento divino contro l’eccessiva fiducia dell’uomo nelle proprie capacità e il suo oblio della propria fragilità. Agli dèi importa ricordarci il nostro posto.
- Una costante della storia: Potrebbe semplicemente indicare che l’umanità è perennemente soggetta a forze che la sovrastano, siano esse naturali o metafisiche, e che queste forze esercitano un potere incomprensibile sul nostro destino, senza che possiamo farci nulla.
Dato il contesto successivo della poesia, che introduce tragedie di origine umana, l’interpretazione più plausibile tende all’ironia o al monito sulla presunzione umana. La tragedia naturale di Pompei anticipa quella, ben più grave perché auto-inflitta, della guerra, suggerendo che l'”orgoglioso nostro seme” provoca la propria rovina quando non si pone limiti.
Interpretazione
“La bambina di Pompei” di Primo Levi è una lirica che condensa la sua profonda riflessione sulla sofferenza e sulla responsabilità, tematiche centrali in tutta la sua opera. La poesia si pone come una meditazione sulla vulnerabilità umana di fronte alla catastrofe, sia essa naturale o, soprattutto, antropica, e si conclude con un accorato appello morale.
La poesia si lega indissolubilmente all’intera opera di Levi, in particolare al suo capolavoro Se questo è un uomo, dove narra la dolorosa esperienza della deportazione e della detenzione ad Auschwitz. Lì, come nelle tragedie evocate nella poesia, l’individuo è ridotto a “materiale di contorno”, annientato da una violenza disumana. La “fanciulla d’Olanda murata fra quattro mura” è un’evidente allusione ad Anna Frank, la cui storia è un simbolo dello sterminio nazista. Il parallelo tra la bambina di Pompei e Anna Frank sottolinea la somiglianza del loro destino di vittime innocenti, ma anche la radicale differenza nella causa della morte: la prima è vittima della natura, la seconda della barbarie umana. Questo passaggio è cruciale per Levi: il male inflitto dall’uomo all’uomo, la Shoah in particolare, è un evento che sfida ogni comprensione e perdono.
La “scolara di Hiroshima”, infine, introduce la dimensione della responsabilità della scienza e della tecnologia quando esse vengono piegate a fini distruttivi. La “luce di mille soli” che la riduce a un'”ombra confitta nel muro” è l’esito apocalittico dell’intelligenza umana senza freni morali. Questa figura è un monito contro la minaccia nucleare, una preoccupazione costante nel pensiero di Levi nel dopoguerra. Egli, da chimico, era profondamente consapevole delle potenzialità sia costruttive che distruttive della scienza, e l’immagine di Hiroshima rappresenta la massima perversione del progresso.
Gli ultimi quattro versi della poesia assumono un significato di monito finale e di appello etico di straordinaria urgenza, che riassume la preoccupazione costante di Levi:
- “Potenti della terra padroni di nuovi veleni, / Tristi custodi segreti del tuono definitivo,” (vv. 21-22): Il poeta si rivolge direttamente ai detentori del potere politico e militare, coloro che hanno il controllo delle armi di distruzione di massa (“nuovi veleni”, “tuono definitivo” allude alla bomba atomica). Li definisce “tristi custodi segreti”, sottolineando la solitudine e la gravità della loro posizione, ma anche la loro potenziale irresponsabilità.
- “Ci bastano d’assai le afflizioni donate dal cielo.” (v. 23): Questa è una preghiera, un’implorazione. Le catastrofi naturali (come Pompei) sono già sufficienti a infliggere dolore all’umanità. Non c’è bisogno che l’uomo si aggiunga con la sua violenza auto-inflitta, attraverso la guerra e le armi di distruzione di massa. È un’accusa alla follia umana di provocare la propria rovina.
- “Prima di premere il dito, fermatevi e considerate.” (v. 24): L’ultimo verso è un imperativo diretto, un’esortazione alla prudenza e alla riflessione. “Premere il dito” è un gesto minimo che ha conseguenze catastrofiche (il pulsante nucleare). “Fermatevi e considerate” è un appello alla razionalità, alla consapevolezza delle conseguenze, un invito a interrompere la spirale di violenza prima che sia troppo tardi. È un appello alla responsabilità morale dei potenti.
In sintesi, gli ultimi versi non sono solo una chiusa poetica, ma un testamento morale di Primo Levi. Egli, che ha vissuto l’orrore della guerra e la brutalità umana, usa la poesia per lanciare un grido d’allarme contro l’autodistruzione. È un messaggio di pace, ma anche un severo richiamo alla coscienza di coloro che detengono il potere, affinché non dimentichino le lezioni della storia e non aggiungano ulteriori tragedie a quelle già imposte dal destino o dalla natura. La loro “angoscia”, come quella delle fanciulle, deve essere la nostra.





