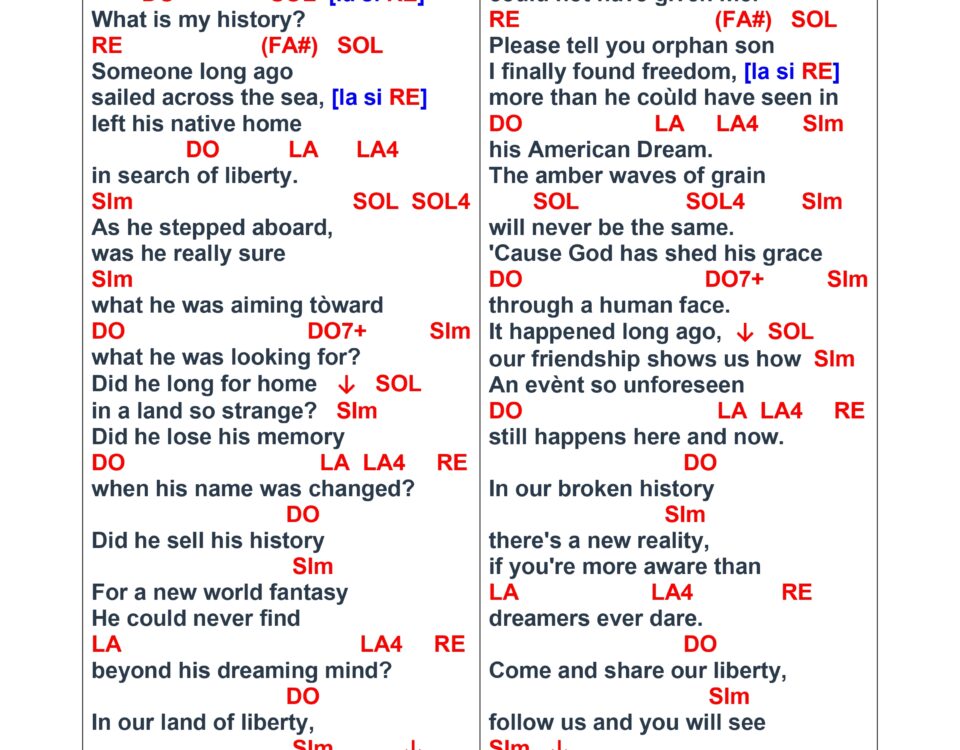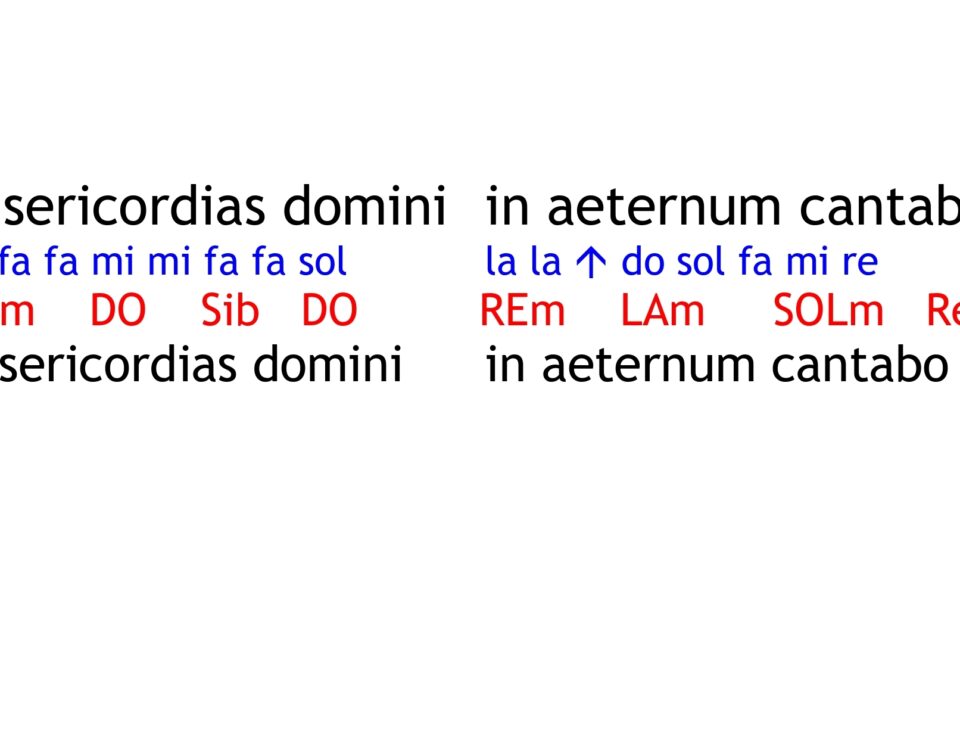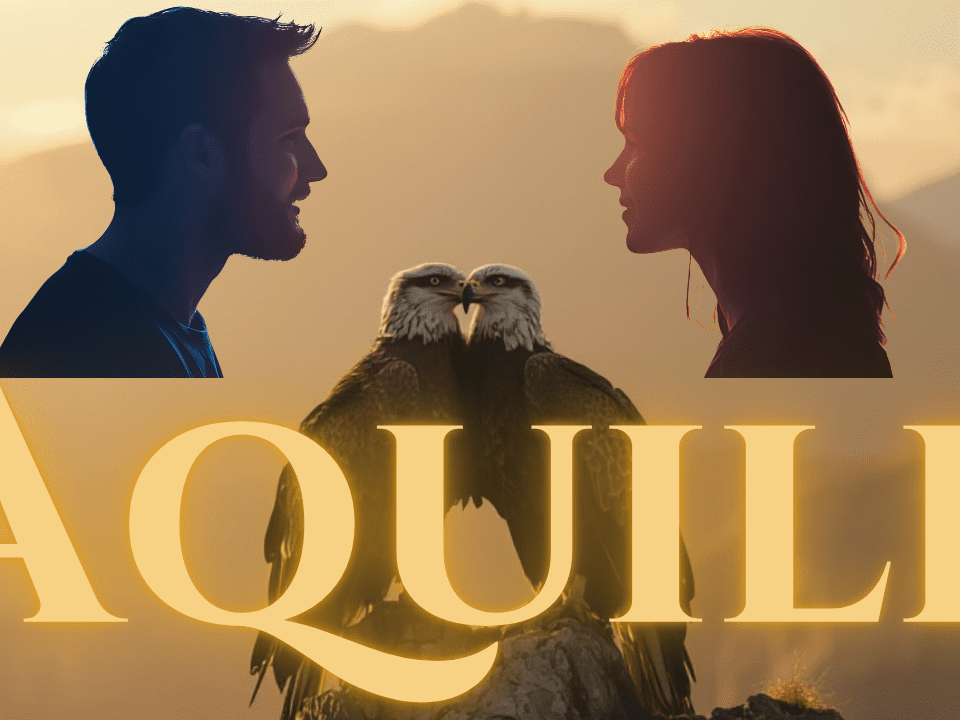Sicheo Casimir Patrick
28 Dicembre 2019
Vecchio al ponte di Ernest Hemingway
28 Dicembre 2019Il racconto “La bella serata” di Alberto Moravia si inserisce nella produzione dello scrittore romano, caratterizzata da un realismo crudo e ironico, in cui si esplorano le debolezze e le miserie della condizione umana.
1. Il contesto
Il testo narra una serata tra amici in una trattoria di infima qualità, rivelando attraverso la narrazione le delusioni, le frustrazioni e le piccole miserie quotidiane di un gruppo di persone comuni.
La vicenda, apparentemente semplice, si carica di significati più profondi: l’incomunicabilità tra i personaggi, il contrasto tra aspettative e realtà, e la critica alla società attraverso la rappresentazione di ambienti degradati e personaggi mediocri.
2. Struttura e stile
Il racconto è narrato in prima persona da un narratore interno che partecipa agli eventi, contribuendo a rendere il tono ancora più ironico e amaro. La narrazione è scandita da una successione di eventi che seguono un ritmo ben preciso: l’arrivo alla trattoria, la scoperta delle sue condizioni scadenti, il cibo pessimo, il tentativo di migliorare la situazione con il vino e la musica, e infine la rissa conclusiva.
Lo stile di Moravia è essenziale, realistico e privo di fronzoli. Utilizza un linguaggio colloquiale, vicino al parlato, che riflette la quotidianità e la banalizzazione del degrado. L’ironia è un elemento costante: attraverso le descrizioni e i dialoghi si crea un effetto di comicità amara che mette in luce le debolezze dei personaggi.
3. Personaggi
- Amilcare: è il personaggio più pittoresco, caratterizzato da una grande fiducia nelle proprie scelte che si riveleranno disastrose. Ostenta allegria e sicurezza, ma alla fine risulta il più sconfitto della serata.
- Sirio: uomo dal carattere irascibile, per via della sua ulcera allo stomaco. Rappresenta il malcontento costante, sempre pronto alla polemica e alla lite.
- Remo: giovane seduttore, superficiale e vanitoso, che cerca di impressionare la giovane Gemma con il canto.
- Gemma: la ragazza più giovane del gruppo, si mostra schifata dal cibo e resta estranea ai conflitti.
- Adele: moglie di Amilcare, personaggio rassegnato e cinico, che non ostacola il marito nelle sue decisioni, pur prevedendone le conseguenze.
- L’oste: figura simbolo dell’ambiente degradato, scortese e indifferente alle lamentele dei clienti, rappresenta l’inefficienza e la mediocrità di una certa ristorazione popolare.
4. Ambiente e atmosfera
La trattoria “Africa” non è solo il luogo in cui si svolge la storia, ma diventa il simbolo di un’Italia popolare e decadente. L’ambiente è squallido, freddo, malconcio, e il cibo servito è scadente, a tratti disgustoso (come dimostra la scena del bacherozzo negli spaghetti). Il freddo persistente e l’assenza di conforto contribuiscono a creare un’atmosfera di disagio e di fallimento.
5. Il tema del fallimento e della frustrazione
La “bella serata” si rivela un totale fallimento. I personaggi cercano svago e piacere, ma incontrano solo disillusioni: il cibo è pessimo, il servizio scadente, l’atmosfera deprimente e la serata si conclude con una rissa. Questo rispecchia la condizione di un’umanità frustrata, incapace di migliorare la propria situazione e condannata a subire la mediocrità del quotidiano.
6. Conclusione e significato
“La bella serata” è un racconto ironico e amaro, che attraverso un episodio apparentemente banale riflette su temi universali come la mediocrità, l’insoddisfazione e l’incapacità di realizzare le proprie aspettative. La critica sociale si insinua tra le righe, mostrando un’Italia popolare fatta di espedienti, illusioni e disillusioni. Il finale grottesco, con il cartoccio di rifiuti lanciato dalla finestra, suggella con una nota di crudele ironia il fallimento totale della serata e dei suoi protagonisti.
Testo originale del racconto “La bella serata” di Alberto Moravia
LA BELLA SERATA
In quanti eravamo? Eravamo in sei, due donne: Adele, la moglie di Amilcare, e Gemma, la nipote loro di Terni, in gita a Roma; e quattro uomini: Amilcare, Remo, Sirio ed io.
Intanto il primo errore fu di far venire Sirio che per via dell’ulcera allo stomaco è irascibile e prende fuoco per ogni nonnulla. Il secondo fu di dar retta ad Amilcare nella scelta della trattoria: siccome aveva da pagare per tre e non voleva spendere, insistette, all’appuntamento in piazza Indipendenza, perché andassimo in un’osteria che conosceva lui, lì vicino: l’oste era amico suo, si mangiava bene, ci avrebbe fatto prezzi speciali.
Dovevamo pensarci prima: che può esserci di buono in quei quartieracci intorno alla stazione? Sono parti di Roma dove non capitano che forestieri di passaggio o coscritti delle caserme del Macao.
Dunque, ci avviammo per quelle strade dritte, tra quei casamenti grigi, in un freddo proprio di gennaio, secco e tagliente. Amilcare, che è un mangione, badava a ripetere: “Aho, giovanotti, voglio farmi una mangiata numero uno… questa volta voglio mangiare e bere senza pensare al fegato, ai reni, allo stomaco e alle altre budelle… te lo dico prima Adele, perché tu non cominci con la solita lagna.”
“Per me – disse Adele, una donna secca e triste quanto lui era grasso e allegro – fai pure… se ne riparla domani.” Remo intanto scherzava con Gemma, una bella ragazza bruna, e Sirio ed io commentavamo le ultime del calcio. Percorremmo così parecchie di quelle strade smorte coi nomi delle patrie battaglie: Castelfidardo, Calatafimi, Palestro, Marsala, e finalmente, a due lumi a palla, con l’insegna “Trattoria Africa”, ci infilammo dentro.
L’osteria, subito ce ne accorgemmo, non era un gran che. C’era un primo stanzone coi tavoli di marmo per berci il mezzo litro e poi c’era un secondo stanzone diviso in due parti da un tramezzo: da una parte la cucina, dall’altra la trattoria vera e propria con cinque o sei tavoli con le tovaglie. Per il resto il solito squallore dei locali intorno alla stazione: segatura in terra, intonaco scrostato alle pareti, seggiole sgangherate, tavoli idem, tovaglie rammendate, bucate e per giunta sporche. Ma quello che ci colpì soprattutto fu il freddo: intenso, umido, di grotta. Tanto che Sirio entrando esclamò: “Aho, altro che Africa!… qui c’è il caso di beccarsi una polmonite.”
Faceva effettivamente un gran freddo: nell’osteria i bevitori stavano ai tavoli con il cappello, il cappotto e il bavero rialzato; a respirare, si vedeva nell’aria la nuvoletta, come se fossimo stati per strada. Sedemmo ad uno di quei tavoli, e subito venne l’oste, un omaccione con la faccia tetra, quadrata e gli occhi pesti e malcontenti. Amilcare, tutto allegro, gli domandò: “Sor Giovanni, si ricorda di me?” Ma l’altro, senza sorridere: “Mi chiamo Serafino e non Giovanni… per dir la verità non la ricordo.”
Amilcare ci rimase male e cominciò a tempestarlo di domande; quello aggrottava la fronte, incerto, e finalmente esclamò: “Ma sì… lei venne qua a Capodanno, a mangiare lo zampone con le lenticchie.” Amilcare rispose che il Capodanno l’aveva passato a casa; e, insomma, non si riconobbero. Poi l’oste cavò dalla giubba bianca che era tutta una frittella, la lista dei piatti domandando: “Che mangiano i signori?”; e la discussione dei ricordi finì.
Prendemmo la lista e subito vedemmo che c’era poco da ridere: pasta asciutta, abbacchio o pollo, formaggio e frutta. Amilcare per non far cattiva figura insistette con l’oste: “Ma ci avete la vostra specialità… gli spaghetti all’amatriciana.” L’oste disse che ci aveva infatti gli spaghetti all’amatriciana e ordinammo tutti antipasto, spaghetti, chi pollo chi arrosto e chi abbacchio al forno. Per il dolce si disse che ci avremmo pensato. Ma Sirio protestò che voleva la minestrina e l’oste gli assicurò che ci aveva il brodo di pollo. Quindi domandò come volevamo il vino: se bianco o rosso, se asciutto o sulla vena. Decidemmo per il frascati asciutto e l’oste portò i litri, i bicchieri, il pane, le posate involtate nei tovaglioli e se ne andò in cucina.
Amilcare, rinfrancato, domandò: “Che ve ne pare… non si sta bene?” Ci guardammo in faccia e finalmente, interpretando il sentimento comune, Sirio rispose: “Per star bene, vedremo… per ora mi pare di star in una latrina pubblica.” Questa risposta non piacque ad Amilcare che impegnò una discussione agretta: tu sei un guastafeste; e tu vuoi risparmiare; tu ci hai l’ulcera e in trattoria non dovresti andarci; e tu vuoi mangiare ma non vuoi spendere; e così via.
Intanto il tempo passava e noi, come sempre avviene nei locali non attrezzati, ci abbottavamo di vino e di pane discutendo del più e del meno. Faceva veramente freddo, avevamo tutti i piedi gelati e il sedere intirizzito; il vino, poi, forse perché era annacquato, come disse Sirio, più se ne beveva e meno ci riscaldava. Amilcare finalmente si inquietò e andò in cucina tornando poco dopo, soddisfatto, ad annunziare che presto avremmo mangiato.
Arrivò, infatti, l’oste e distribuì gli antipasti, tutti guardammo nei piatti: miseria. Due carciofini, una fetta di prosciutto, una sardina. Sirio disse ad Amilcare: “Mi sa che stasera la mangiata non la fai.” Cominciammo a mangiare ma tutti dissero che il prosciutto era salato arrabbiato, da non mangiarsi. “Prosciutto africano”, disse Sirio che pareva fare apposta a canzonare Amilcare. Insomma l’antipasto rimase sui piatti; per fortuna, di rincalzo, arrivarono gli spaghetti. Fumavano, perché l’aria era fredda gelata; ma sotto il dente si rivelarono tiepidi. Sirio, come fa lui, intanto smuoveva la minestrina con il cucchiaio, come se avesse voluto trovarci le perle. Chiamò, poi, l’oste, e con serietà gli domandò: “Lei è un cacciatore?” L’oste rispose che non capiva e Sirio: “Perché in questo brodo ci avete certo sparato una fucilata.”
“Sarebbe a dire?”
“Sarebbe a dire che il brodo sa di fumo.” L’oste protestò, brutto: “Ma che fumo… di fumo il mio brodo?… il fumo ce l’ha lei nella testa.” E Sirio, impallidendo e alzando la voce: “Ho detto che sa di fumo e lei deve crederlo.” Brontolando, l’oste andò in cucina e riportò addirittura la pentola per farci vedere le carni con cui aveva fatto il brodo. Mentre mostrava in giro la pentola, un grido: “Ah, c’è il bacherozzo.” Ci voltammo, era Gemma, la nipote di Amilcare, che indicava qualcosa di nero tra gli spaghetti. L’oste disse: “Macché bacherozzo… sarà un pezzo di guanciale che è un po’ bruciato.” Ma Gemma insistette: “E io le dico che è un bacherozzo… guardi… con tutte le zampe.” L’oste andò a guardare e, infatti, era proprio un bacherozzo. Disse, però, prendendolo su con una forchetta: “Si sa, può essere caduto dal camino… sono cose che succedono…” e senza aggiungere altro se ne tornò in cucina con la sua pentola e il suo bacherozzo.
Ci guardammo in faccia stupiti. “Io ho fame e mangio”, disse finalmente Amilcare prendendo la forchetta. Lo imitammo, sebbene con ripugnanza. Soltanto Gemma disse che gli faceva schifo e non toccò il piatto. Faceva più freddo che mai, e dopo gli spaghetti, andammo tutti a riprenderci i cappotti e così sedemmo a tavola incappottati. Tornò l’oste e distribuì rapidamente le porzioni di pollo e di abbacchio. Il pollo era secco, un pollo da rosticceria di quarto ordine; l’abbacchio era tutto costole, pelle e grasso, per giunta riscaldato dalla mattina. Amilcare inforcò l’abbacchio sollevandolo per aria e poi gridò inviperito: “Ma questo non si può mangiare… oste, oste.” Ecco di nuovo l’oste, con la sua facciona scura, e Amilcare gli disse: “Ma lei mi vuol dire perché fa l’oste?”
“E che dovrei fare?”
“Qualsiasi altro mestiere: il tranviere, lo scopino, il beccamorto, ma non l’oste.” Insomma, nacque un battibecco, ma svogliato, perché l’oste, nella sua tetraggine, non era neppure permaloso. Poi dalla cucina si affacciò il cuoco con il suo berrettone e chiamò il padrone e questi ci lasciò. Amilcare gridò al cuoco: “Cuoco… ci hai avvelenati.” Ma il cuoco non rispose e noi riprendemmo a combattere con le coste dell’abbacchio e con le ossa del pollo.
Eravamo tutti di cattivo umore, infreddoliti peggio che se fossimo stati all’aperto, con lo stomaco pieno di robaccia mal cucinata e peggio digerita. Amilcare, che ormai si rendeva conto del suo errore, volle raddrizzare la situazione e ordinò due bottiglie di vino rosso da bere con il panettone. Furono queste le sole cose buone della serata e l’oste non ne ebbe merito, perché le bottiglie erano sigillate e il panettone veniva da Milano. Bevemmo il vino che era barbera, mangiammo il panettone e un poco ci scaldammo.
Intanto l’osteria si era vuotata e non era rimasto che un gruppo di giovanotti ad un tavolo accanto al nostro: giocavano a carte e, dopo un poco, a loro si unirono l’oste e il cuoco. Remo, che tutta la sera non aveva cessato di scherzare con Gemma, ringagliardito dal vino, propose allora di cantare. Faceva sempre così, alla frutta si offriva sempre di cantare e non dico che non cantasse bene, ma le canzoni erano sempre le stesse e noi le conoscevamo tutte. Ma lui quella sera voleva cantare per Gemma che era nuova e noi, comprendendo l’intenzione, gli dicemmo che cantasse pure.
Per capire, però, che cosa volesse dire per lui cantare, bisogna che io lo descriva: Remo è piccoletto, con la faccia bruna e accesa, la fronte bassa tutta riccioletti neri, gli occhi strizzati e iniettati di sangue. Con questa complessione un po’ brutale, Remo tuttavia, quando canta, non è mai volgare, semmai è troppo sdolcinato. Prende la mano alla ragazza, si sporge verso di lei, socchiudendo gli occhi e facendo la bocca piccola, e canta in sordina con voce appassionata, scivolosa, insinuante. Le sue canzoni, poi, hanno tutte le rime in “ore”: dolore, cuore, amore; oppure in “one”: passione, perdizione, devozione.
Basta, quella sera, come il solito, acchiappò la manuccia a Gemma e cominciò a cantarle col viso accosto al viso, mentre noi tacevamo imbarazzati, guardandolo. Gemma sorrideva, e lui incoraggiato da quel sorriso, dopo la prima canzone attaccò la seconda. Intanto, al tavolo accanto si erano azzittiti e ci guardavano; poi incominciarono a ridere tra di loro; e poi uno si mise a cantare rifacendo il verso a Remo e un altro, abbassandosi sotto la tovaglia, imitò il miagolio del gatto. Remo forse non se ne accorse o non volle accorgersene. Ma alla terza canzone, poiché quelli insistevano coi miagolii e le risate, si interruppe dicendo con dignità: “Basta, sarà meglio che smetta…”
Ma Sirio, che non c’entrava, saltò su improvvisamente: “Canta… non ti occupare di certa gente ignorante e maleducata… canta.” Subito, come ad un segnale, un biondino ricciuto, basso, con una maglia rossa che gli arrivava fino alle orecchie, si alzò e affrontò Sirio, domandando: “E chi sarebbe la gente ignorante e maleducata?” Sirio è un tipo bilioso e non ha paura di nessuno. Rispose “Voialtri.”
“Ah sì?… e perché? Siamo all’osteria… è un locale pubblico; facciamo quel che ci pare e piace.”
“E anche noi facciamo quel che ci pare e piace… e appunto diciamo che voialtri di quel tavolo siete ignoranti e maleducati.” Intanto l’oste, il cuoco e altri due si erano alzati e s’erano avvicinati anche loro. Al nostro tavolo invece, eravamo tutti restati a sedere. Il biondino disse: “Ma tu chi sei? Che vuoi? Si può sapere che vuoi?” alzando al tempo stesso la mano come per afferrare Sirio alla cravatta.
“Leva mano, leva”, gli rispose Sirio, in piedi anche lui, naso a naso, buttandogli giù la mano con una botta. Il biondino allora l’afferrò davvero per i baveri della giubba, piegandolo indietro. Le due donne cacciarono uno strillo; Remo gridò: “Ma andiamocene, che ce ne importa?” Fu un attimo. Poi in maniera imprevista, Amilcare saltò in piedi, acchiappò il biondino per la maglia, al petto, e rovinò con lui, giù giù, fino in fondo allo stanzone, menando colpi all’impazzata. Sbattuto contro la ghiacciaia; il biondino si riparava con un braccio mentre Amilcare gli stava sopra, con tutto il corpo, pestandolo. Ma, ad un tratto, vedemmo le spalle larghe di Amilcare rovesciarsi indietro e poi lo vedemmo crollare giù come un masso, supino. Il biondino, da pugilista, gli aveva tirato un colpo secco al mento, e adesso Amilcare stava disteso in terra, sopra la segatura.
Finì come doveva finire: con le guardie che prendevano i nomi; con le due donne che si lagnavano; con Amilcare che si reggeva il mento con la mano e ripeteva che lui non avrebbe cacciato un soldo; con Sirio, Remo e io che pagavamo il conto; con l’oste che ci gridava dalla cucina: “Ma che ci andate a fare nelle trattorie? Perché non restate a casa?”
Come uscimmo, poi, una finestra si aprì, e qualcuno lanciò nella strada un cartoccio di rifiuti che colpì in testa Amilcare. “Oh, scusate”, gridò una vocetta, “era per i gatti.” Di gatti, infatti, ce n’era una quantità, accoccolati sulla strada, che aspettavano che ce ne andassimo per accostarsi al cartoccio. Ma Amilcare che aveva perduto la testa, convinto, chissà perché, d’essere stato bersagliato dall’oste, voleva tornare indietro; e dovemmo portarlo via, si può dire, di peso, mentre inveiva e si ripuliva il cappello delle lische di pesce. Insomma, quello che si chiama una bella serata.