
Biografia di Eugenio Montale
28 Dicembre 2019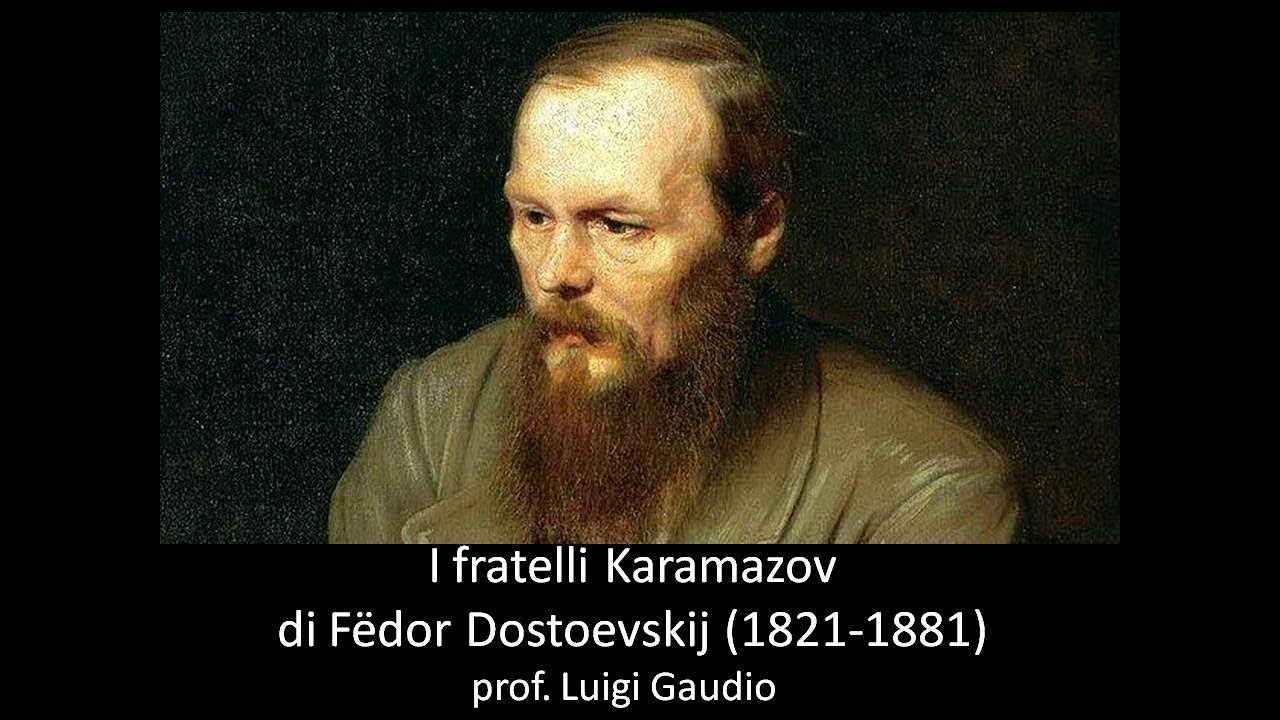
I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij
28 Dicembre 2019Testo, traduzione e analisi del brano tratto dal II libro dell’Eneide, che narra la caduta di Troia
Testo e Traduzione
|
Testo di Virgilio:
Conticuēre omnēs intentīque ōra tenēbant
inde torō pater Aenēās sīc ōrsus ab altō:Īnfandum, rēgīna, iubēs renouāre dolōrem, Trōiānās ut opēs et lāmentābile rēgnum ēruerint Danaī, quaeque ipse miserrima uīdī 5 et quōrum pars magna fuī. Quis tālia fandō Myrmidonum Dolopumue aut dūrī mīles Ulixī temperet ā lacrimīs? et iam nox ūmida caelō praecipitat suādentque cadentia sīdera somnōs. Sed sī tantus amōr cāsūs cognōscere nostrōs 10 et breuiter Trōiae suprēmum audīre labōrem, quamquam animus meminisse horret lūctūque refūgit, incipiam. Fractī bellō fātisque repūlsi ductōrēs Danaum tot iam lābentibus annīs instar montis equum diuīna Palladis arte 15 aedificant, sectāque intexunt abiete costās; uōtum prō reditū simulant; eā fāma uagātur. hūc dēlecta uirum sortītī corpora furtim īnclūdunt caecō laterī penitusque cauernās ingentīs uterumque armātō mīlite complent. 20 Est in conspectū Tenedōs, nōtissima fāma īnsula, dīues opum Priamī dum rēgna manēbant, nunc tantum sinus et statiō male fīda carīnīs: hūc sē prōuectī desertō in lītore condunt; nōs abiisse ratī et uentō petiisse Mycēnas. 25 Ergō omnīs longō soluit sē Teucria lūctū; panduntur portae, iuuat īre et Dōrica castra desertōsque uidēre locōs lītusque relictum: hīc Dolopum manus, hīc saeuus tendēbat Achilles; classibus hīc locus, hīc aciē certāre solēbant. 30 pars stupet innuptae dōnum exitiāle Mineruae et mōlem mīrāntur equī; prīmusque Thymoetes dūci intrā mūrōs hortātur et arce locārī, sīue dolō seu iam Trōiae sīc fāta ferēbant. At Capys, et quōrum melior sententia mentī, 35 aut pelagō Danaum insidiās suspectaque dōna praecipitāre iubent subiectīsque ūrere flammīs, aut terebrāre cauās uterī et temptāre latēbrās. scinditur incertum studia in contrāria uulgus.Prīmus ibi ante omnīs magnā comitante cateruā 40 Lāocoōn ardēns summā decurrit ab arce, et procul ‘Ō miserī, quae tanta insānia, ciues? Crēditis auectōs hostis? aut ūlla putātis dōna carēre dolīs Danaum? Sīc nōtus Ulixes? aut hōc inclūsī lignō occultantur Achīuī, 45 aut haec in nostrōs fabricāta est māchina mūrōs, inspectūra domōs uentūraque dēsuper urbī, aut aliquis latet error; equō nē crēdite, Teucrī. quidquid id est, timeō Danaōs et dōna ferentīs.’ Sīc fātus ualidīs ingentem uīribus hastam 50 in latus inque ferī curuam compāgibus aluum contorsit. Stetit illa tremēns, uterōque recussō insonuēre cauae gemitumque dedēre cauernae. Et, sī fāta deum, sī mens nōn laeua fuisset, impulerat ferrō Argolicās foedāre latēbras, 55 Trōiaque nunc stāret, Priamīque arx alta manēres.
|
Traduzione
1-2 Tutti tacquero e tenevano gli occhi intenti. Quindi, dal trono alto, il padre Enea così cominciò: 3-9 “O regina, mi ordini di rinnovare un dolore indicibile, come i Danai abbatterono le ricchezze troiane e il regno degno di pianto, e quali cose miserrime io stesso vidi e di cui fui gran parte. Chi, narrando tali cose, tra i Mirmidoni o i Dolopi o il soldato del duro Ulisse potrebbe trattenersi dalle lacrime? E già la notte umida dal cielo precipita e le stelle cadenti invitano al sonno. 10-13 Ma se è tanto il tuo desiderio di conoscere le nostre sventure e di ascoltare brevemente l’estrema fatica di Troia, sebbene l’animo inorridisca al ricordo e rifugga per il dolore, inizierò. Fracassati dalla guerra e respinti dal fato, 14-20 i capi dei Danai, trascorsi ormai tanti anni, con l’arte divina di Pallade, costruiscono un cavallo grande come una montagna, e ne intessono le costole con abete tagliato; simulano un voto per il ritorno; tale fama si diffonde. Qui, scelti furtivamente corpi di uomini sorteggiati, li rinchiudono nel cieco fianco e riempiono le enormi caverne e il ventre di soldati armati. 21-25 Di fronte si trova Tenedo, isola notissima per fama, ricca di beni finché i regni di Priamo duravano, ora solo una baia e un ancoraggio poco sicuro per le navi: qui, inoltrati, si nascondono su una spiaggia deserta; noi pensammo che fossero partiti e avessero raggiunto Micene con il vento. 26-31 Perciò tutta la Teucria si liberò dal lungo lutto; si aprono le porte, è piacevole andare a vedere gli accampamenti dei Greci e i luoghi deserti e la spiaggia abbandonata: qui la schiera dei Dolopi, qui il feroce Achille si accampava; qui il posto per le flotte, qui solevano combattere in schiera. Parte si stupisce del dono esiziale a Minerva non ancora sposata e ammira la mole del cavallo; e per primo Timete esorta a condurlo dentro le mura e a collocarlo sulla rocca, sia per inganno o perché già così il fato di Troia portava. 35-38 Ma Capi, e quelli che avevano un migliore senno, comandano o di gettare in mare gli inganni dei Danai e i doni sospetti e di bruciarli con fiamme appiccate, o di trapanare le cave caverne del ventre e di esplorarne i nascondigli. La folla incerta si divide in pareri contrari. 39-49 Per primo lì, prima di tutti, con una grande schiera che lo accompagnava, Laocoonte ardente accorre dalla rocca più alta, e da lontano: “O infelici cittadini, quale così grande follia? Credete che i nemici siano partiti? O pensate che qualche dono dei Danai sia privo di inganni? Così è noto Ulisse? O in questo legno sono nascosti degli Achei, o questa macchina è stata fabbricata contro le nostre mura, per spiare le case e piombare dall’alto sulla città, o qualche errore è nascosto; non fidatevi del cavallo, o Teucri. Qualunque cosa sia, temo i Danai, anche se portano doni.” 50-56 Così detto, con forze poderose scagliò l’enorme lancia contro il fianco e il ventre ricurvo dalle giunture della belva. Essa stette tremando, e, scosso il ventre, risuonarono le cave caverne ed emisero un gemito. E, se i fati degli dèi, se la mente non fosse stata ostile, egli avrebbe spinto a sfigurare con il ferro i nascondigli degli Argivi, e Troia ora starebbe ancora in piedi, e l’alta rocca di Priamo rimarrebbe. |
Analisi del Brano
Questo estratto si trova all’inizio del II libro dell’Eneide e costituisce l’esordio del racconto in prima persona di Enea rivolto a Didone, regina di Cartagine. Dopo il banchetto nel I libro, Didone chiede a Enea di narrare le sventure che lo hanno condotto sulle coste africane. Il brano è cruciale per la sua drammaticità, per l’introduzione del tema del “dolore indicibile” e per la presentazione del Cavallo di Troia, fulcro della tragedia troiana.
1. L’inizio del racconto (vv. 1-13)
- Contesto narrativo: Enea, definito “pater Aeneas” (padre Enea), si appresta a raccontare la fine della sua patria. La sua posizione “dal trono alto” (torō… ab altō) sottolinea la sua dignità regale e il peso della sua esperienza.
- Il “dolore indicibile”: L’espressione “Infandum… dolorem” (v. 3) è una chiave di lettura del tono che seguirà. Enea è profondamente segnato dagli eventi e il ricordo stesso lo fa inorridire (“animus meminisse horret lūctūque refūgit”, v. 12). Questo sottolinea la sua pietas, il senso di profondo legame con la sua patria e il suo popolo.
- Funzione proemiale: La digressione sulla notte che invita al sonno (“nox ūmida caelō praecipitat suādentque cadentia sīdera somnōs”, vv. 8-9) serve a creare un’atmosfera di attesa e di sospensione, prima di immergersi nel racconto traumatico. È una sorta di richiamo alla dimensione epica e al contempo umana del narratore.
- La retorica della domanda: Enea si chiede chi potrebbe trattenersi dalle lacrime (“Quis tālia fandō… temperet ā lacrimīs?”, vv. 6-8), coinvolgendo emotivamente gli ascoltatori (e quindi anche il lettore) e anticipando la commozione che il racconto susciterà.
2. La costruzione del Cavallo di Troia e l’inganno (vv. 14-25)
- L’astuzia greca: I Greci, frustrati da anni di assedio infruttuoso (“Fractī bellō fātisque repūlsi”, v. 13), ricorrono all’inganno. La costruzione del cavallo è attribuita all'”arte divina di Pallade” (Minerva), sottolineando la sua origine prodigiosa e quasi ineluttabile.
- Descrizione del cavallo: L’immagine del cavallo “instar montis” (grande come una montagna, v. 15) ne enfatizza la grandiosità e la capacità di ingannare. Il riferimento al “voto per il ritorno” (vōtum prō reditū, v. 17) è l’astuta copertura che i Greci usano.
- Tenedo: L’isola di Tenedo (vv. 21-25) assume un ruolo strategico. È il luogo dove la flotta greca si nasconde per far credere ai Troiani di aver abbandonato l’assedio. La sua descrizione, da “ricca di beni” a “solo una baia e un ancoraggio poco sicuro”, evoca la caducità delle fortune.

3. La reazione dei Troiani e le diverse opinioni (vv. 26-38)
- La gioia illusoria: La “Teucria” (Troia) si libera dal “lungo lutto” (v. 26), le porte si aprono e i Troiani curiosi escono a esplorare i campi abbandonati. Questa scena di sollievo e scoperta è intrisa di ironia tragica, poiché precede l’imminente distruzione.
- Le due fazioni: La folla troiana si divide tra chi, come Timete, propone di introdurre il cavallo in città (v. 32-34) e chi, come Capi, è più cauto e sospetta l’inganno (vv. 35-38). Questa divisione riflette il dibattito interno e la vulnerabilità dei Troiani di fronte a un inganno così ben congegnato. Il “fatum” (fato) è già qui presente come forza ineluttabile che spinge Timete a un’azione sconsiderata.
4. L’intervento di Laocoonte (vv. 39-56)
- La figura di Laocoonte: Il sacerdote Laocoonte emerge come la voce della ragione e della prudenza. La sua discesa “ardente” dalla rocca (“ardēns summā decurrit ab arce”, v. 40) denota la sua urgenza e la sua passione nel tentare di salvare la città.
- Il discorso profetico: Le sue parole sono un monito accorato: “Ō miserī, quae tanta insānia, ciues?” (O infelici, quale così grande follia, v. 41). La sua celebre frase “timeō Danaōs et dōna ferentīs” (temo i Danai, anche se portano doni, v. 49) è diventata un adagio proverbiale e sintetizza l’essenza dell’inganno e della sua diffidenza.
- Il gesto e le conseguenze: Il gesto di Laocoonte che scaglia l’asta contro il fianco del cavallo (vv. 50-53) è un tentativo disperato di smascherare l’inganno. Il suono metallico (“insonuēre cauae gemitumque dedēre cauernae”, v. 53) è il primo segno fisico che il cavallo è cavo e nasconde qualcosa.
- Il destino ineluttabile: I versi finali (“Et, sī fāta deum, sī mens nōn laeua fuisset…”, vv. 54-56) sottolineano il concetto del fato come forza superiore e implacabile. Se solo la volontà divina non fosse stata avversa, o la mente dei Troiani non fosse stata “ostile” (laeva), il gesto di Laocoonte avrebbe potuto salvare Troia. Ma il destino di Troia era già segnato, rendendo vano ogni tentativo di opposizione. Questa è una delle manifestazioni più chiare del pessimismo storico di Virgilio, dove il fato è una forza dominante e spesso imperscrutabile.

In sintesi, questo brano è un capolavoro di narrazione epica, che mescola suspense, pathos e un profondo senso di fatalismo. Virgilio abilmente costruisce la tensione attraverso le diverse reazioni dei Troiani e il presagio inascoltato di Laocoonte, culminando nella premonizione dell’ineluttabile distruzione.





