
Gloria del disteso mezzogiorno, Casa sul mare e Dora Markus di Montale
28 Dicembre 2019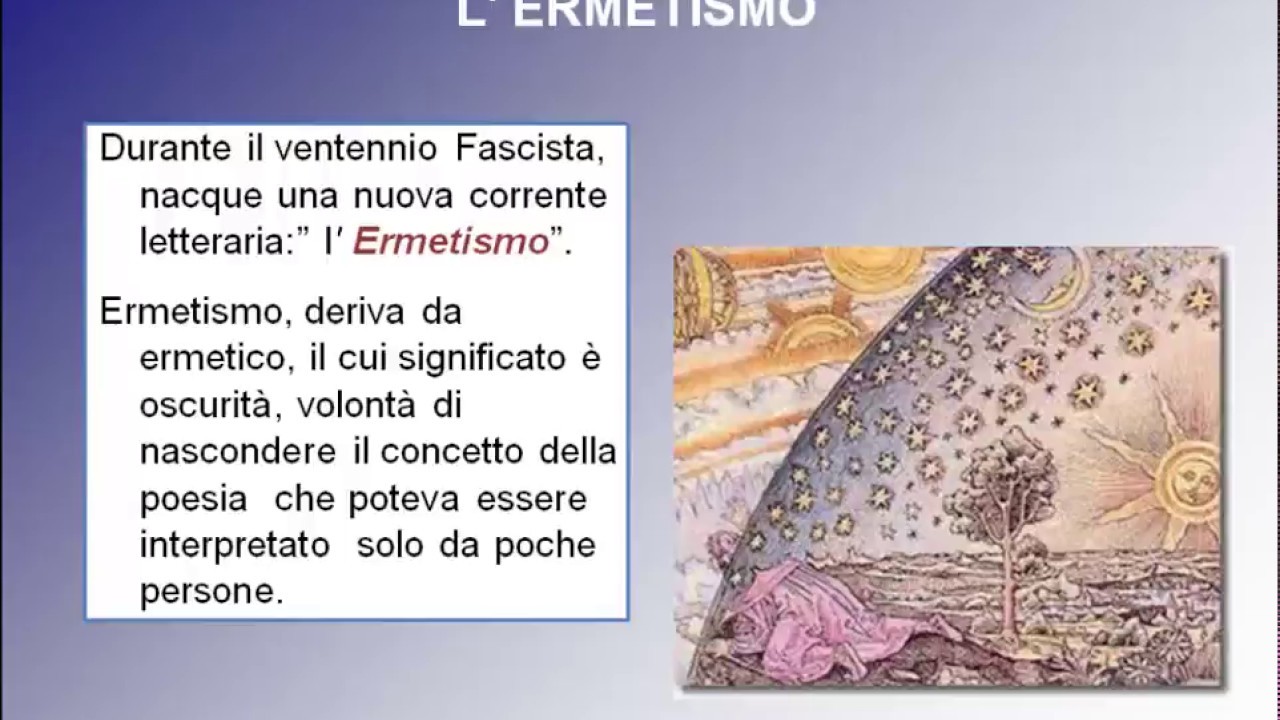
La poesia “La preghiera” in Sentimento del tempo di Giuseppe Ungaretti
28 Dicembre 2019La novella “La carriola” di Luigi Pirandello, inclusa nella raccolta Novelle per un anno , è una delle opere più significative e rappresentative dello scrittore siciliano.
Questa storia esplora temi centrali della narrativa pirandelliana, come l’identità, il conflitto tra apparenza e realtà, e la crisi dell’individuo in un contesto sociale rigido e oppressivo.
Pubblicata per la prima volta nel 1921, questa storia esplora temi pirandelliani classici come l’identità, il conflitto tra apparenza e realtà, e la ricerca di senso in un mondo dominato dalle convenzioni sociali. Tuttavia, questa versione rivela un aspetto particolare e inquietante della vicenda: il protagonista, un professore stimato e avvocato, vive una ribellione interiore segreta e apparentemente futile, espressa attraverso un gesto bizzarro e privato, quello di fare “la carriola” con la sua cagna Lupetta.
Di seguito, analizzerò il testo in modo approfondito, concentrandomi sui temi, i simboli e il significato del racconto.
Trama e contesto
Il protagonista della novella è un uomo rispettato, un professore universitario e avvocato, che incarna l’autorità e la dignità sociale. La sua vita è governata da rigide convenzioni e dall’aspettativa di mantenere un’immagine pubblica austera e impeccabile. Tuttavia, in privato, egli vive un profondo conflitto interiore, espresso attraverso un gesto strano e apparentemente insignificante: ogni giorno, nel massimo segreto, solleva la sua cagna Lupetta e la fa camminare sulle zampe anteriori (un gioco chiamato “fare la carriola”).
Questo gesto, descritto dal protagonista come un atto di “divina follia”, rappresenta un momento di liberazione personale, in cui egli si sente finalmente libero dalle pressioni sociali. Tuttavia, il significato profondo di questo comportamento è ambiguo e contraddittorio. Mentre il protagonista cerca di convincersi che si tratta di un atto innocente e privo di conseguenze, la reazione della cagna Lupetta – che lo guarda con occhi terrorizzati – suggerisce che il gesto ha implicazioni ben più profonde e inquietanti.
Temi principali
1. L’apparenza e la realtà
Il protagonista è un uomo diviso tra due identità: quella pubblica, austera e rispettabile, e quella privata, segreta e irrazionale. Nella sfera pubblica, egli mantiene un’immagine di autorità e saggezza, incarnata dai suoi titoli accademici e professionali incisi sulla porta di casa (“preceduti dai miei titoli e seguiti dai miei attributi scientifici e professionali”). Tuttavia, in privato, egli si abbandona a un comportamento eccentrico e infantile, che contrasta nettamente con la sua immagine ufficiale.
Questo dualismo riflette uno dei temi centrali della narrativa pirandelliana: il conflitto tra ciò che appare e ciò che realmente è. Il protagonista è costretto a vivere una doppia vita, nascondendo la sua vera natura dietro una maschera di formalità.
2. La crisi dell’identità
Il protagonista vive una crisi profonda legata alla sua identità. Egli sembra consapevole di essere prigioniero delle convenzioni sociali, ma non riesce a liberarsene completamente. Il gesto di “fare la carriola” con Lupetta rappresenta un tentativo di sfuggire a questa prigione, ma è un tentativo fallimentare, perché il protagonista non riesce a superare le sue stesse paure e contraddizioni.
Il momento culminante della crisi si verifica quando il protagonista, tornando a casa, vede “da fuori” se stesso e la sua vita, ma non riesce a riconoscersi. Questa scissione tra il sé interiore e il sé esteriore è tipica della condizione umana pirandelliana, in cui l’individuo è sempre diviso tra ciò che vuole essere e ciò che gli altri si aspettano che sia.
3. La solitudine dell’individuo
Nonostante la sua posizione sociale elevata, il protagonista è profondamente solo. Nessuno conosce il suo segreto, nemmeno i suoi familiari. La sua ribellione contro le convenzioni sociali è privata e meschina, incapace di tradursi in un cambiamento reale. Anche la sua relazione con Lupetta è distorta: egli cerca conforto in un animale, ma finisce per terrorizzarla con il suo comportamento.
4. Il senso di colpa e l’incomprensione
La reazione della cagna Lupetta – che lo guarda con occhi “appannati” e “sbarrati dal terrore” – suggerisce che il protagonista è consapevole del carattere inquietante del suo gesto. Egli vorrebbe convincerla che non è nulla di grave, ma la bestia “comprende” la terribilità dell’atto. Questo dettaglio mette in evidenza il senso di colpa del protagonista, che non riesce a giustificare nemmeno a se stesso il significato del suo comportamento.
Simbolismo della “carriola”
Il gesto di “fare la carriola” con Lupetta è ricco di significati simbolici:
- Libertà individuale : Per il protagonista, il gesto rappresenta un momento di liberazione dalla rigidità sociale. Tuttavia, questa libertà è illusoria, perché il protagonista rimane prigioniero delle sue stesse paure.
- Follia e razionalità : Il protagonista descrive il gesto come un atto di “cosciente follia”. Questo paradosso riflette il conflitto tra la sua razionalità professionale e il bisogno di esprimere il suo lato irrazionale.
- Infantilismo e regressione : Il gesto infantile di giocare con la cagna suggerisce una regressione psicologica, un ritorno a uno stato di innocenza e spontaneità che il protagonista non riesce a vivere pienamente.
Analisi del finale
Il finale della novella è particolarmente significativo. Dopo aver compiuto il gesto, il protagonista ritorna immediatamente alla sua vita di prima, pronto a ricevere i clienti con “l’austera dignità di prima”. Questo ritorno all’ordine suggerisce che il suo tentativo di ribellione è stato inefficace: egli non riesce a liberarsi delle convenzioni sociali e torna a recitare il ruolo che gli è stato imposto.
La reazione di Lupetta – che continua a guardarlo con terrore – mette in luce l’ambiguità del gesto. Sebbene il protagonista cerchi di minimizzarne l’importanza, il gesto rivela qualcosa di profondamente inquietante, forse legato al senso di colpa o alla consapevolezza della propria ipocrisia.
Conclusione
“La carriola” è una novella emblematica della produzione pirandelliana, che esplora temi universali come l’identità, la solitudine e il conflitto tra apparenza e realtà. Attraverso il gesto apparentemente banale di “fare la carriola” con una cagna, Pirandello mette in luce la fragilità dell’individuo moderno, costretto a vivere una doppia vita e incapace di trovare una vera liberazione.
Riassumendo: “La carriola” di Luigi Pirandello è una riflessione profonda sul conflitto tra apparenza e realtà, simboleggiato dal gesto bizzarro e segreto del protagonista. Attraverso questo racconto, Pirandello critica le convenzioni sociali e mette in luce la difficoltà di rimanere autentici in un mondo dominato dalle maschere.
📖 Brani significativi della novella “La carriola” del 1921 (Luigi Pirandello)
Il professore stimato di diritto, avvocato, mentre sta viaggiando in treno (un evento come per Belluca) riconosce l’oltre nella sua vita. Tuttavia la sua ribellione non diventa pubblica, come quella di Belluca, ma meschinamente privata, con la cagna Lupetta. Si ferma a vedere il suo nome e cognome incisi sulla porta, ma come Mattia, rientra nella vita di prima.
La carriola – inizio
Quand’ho qualcuno attorno, non la guardo mai; ma sento che mi guarda lei, mi guarda, mi guarda senza staccarmi un momento gli occhi d’addosso. Vorrei farle intendere, a quattr’occhi, che non è nulla; che stia tranquilla; che non potevo permettermi con altri questo breve atto, che per lei non ha alcuna importanza e per me è tutto. Lo compio ogni giorno al momento opportuno, nel massimo segreto, con spaventosa gioja, perché vi assaporo, tremando, la voluttà d’una divina, cosciente follia, che per un attimo mi libera
La carriola – a metà
Con quest’animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m’attendeva all’uscita, e m’avviai per ritornare a casa.
Ebbene, fu nella scala della mia casa; fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta.
Io vidi a un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale, d’ottone, su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito da’ miei attributi scientifici e professionali, vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscerla come mia.
La carriola – finale
piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola: le faccio muovere cioè otto o dieci passi, non più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro.
Questo è tutto. Non faccio altro. Corro subito a riaprire l’uscio adagio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l’austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile.
Ma, ecco, la bestia, da quindici giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere – ripeto – che non è nulla; che stia tranquilla, che non mi guardi cosí.
Comprende, la bestia, la terribilità dell’atto che compio.
Non sarebbe nulla, se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa ch’io non posso scherzare; non le è possibile ammettere che io scherzi, per un momento solo; e séguita maledettamente a guardarmi, atterrita.





