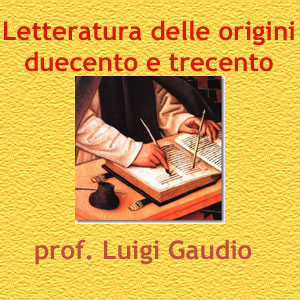Coro San Francesco ad Arezzo affrescato da Piero della Francesca
28 Dicembre 2019
Il castello di Franz Kafka
28 Dicembre 2019La Lirica del Duecento in Toscana ed Emilia prima del Dolce Stil Novo
Il Duecento in Italia è un secolo di straordinaria fioritura letteraria, che vede il passaggio dalla poesia di corte alla lirica comunale e l’emergere di nuove sensibilità e forme espressive. In Toscana ed Emilia, prima dell’affermazione del “Dolce Stil Novo”, si sviluppa una produzione lirica fondamentale che getta le basi per i successivi sviluppi, pur mantenendo caratteristiche proprie. Questa fase è dominata da figure come Guittone d’Arezzo e i Siculo-Toscani, e da precursori come Guido Guinizzelli in Emilia.
1. Il Contesto: Dalla Sicilia ai Comuni
La lirica italiana del Duecento nasce dall’imitazione della Scuola Siciliana di Federico II, che per prima aveva elaborato una poesia d’amore in volgare italiano (il siciliano illustre). Con la fine della dinastia sveva (metà del XIII secolo), i manoscritti siciliani si diffondonero in Italia centrale, in particolare in Toscana, dove furono copiati e rielaborati da notai, mercanti e intellettuali dei nascenti Comuni. Questo passaggio dalla corte all’ambiente comunale porta a significative trasformazioni nei temi e nello stile.
2. La Lirica Siculo-Toscana (o Guittoniana): Complessità e Impegno
La corrente più rappresentativa di questo periodo è quella dei Siculo-Toscani, il cui caposcuola indiscusso è Guittone d’Arezzo (c. 1235-1294).
- Guittone d’Arezzo:
- Contesto: Guittone è una figura di spicco, inizialmente dedito a una poesia d’amore cortese, ma poi convertitosi a una vita religiosa e fondando l’ordine dei Frati Gaudenti. Questa conversione influenzerà profondamente la sua produzione successiva.
- Caratteristiche Stilistiche (“Trobar Clus” e Retorica): La sua poesia è caratterizzata da una notevole complessità formale e retorica. Guittone adotta il “trobar clus” (trovare chiuso), uno stile ermetico e difficile, ricco di artifici retorici (allitterazioni, figure etimologiche, antitesi, iperbati), latinismi e provenzalismi. La sintassi è spesso contorta e il lessico ricercato. L’obiettivo è mostrare la virtuosità del poeta e stimolare l’intelletto del lettore.
- Temi:
- Amore: Inizialmente, canta un amore cortese, ma spesso con toni più aspri e meno idealizzati rispetto ai provenzali. Dopo la conversione, l’amore assume una dimensione più etica e morale, criticando la vanità delle passioni terrene.
- Politica e Morale: Guittone è il primo a introdurre in modo significativo temi politici e morali nella lirica italiana. Celebre è la sua canzone Ahi lasso, or è stagion de doler tanto, in cui lamenta la sconfitta di Firenze nella battaglia di Montaperti (1260) e la decadenza morale delle città. La sua poesia diventa uno strumento di riflessione etica e di denuncia sociale.
- Lingua: Utilizza il volgare toscano, ma lo arricchisce con elementi siciliani e latini, contribuendo alla creazione di una lingua poetica più elaborata.
- Altri Siculo-Toscani (o Guittoniani): Molti poeti toscani e di altre regioni centrali seguirono l’esempio di Guittone, imitandone lo stile complesso e i temi. Tra i più noti:
- Bonagiunta Orbicciani da Lucca: Meno innovativo di Guittone, ma importante per la diffusione dello stile. È il poeta che Dante Alighieri, nel Purgatorio (Canto XXIV), indica come rappresentante della poesia “vecchia” rispetto al “Dolce Stil Novo”.
- Chiaro Davanzati da Firenze: Anche lui influenzato da Guittone, ma con una maggiore attenzione alla musicalità e a volte a temi più leggeri.
3. Guido Guinizzelli e la Lirica Emiliana: Il Precursore dello Stil Novo
In Emilia, e in particolare a Bologna, città universitaria e centro di vivaci scambi culturali, si sviluppa una lirica che, pur cronologicamente precedente o contemporanea ai primi Stilnovisti, presenta elementi di forte innovazione rispetto a Guittone, tanto da essere considerato il padre del Dolce Stil Novo.
- Guido Guinizzelli (c. 1230-1276):
- Contesto: Giurista e giudice bolognese, Guinizzelli è immerso in un ambiente intellettuale e filosofico che influenzerà la sua concezione dell’amore.
- Caratteristiche Stilistiche: Sebbene non ancora pienamente “dolce” e “nuovo” come lo stile di Cavalcanti e Dante, Guinizzelli abbandona la complessità retorica guittoniana a favore di una maggiore chiarezza e linearità. Il suo linguaggio è più raffinato e meno artificioso.
- Temi: Amore e “Gentilezza” (Nobiltà d’Animo): Il suo contributo più rivoluzionario è la teorizzazione del concetto di “amore-gentilezza”. Nella celebre canzone Al cor gentil rempaira sempre amore, egli afferma che l’amore risiede solo nel “cuore gentile”, inteso non come nobiltà di sangue, ma come nobiltà d’animo, virtù intellettuale e morale. L’amore è un’esperienza spirituale che eleva l’uomo e lo rende capace di comprendere le cose più alte. La donna amata (spesso una “donna-angelo”) è mediatrice tra l’uomo e Dio, capace di nobilitare l’animo di chi la contempla.
- Influenza Filosofica: La sua poesia risente dell’influenza della filosofia scolastica e della filosofia naturale, in particolare aristotelica, che gli permette di elaborare una concezione dell’amore più astratta e intellettuale.
- Ruolo di Precursore: Dante stesso riconoscerà Guinizzelli come suo “padre” poetico, indicandolo come colui che ha dato il via alla “nuova rima”. La sua visione dell’amore e della donna, e la sua ricerca di una lingua più “illustre” e meno “municipale”, apriranno la strada al Dolce Stil Novo.
- Altri Emiliani: La produzione lirica emiliana di questo periodo è meno vasta e meno caratterizzata da figure distinte al di fuori di Guinizzelli. Spesso i poeti minori emiliani si muovono tra l’influenza siciliana e quella guittoniana, senza raggiungere l’originalità di Guinizzelli. La sua figura è talmente dominante da assorbire gran parte dell’attenzione per la lirica emiliana pre-stilnovista.
Conclusione
La lirica del Duecento in Toscana ed Emilia, prima del Dolce Stil Novo, rappresenta un periodo di transizione e sperimentazione cruciale. Da un lato, i Siculo-Toscani di Guittone d’Arezzo elaborano uno stile complesso e impegnato, introducendo temi politici e morali e mostrando una grande consapevolezza retorica. Dall’altro, Guido Guinizzelli in Emilia, pur non essendo ancora pienamente uno stilnovista, anticipa le tematiche centrali del movimento successivo, in particolare la connessione tra amore e nobiltà d’animo, e una maggiore raffinatezza linguistica. Questo periodo, quindi, non è solo un ponte, ma un terreno fertile di innovazioni che prepareranno il terreno per l’età d’oro della lirica italiana con Dante, Cavalcanti e Petrarca.
🎤🎧 Audio Lezioni, ascolta il podcast sulla Letteratura del novecento del prof. Gaudio