
Biografia di Eugenio Montale
28 Dicembre 2019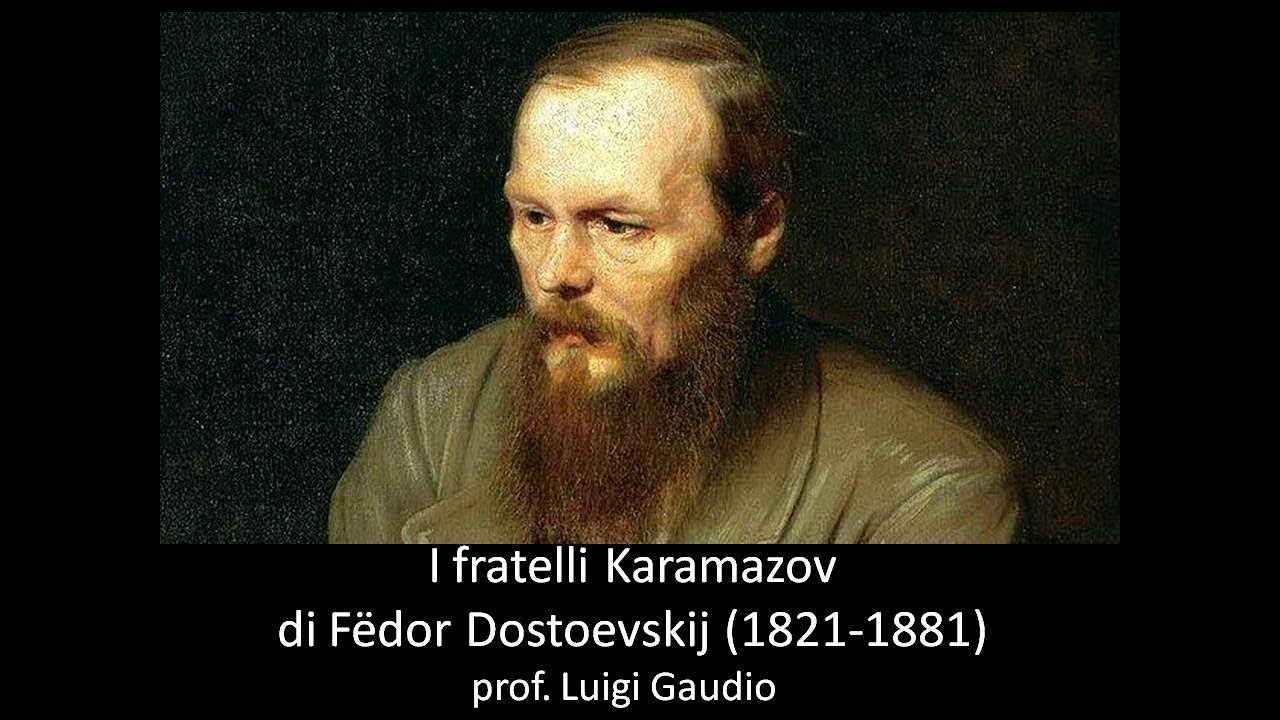
I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij
28 Dicembre 2019“La mia sera” è una delle liriche più celebri e rappresentative di Giovanni Pascoli (1855-1912), inclusa nella raccolta Canti di Castelvecchio (1907).
Questa poesia incarna pienamente la poetica pascoliana, caratterizzata dall’attenzione alla natura, dal simbolismo, dall’uso delle onomatopee e dalla profonda malinconia che si cela dietro la rappresentazione del mondo infantile e domestico. Il componimento è una meditazione sul contrasto tra la violenza del giorno e la quiete della sera, che si trasforma in una riflessione sulla vita, la morte e il ritorno all’innocenza.
Analisi della Poesia
“La mia sera” si articola in cinque strofe di ottonari, con rime alternate (ABAB), e presenta un’alternanza tra la descrizione del paesaggio naturale e l’introspezione del poeta.
Strofa 1: Il Contrasto Giorno/Sera La poesia si apre con un netto contrasto tra il “giorno fu pieno di lampi” (simbolo della violenza, del dolore, delle fatiche della vita) e la quiete imminente della sera. L’arrivo delle “tacite stelle” e il “breve gre gre di ranelle” introducono un’atmosfera di pace e serenità. L’onomatopea “gre gre” è un tipico elemento pascoliano che riproduce i suoni della natura, rendendoli vivi e quasi misteriosi. Le “tremule foglie dei pioppi” che sentono una “gioia leggiera” suggeriscono una delicatezza e una sensibilità quasi fanciullesca nel percepire la natura. La strofa si chiude con l’esclamazione “Che pace, la sera!”, che sintetizza il tema principale.
Strofa 2: La Trasformazione del Tumulto Il cielo si fa “tenero e vivo” con l’aprirsi delle stelle. Il “singhiozza monotono un rivo” è un’altra onomatopea che, pur evocando un suono malinconico, si contrappone al “cupo tumulto” e all'”aspra bufera” del giorno. Il dolore del giorno non è svanito del tutto, ma si è trasformato in un “dolce singulto”, un lamento attenuato che si confonde con l’umidità e la quiete della sera.
Strofa 3: La Bellezza Residua del Dolore La “infinita tempesta” del giorno è ora “finita in un rivo canoro”, un’immagine che suggerisce la purificazione e la trasformazione del dolore in armonia. I “fulmini fragili” (un ossimoro che unisce la potenza distruttiva alla delicatezza dei resti) lasciano dietro di sé “cirri di porpora e d’oro”, nuvole colorate dal tramonto. Questo è un momento di sublime bellezza, in cui la sofferenza passata si sublima in un’immagine estetica. Il poeta invita il proprio “stanco dolore” a riposare, trovando pace nella visione della nube che, da “nera” nel giorno, si fa “rosa” nell'”ultima sera”, metafora della morte come momento di serenità e bellezza.
Strofa 4: La Vita che Resiste e la Malattia del Poeta La scena si anima con i “voli di rondini” e i “gridi nell’aria serena”. Le rondini, simbolo di vita e di ritorno, prolungano la loro “garrula cena” per la “fame del povero giorno”. Pascoli qui introduce una nota personale: “La parte, sì piccola, i nidi / nel giorno non l’ebbero intera. / Nè io…”. Il poeta si identifica con i nidi che non hanno avuto la loro piena parte di vita e di gioia durante il giorno. Questa strofa, pur descrivendo la vitalità degli uccelli, rivela la profonda malinconia del poeta, la sua sensazione di incompletezza e di sofferenza non appagata. L’esclamazione “mia limpida sera!” è un’accettazione di questa condizione, una sorta di resa serena.
Strofa 5: Il Ritorno all’Infanzia e il “Nulla” Finale La strofa finale è la più toccante e simbolica. Il suono delle campane (“Don… Don…”) si trasforma in un coro di voci che invitano al sonno: “Dormi! mi cantano, Dormi! sussurrano, / Dormi! bisbigliano, Dormi!”. Queste “voci di tenebra azzurra” (un altro ossimoro che unisce l’oscurità della notte al colore del cielo) richiamano i “canti di culla”. Il poeta regredisce all’infanzia, a un tempo di innocenza e protezione, quando “sentivo mia madre…”. L’immagine della madre è centrale nella poetica pascoliana, simbolo del “nido” familiare perduto e della fragilità della vita. La poesia si chiude con il “poi nulla… / sul far della sera”, un verso che suggerisce non solo l’addormentarsi, ma anche l’accettazione della morte come un ritorno al nulla primordiale, una pace definitiva dopo la tempesta della vita.
Temi Principali:
- Contrasto Giorno/Sera: Il giorno come metafora della vita, delle sue fatiche e dei suoi dolori; la sera come metafora della pace, del riposo e della morte.
- Il Nido e l’Infanzia: Il richiamo alla madre e ai canti di culla evoca il tema del nido familiare, luogo di protezione e innocenza perduta.
- La Morte come Quiete: La sera e il sonno sono metafore della morte, vista non con terrore, ma come un approdo sereno, un ritorno al “nulla” che è anche pace.
- La Natura come Specchio dell’Animo: Gli elementi naturali (lampi, stelle, ranelle, rivo, rondini, nuvole) riflettono gli stati d’animo del poeta e assumono valenze simboliche.
- Onomatopee e Fonosimbolismo: L’uso di suoni (“gre gre”, “singhiozza”, “Don… Don…”) contribuisce a creare un’atmosfera suggestiva e a rendere la natura “parlante”.
- Il Fanciullino: La capacità di Pascoli di percepire il mondo con la sensibilità e la meraviglia di un bambino, anche di fronte al dolore e alla morte.
Stile e Linguaggio: Pascoli utilizza un linguaggio apparentemente semplice e colloquiale, ma ricco di sfumature e di significati nascosti. La sintassi è piana, ma la densità delle immagini e dei simboli è elevata. Il ritmo è musicale, quasi una ninna nanna, soprattutto nell’ultima strofa. L’uso di figure retoriche come l’ossimoro (“tacite stelle”, “dolce singulto”, “fulmini fragili”, “tenebra azzurra”) e la personificazione (“rivo singhiozza”, “nube rosa”) arricchisce il testo di suggestioni.
Conclusione
“La mia sera” è una poesia che, con la sua delicatezza e profondità, offre una delle più commoventi meditazioni pascoliane sulla vita e sulla morte. Il contrasto tra la violenza del giorno e la quiete della sera diventa una metafora universale del passaggio dall’esistenza terrena al riposo eterno. Attraverso immagini naturali e suoni evocativi, Pascoli ci conduce in un viaggio interiore che culmina nel ritorno all’innocenza infantile e nell’accettazione serena del “nulla”, inteso come pace finale. È un capolavoro di lirismo che continua a toccare le corde più intime dell’animo umano.

Testo della poesia La mia sera di Giovanni Pascoli, da Canti di Castelvecchio (1907)
LA MIA SERA
Il giorno fu pieno di lampi;
ma ora verranno le stelle,
le tacite stelle. Nei campi
c’è un breve gre gre di ranelle.
Le tremule foglie dei pioppi 5
trascorre una gioia leggiera.
Nel giorno, che lampi! che scoppi!
Che pace, la sera!
Si devono aprire le stelle
nel cielo sì tenero e vivo. 10
Là, presso le allegre ranelle,
singhiozza monotono un rivo.
Di tutto quel cupo tumulto,
di tutta quell’aspra bufera,
non resta che un dolce singulto 15
nell’umida sera.
È, quella infinita tempesta,
finita in un rivo canoro.
Dei fulmini fragili restano
cirri di porpora e d’oro. 20
O stanco dolore, riposa!
La nube nel giorno più nera
fu quella che vedo più rosa
nell’ultima sera.
Che voli di rondini intorno! 25
che gridi nell’aria serena!
La fame del povero giorno
prolunga la garrula cena.
La parte, sì piccola, i nidi
nel giorno non l’ebbero intera. 30
Nè io… e che voli, che gridi,
mia limpida sera!
Don… Don… E mi dicono, Dormi!
mi cantano, Dormi! sussurrano,
Dormi! bisbigliano, Dormi! 35
là, voci di tenebra azzurra…
Mi sembrano canti di culla,
che fanno ch’io torni com’era…
sentivo mia madre… poi nulla…
sul far della sera. 40





