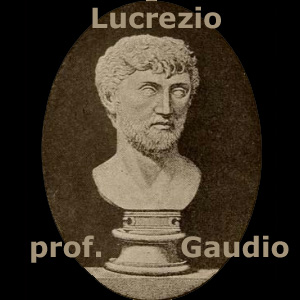
La passione d’amore dal De rerum natura di Lucrezio IV 1129-1140
28 Dicembre 2019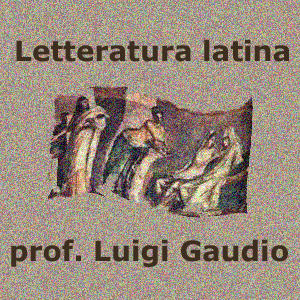
Testimonianze poetiche preletterarie in latino
28 Dicembre 2019Testo, traduzione e analisi di un testo di Lucrezio: La Passione d’Amore (De Rerum Natura, Libro IV, vv. 1121-1140)
Questo brano fa parte del IV libro del De Rerum Natura, l’opera didascalica di Tito Lucrezio Caro, che espone la filosofia epicurea. In questa sezione, Lucrezio affronta il tema dell’amore e della passione sensuale, descrivendone gli aspetti negativi e le illusioni, in linea con il precetto epicureo di evitare le passioni che turbano la atarassia (l’imperturbabilità dell’anima). Il poeta dipinge un quadro crudo e disincantato degli effetti devastanti dell’amore ossessivo.
1. Testo Latino e Traduzione Italiana
| Lucrezio, De Rerum Natura, Libro IV, vv. 1121-1140
Adde quod absumunt viris pereuntque labore, 1121
adde quod alterius sub nutu degitur aetas, languent officia atque aegrotat fama vacillans. Labitur interea res et Babylonia fiunt unguenta et pulchra in pedibus Sicyonia rident, 1125 scilicet et grandes viridi cum luce zmaragdi auro includuntur teriturque thalassina vestis adsidue et Veneris sudorem exercita potat. Et bene parta patrum fiunt anademata, mitrae, inter dum in pallam atque Alidensia Ciaque vertunt. Eximia veste et victu convivia, ludi, 1131 pocula crebra, unguenta, coronae, serta parantur, ne quiquam, quoniam medio de fonte leporum surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat, aut cum conscius ipse animus se forte remordet 1135 desidiose agere aetatem lustrisque perire, aut quod in ambiguo verbum iaculata reliquit, quod cupido adfixum cordi vivescit ut ignis, aut nimium iactare oculos aliumve tueri quod putat in voltuque videt vestigia risus. 1140 |
Traduzione italiana
Aggiungi che consumano le forze e si logorano per la fatica, |
2. Analisi del Brano: La Disillusione della Passione
Questo passo rientra nella sezione in cui Lucrezio, dopo aver spiegato il meccanismo della visione e della riproduzione, si dedica a confutare l’idea che l’amore passionale (inteso come furor amoris, ovvero l’amore ossessivo e totalizzante) possa portare alla felicità. Al contrario, per Lucrezio, l’amore è una fonte di sofferenza, illusione e autodistruzione, in netta contraddizione con gli ideali di atarassia (assenza di turbamento) e aponia (assenza di dolore fisico) propugnati dall’Epicureismo.
Il brano si apre con una serie di “aggiunte” (adde quod… adde quod…), un’anfora che scandisce l’accumulo di mali derivanti dalla passione:
- Consumo di Energie e Sottomissione (vv. 1121-1123): L’amore consuma le forze fisiche e mentali (absumunt viris pereuntque labore) e rende l’individuo schiavo della volontà altrui (alterius sub nutu degitur aetas). La vita dell’amante è interamente condizionata dal capriccio della persona amata. Le attività quotidiane, persino la reputazione, ne risentono gravemente (languent officia atque aegrotat fama vacillans). Qui si delinea il tema del servitium amoris, tipico dell’elegia, ma qui visto con connotazione negativa.
- Rovina Economica (vv. 1124-1132): Lucrezio descrive con vivida precisione lo sperpero di denaro a cui l’amore conduce. Il patrimonio (res) si disperde in oggetti di lusso esotici e costosissimi, acquistati per compiacere l’amante:
- unguenta Babylonia: profumi preziosi provenienti da Babilonia.
- pulchra… Sicyonia: sandali eleganti e lussuosi dalla città greca di Sicione.
- grandes… zmaragdi auro includuntur: grandi smeraldi incastonati nell’oro.
- thalassina vestis: una veste di colore verde-mare, costosa e raffinata.
- anademata, mitrae, palla, Alidensia Ciaque: diademi, turbanti, veli e tessuti preziosi provenienti da Alinda e Ceo, località famose per i loro prodotti di lusso. L’immagine della veste che “beve il sudore di Venere” (Veneris sudorem exercita potat) è quasi metaforica, indicando l’uso costante nel piacere e l’usura dovuta alla vita dissoluta. La scena dei banchetti (convivia, ludi, pocula crebra, unguenta, coronae, serta) completa il quadro di una vita di eccessi e sperpero. L’enfasi sull’origine “ben guadagnata dai padri” (bene parta patrum) sottolinea il contrasto tra la parsimonia tradizionale romana e lo spreco lussurioso dettato dalla passione.
- L’Amaro nel Piacere (Amari Aliquid) (vv. 1133-1140): Questo è il punto centrale della critica lucreziana all’amore passionale. Anche nel momento di massimo piacere, sorge sempre qualcosa di amaro (surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat). Questo concetto è uno dei più famosi del poema e sintetizza la visione epicurea del piacere: un piacere che comporta turbamento non è un vero piacere. Le cause di quest’amarezza sono molteplici:
- Rimorso della Coscienza (vv. 1135-1136): La consapevolezza di condurre una vita dissipata e di perdersi in piaceri futili (desidiose agere aetatem lustrisque perire). Questo è un chiaro richiamo alla morale epicurea che condannava l’ozio improduttivo e la dissipazione.
- Gelosia e Sospetto (vv. 1137-1140): Il sospetto, la gelosia e l’incertezza generati dalla persona amata. Una parola ambigua (ambiguo verbum iaculata) o uno sguardo di troppo verso un altro (nimium iactare oculos aliumve tueri) sono sufficienti a innescare il tormento nel cuore innamorato, che si ravviva “come fuoco” (vivescit ut ignis). L’amante vede ovunque i segni di un possibile tradimento (vestigia risus).
3. Stile e Linguaggio
- Didattismo e Persuasione: Il tono è didascalico, tipico del De Rerum Natura. L’anfora adde quod serve a accumulare prove e a persuadere il lettore sulla negatività del fenomeno.
- Realismo e Dettaglio: Lucrezio non teme di scendere nei dettagli materiali (gli unguenti, i sandali, i gioielli, le vesti), rendendo tangibile lo sperpero e la mondanità della passione.
- Immagini Forti: La veste che “beve il sudore” è un’immagine sensuale e quasi inquietante, che comunica l’intensità fisica e la dissipazione. Il “fuoco” che ravviva il tormento è una metafora classica della passione, ma qui applicata al dolore.
- Lessico: Il lessico è preciso e variegato. I termini geografici (Babylonia, Sicyonia, Alidensia, Ciaque) servono a evocare il lusso esotico e costoso.
- Pessimismo Epistemologico: L’intero brano, e in particolare la parte sull’amari aliquid, mostra il pessimismo di Lucrezio sulla capacità dell’uomo di trovare felicità nell’amore passionale, che si rivela essere una fonte inesauribile di dolore mentale. Questo è un punto chiave della sua polemica contro le illusioni e le superstizioni.
In conclusione, questo passaggio è un potente esempio di come Lucrezio, attraverso la sua poesia filosofica, demolisca l’idealizzazione dell’amore, mostrandone le conseguenze distruttive sul piano materiale, sociale, psicologico ed emotivo. L’amore passionale non porta alla serenità, ma è un inganno che conduce solo a fatica, rovina economica, rimorso e gelosia, avvelenando ogni piacere con la sua intrinseca amarezza.
Immagine di un busto di Lucrezio, il filosofo-poeta autore del De Rerum Natura.



