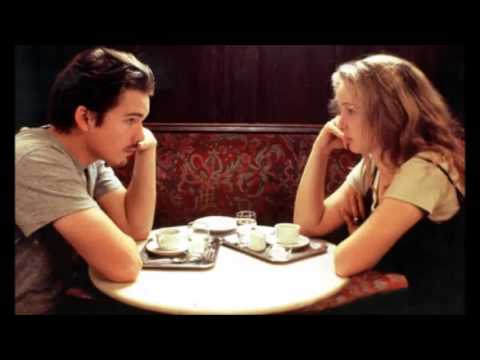
La funzione e la natura delle parole
28 Dicembre 2019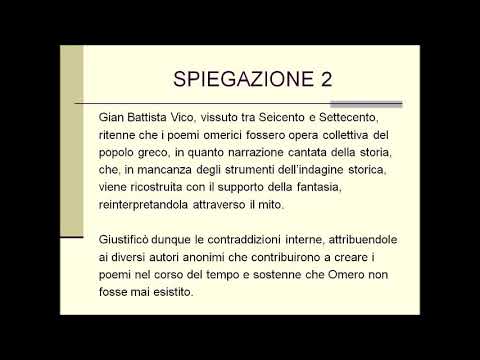
Chi era Omero
28 Dicembre 2019Nel primo Ottocento, in Italia, si sviluppa una forte tradizione di poesia dialettale, che trova i suoi due massimi esponenti in Carlo Porta (Milano) e Giuseppe Gioachino Belli (Roma).
Entrambi utilizzano il dialetto per rappresentare con realismo e ironia la vita quotidiana delle rispettive città, offrendo un ritratto autentico e spesso satirico della società del tempo.
Carlo Porta (1775-1821) e la poesia in milanese
Caratteristiche della sua poesia
- Porta scrive in dialetto milanese, lingua che usa per rappresentare la società popolare, ridicolizzando le ipocrisie e i vizi delle classi dirigenti.
- La sua poesia è fortemente realistica, con descrizioni vive e dettagliate della vita quotidiana della Milano napoleonica e asburgica.
- Usa spesso l’ironia e la satira, mettendo in ridicolo il clero corrotto, i nobili decadenti e i burocrati incapaci.
Temi principali
- Critica sociale → attacca l’ipocrisia della borghesia e del clero.
- Vita quotidiana → descrive con grande vivacità il linguaggio e i modi del popolo.
- Politica e potere → critica i governi napoleonici e austriaci.
Esempio di poesia
Uno dei componimenti più celebri è La Ninetta del Verzee, che racconta con crudele realismo la vita di una giovane prostituta.
Un altro testo famoso è La preghiera di Don Abbondio, dove Porta ridicolizza il famoso personaggio de I Promessi Sposi di Manzoni.
Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863) e la poesia in romanesco
Caratteristiche della sua poesia
- Belli scrive in dialetto romanesco, con una straordinaria capacità di riprodurre il linguaggio e le espressioni del popolo romano.
- I suoi Sonetti Romaneschi (oltre 2200 componimenti) offrono una visione spietata e ironica della società papalina del primo Ottocento.
- A differenza di Porta, Belli mostra una visione più pessimista e disincantata della società.
Temi principali
- Il popolo romano → descritto con affetto ma anche con crudezza, nei suoi pregi e difetti.
- La critica al potere → la Roma papalina è vista come arretrata, oppressiva e corrotta.
- Religione e superstizione → denuncia l’ignoranza e la superficialità con cui il popolo vive la religione.
Esempio di poesia
Uno dei suoi sonetti più famosi è Er giorno der giudizio, in cui immagina la fine del mondo vista con gli occhi di un popolano ignorante:
“Quanno che Dio farà er zignore vero,
e ne farà du’ pezzi d’ogni cosa,
allora viarzirà la terra e er mare
e tuiti li mortacci arisurghenno”
Il tono è ironico e dissacrante, con una rappresentazione grottesca del popolo e della religione.
Confronto tra Porta e Belli
| Aspetto | Carlo Porta | Giuseppe Gioachino Belli |
|---|---|---|
| Dialetto | Milanese | Romanesco |
| Tono | Ironico, satirico, vivace | Grottesco, amaro, disincantato |
| Critica sociale | Contro il clero, la burocrazia e la borghesia | Contro la società papalina e l’ignoranza |
| Visione del popolo | Affettuosa, ma anche critica | Spietata e realistica |
| Struttura poetica | Poemi e componimenti lunghi | Sonetti romaneschi (oltre 2200) |
Conclusione
Porta e Belli sono i due massimi rappresentanti della poesia dialettale dell’Ottocento. Entrambi usano il dialetto per dare voce al popolo, ma con stili e prospettive diverse:
- Porta è più ironico e vivace, con una critica sociale meno pessimista.
- Belli è più cupo e grottesco, con una visione più amara della realtà.
Entrambi, però, trasformano il dialetto in uno strumento letterario altissimo, che supera i confini della semplice poesia popolare e diventa una vera e propria denuncia sociale. 😊




