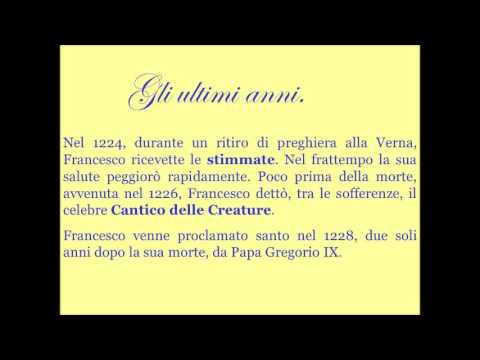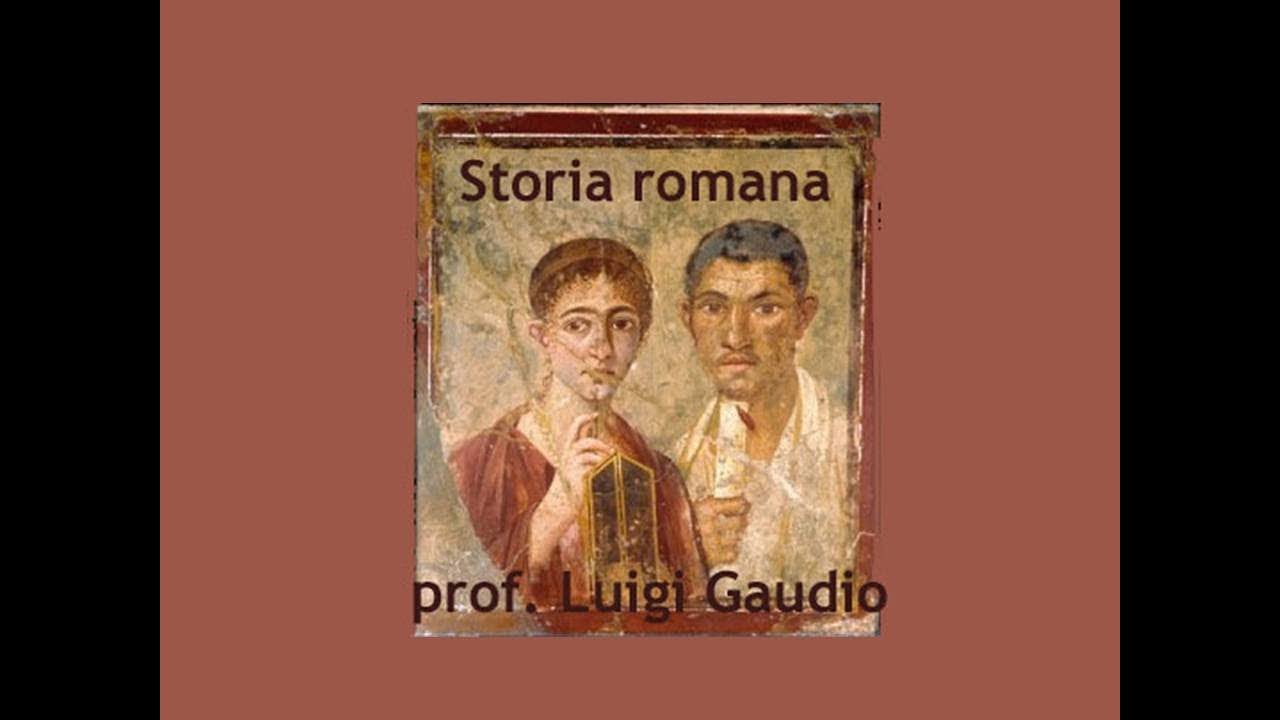
Guerre contro i Sanniti e contro Pirro
28 Dicembre 2019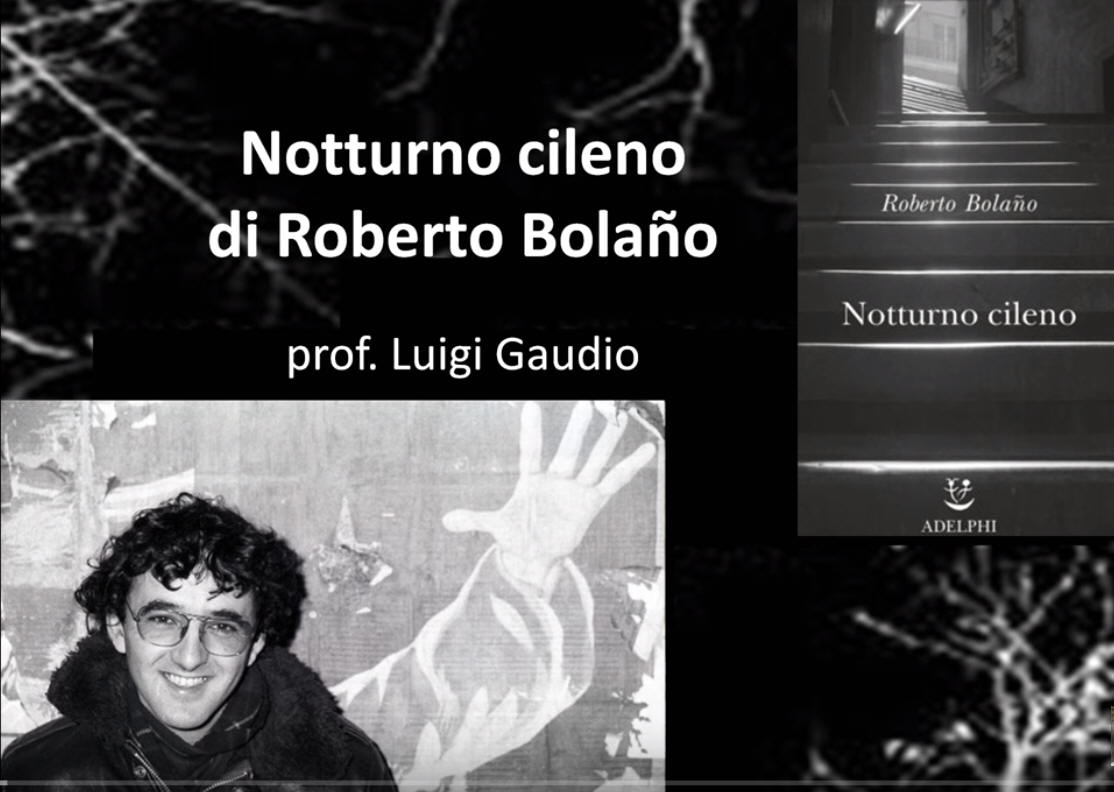
Notturno cileno di Roberto Bolano
28 Dicembre 2019La Poesia Religiosa del Duecento: Da Francesco d’Assisi a Jacopone e Oltre
Il Duecento è un secolo di straordinaria fermento spirituale in Italia, un periodo in cui la religiosità popolare e la mistica si manifestano con una forza rinnovata, influenzando profondamente anche la produzione letteraria. La poesia religiosa di questo periodo, spesso in volgare e legata a movimenti come quello francescano, si contrappone alla tradizione colta e latina, proponendo un linguaggio più diretto ed emotivo, capace di parlare al cuore della gente comune. Questo fiorire poetico getta le basi per lo sviluppo della lingua italiana e per la grande poesia dei secoli successivi.
1. San Francesco d’Assisi: Il Canto della Creazione e l’Amore per la Natura (XII-XIII Secolo)
La figura di San Francesco d’Assisi (1181/82-1226) è il punto di partenza, un innovatore assoluto. La sua spiritualità, basata sull’imitazione di Cristo, sulla povertà radicale, sull’amore per la natura e per ogni creatura, trovò espressione in un testo poetico di sconvolgente novità: il Cantico delle Creature (o Laudes Creaturarum o Cantico di Frate Sole).
- Un Inno di Lode: Scritto in volgare umbro intorno al 1224, il Cantico è un inno di lode a Dio attraverso le sue creature (“frate Sole”, “sora Luna”, “frate Vento”, “sora Acqua”, “frate Foco”, “madre Terra”). È una teofania, una manifestazione del divino nel creato, che riflette l’armonia cosmica e la fratellanza universale predicata da Francesco.
- Novità Linguistica e Tematica: La sua importanza risiede nella scelta del volgare, che lo rende accessibile a un pubblico vasto e illetterato. Il linguaggio è semplice, paratattico, con anafore che creano un ritmo incantatorio e litanico. La tematica è rivoluzionaria: non più un Dio trascendente e temibile, ma un Dio immanente, amato attraverso le meraviglie del mondo. Viene introdotta per la prima volta la lode per “sora Morte corporale”, un’accettazione serena della fine terrena.
- Impatto: Il Cantico non è solo un’opera religiosa, ma un testo fondante della letteratura italiana, per la sua originalità stilistica e la sua profonda spiritualità. Fu modello per la successiva lauda umbra.
San Francesco d’Assisi, simbolo di una spiritualità vicina alla natura.
2. Jacopone da Todi: La Misticità Radicala e la Lauda Drammatica (XIII Secolo)
Jacopone da Todi (1230 ca.-1306) è il più grande esponente della poesia religiosa duecentesca, in particolare della lauda umbra. La sua esperienza spirituale è radicale, tormentata e profondamente mistica, spesso in contrasto con le istituzioni ecclesiastiche del suo tempo. Da un’iniziale vita di agio, si convertì dopo la morte della moglie e divenne un frate francescano dell’ala più rigorista (gli Spirituali), criticando aspramente la corruzione della Chiesa.
- Il Laudario Umbro: Jacopone è l’autore di un vasto Laudario, una raccolta di circa cento laudi in volgare umbro. La lauda era un componimento religioso in versi, spesso destinato al canto durante processioni o riunioni di confraternite.
- Temi: Le sue laudi esplorano un’ampia gamma di temi:
- Contrasto Bene/Male: La lotta tra l’anima e il corpo, la condanna della vanità del mondo e delle sue seduzioni effimere (O signor, per cortesia, mandame la malsania).
- Misticismo: L’ardente desiderio di unione con Dio, spesso espresso con immagini di “follia” d’amore divino e di estasi.
- Critica Sociale e Ecclesiastica: Jacopone non esita a denunciare la corruzione del Papato (celebri le sue invettive contro Bonifacio VIII) e del clero, la simonia e la mondanizzazione della Chiesa.
- Passione di Cristo e Dolore di Maria: Molte laudi sono dedicate alla sofferenza di Cristo e al dolore straziante della Vergine ai piedi della croce (celebre è lo Stabat Mater in latino, attribuito a lui o a un suo contemporaneo, ma che riflette la sensibilità della lauda drammatica).
- Lauda Drammatica: Jacopone sviluppò in particolare la lauda drammatica, una forma dialogica che prefigura il teatro sacro medievale. I personaggi (Cristo, Maria, la Maddalena, il popolo) interagiscono, esprimendo emozioni intense e partecipando al dramma sacro. Un esempio emblematico è Donna de Paradiso, un dialogo tra un nunzio e Maria sulla passione di Cristo.
- Stile: Lo stile di Jacopone è passionale, veemente, spesso crudo e realistico. Usa un linguaggio ricco di espressioni popolari, interiezioni, esclamazioni e un lessico che unisce il sublime al grottesco, il mistico al concreto. Il suo verso è spezzato, ritmico, pensato per essere cantato e recitato con enfasi.
Jacopone da Todi, la cui poesia riflette una spiritualità intensa e una critica radicale.
3. Altri Fenomeni e Caratteristiche della Poesia Religiosa Duecentesca
Il fiorire della poesia religiosa nel Duecento non si limita a queste due grandi figure, ma è un fenomeno più ampio, legato a profondi mutamenti sociali e culturali:
- Movimenti Religiosi e Confraternite: Il Duecento è il secolo della nascita e della diffusione degli ordini mendicanti (Francescani, Domenicani) e delle confraternite di laudesi, associazioni laicali che si riunivano per praticare la devozione, cantare laudi e svolgere opere di carità. Queste confraternite furono fondamentali per la diffusione della lauda in volgare.
- Il Volgare come Lingua Sacra: La scelta del volgare, già iniziata da Francesco, divenne una prassi consolidata. Questo permise di superare la barriera linguistica del latino e di rendere il messaggio religioso accessibile a tutti, favorendo una religiosità più intima e partecipata. Il volgare, pur con inflessioni regionali (come il volgare umbro), si affermava come lingua della predicazione e della devozione.
- Temi Ricorrenti: Oltre a quelli già citati, la poesia religiosa trattava spesso:
- Vita dei Santi: Racconti agiografici in versi.
- Dottrina Morale: Esortazioni alla virtù, condanna dei vizi.
- Escatologia: La riflessione sulla morte, il giudizio universale, l’inferno e il paradiso.
- Miracoli e Visioni: Narrazioni di eventi soprannaturali e esperienze mistiche.
- Funzione: La poesia religiosa aveva una forte funzione didascalica e morale, ma anche emotiva e performativa (era spesso cantata o recitata). Non era solo lettura, ma parte integrante della pratica religiosa quotidiana.
Una confraternita medievale in processione, spesso accompagnata dal canto delle laudi.
Conclusione
La poesia religiosa del Duecento, inaugurata dal genio semplice e rivoluzionario di San Francesco e portata all’apice dalla passione tormentata di Jacopone da Todi, rappresenta un momento di rottura e di straordinaria vitalità per la cultura italiana. Essa testimonia una profonda esigenza di spiritualità e un desiderio di esprimere la fede in un linguaggio vivo e accessibile. Questo fiorire poetico in volgare non solo arricchì il panorama letterario dell’epoca, ma contribuì in modo decisivo a forgiare l’italiano come lingua letteraria, anticipando i capolavori del Trecento e oltre.
🎤🎧 Audio Lezioni di Letteratura delle origini, duecento e trecento del prof. Gaudio
Ascolta “Letteratura origini duecento e trecento” su Spreaker.