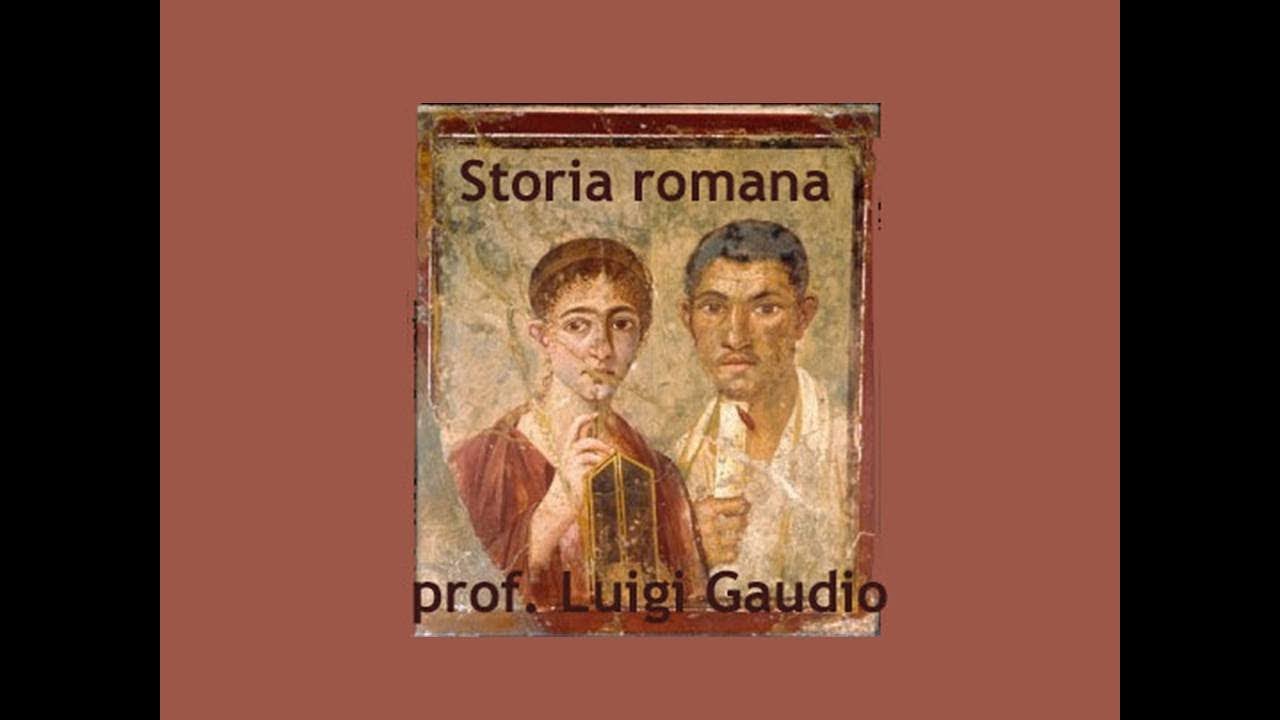Participio presente e perfetto latino
28 Dicembre 2019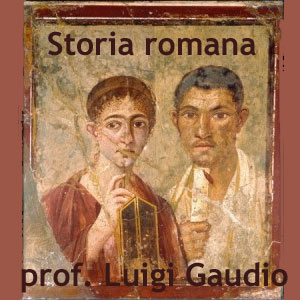
Una innovativa concezione di cittadinanza nella Antica Roma Repubblicana
28 Dicembre 2019Panoramica sulla Prima Guerra Punica (264-241 a.C.) e sulla “pace precaria” che ne seguì.
La Prima Guerra Punica fu il primo grande scontro tra due delle maggiori potenze del Mediterraneo antico: Roma e Cartagine. Non fu solo una guerra per il controllo della Sicilia, ma un conflitto per l’egemonia marittima e commerciale che avrebbe plasmato il futuro del Mediterraneo occidentale.
1. Le Cause del Conflitto: La scintilla scoppiò in Sicilia, un’isola strategica al centro del Mediterraneo, ambita da entrambe le potenze. La causa scatenante fu la richiesta d’aiuto dei Mamertini, un gruppo di mercenari campani che aveva occupato Messina e si trovava sotto la minaccia di Siracusa (alleata di Cartagine). Roma, inizialmente esitante, decise di intervenire, non tanto per i Mamertini, quanto per impedire a Cartagine di controllare lo Stretto di Messina, una posizione vitale per i suoi interessi. Questo segnò la fine della “politica delle mani libere” nel Mediterraneo e l’inizio dello scontro diretto.
2. Lo Svolgimento della Guerra: La Prima Guerra Punica fu combattuta principalmente sul mare, un ambito in cui Roma era inizialmente svantaggiata rispetto alla potente flotta cartaginese.
- La Sfida Navale Romana: I Romani, tradizionalmente potenza terrestre, si trovarono di fronte alla necessità di costruire una flotta. Con notevole ingegno, svilupparono il corvo, un ponte d’abbordaggio con un arpione, che permetteva di trasformare le battaglie navali in scontri terrestri, dove la superiorità dell’esercito romano poteva prevalere.
- Vittorie e Sconfitte: Ci furono importanti battaglie navali come quelle di Milazzo (260 a.C.), Capo Ecnomo (256 a.C.) – una delle più grandi battaglie navali dell’antichità – e delle Isole Egadi (241 a.C.). La guerra fu lunga, dispendiosa e alternò vittorie romane a gravi sconfitte (come la distruzione della flotta romana per tempeste o il fallimento della spedizione in Africa di Marco Atilio Regolo, che venne catturato e ucciso dai Cartaginesi).
- Logoramento: Entrambe le potenze subirono perdite enormi in uomini e mezzi. La perseveranza romana e la capacità di ricostruire la flotta più volte furono decisive.
3. La Conclusione e la “Pace Precária”: La guerra si concluse nel 241 a.C. con la decisiva vittoria romana alle Isole Egadi, che costrinse Cartagine alla resa. La pace impose condizioni onerose ai Cartaginesi:
- Perdita della Sicilia: Cartagine dovette abbandonare la Sicilia, che divenne la prima provincia romana (227 a.C.), segnando l’inizio dell’espansione transmarina di Roma.
- Risarcimento di Guerra: Un’ingente indennità di guerra da pagare a Roma.
- Rinuncia alla Sardegna e Corsica: Poco dopo la guerra, approfittando di una rivolta di mercenari a Cartagine, Roma impose la cessione anche di Sardegna e Corsica (237 a.C.), senza un nuovo conflitto. Questo atto fu percepito dai Cartaginesi come una profonda umiliazione e un’ulteriore ingiustizia.
Questa pace, in effetti, fu tutt’altro che duratura e serena. Fu una “pace precaria” per diverse ragioni:
- Risentimento Cartaginese: Cartagine, sebbene sconfitta, non era annientata e covava un profondo desiderio di vendetta per le perdite subite e per l’umiliazione delle cessioni post-belliche.
- Emergenza di Annibale: Figure come Amilcare Barca (che aveva combattuto in Sicilia nella Prima Guerra Punica) e in seguito suo figlio Annibale emersero come i portabandiera di questa volontà di riscatto, concentrando le energie cartaginesi sulla riconquista di una posizione dominante.
- Espansione Romana: Roma, d’altro canto, non intendeva fermare la sua espansione e vedeva in Cartagine un rivale ancora pericoloso.
- Sviluppo in Spagna: Amilcare Barca e poi Annibale iniziarono a costruire un nuovo impero cartaginese in Spagna, ricco di risorse minerarie e umane, che divenne la base per la ripresa della potenza punica.
Queste tensioni irrisolte, unite al ricordo amaro della sconfitta e delle successive imposizioni romane, prepararono il terreno per il conflitto successivo, molto più devastante: la Seconda Guerra Punica, che sarebbe esplosa di lì a poco meno di vent’anni.