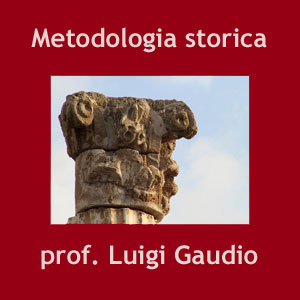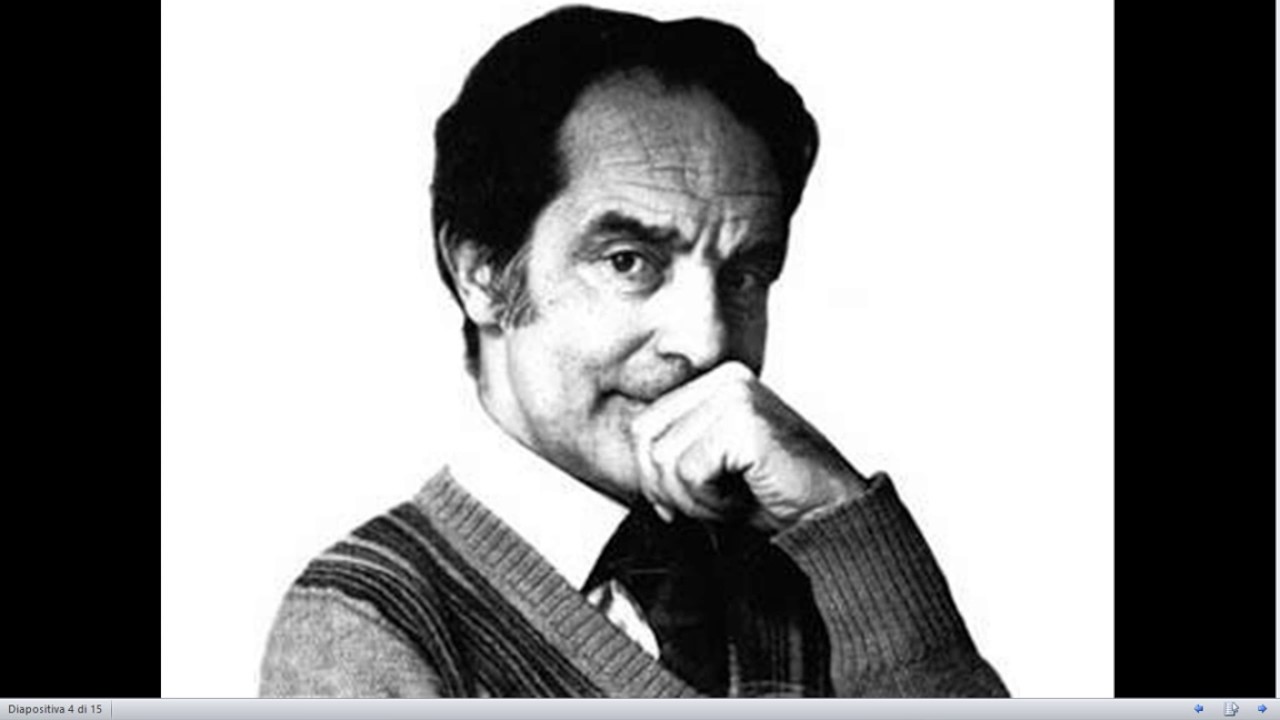
‘Perché leggere i classici’ di Italo Calvino
6 Giugno 2025
L’umanista digitale e le trasformazioni del web
6 Giugno 2025
Traccia svolta di un tema argomentativo sulla metodologia delle scienze storiche
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – PROVA DI ITALIANO – Sessione Straordinaria 2019
TRACCIA TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B2
Testo tratto da:
Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324
Testo
«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”, ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”.
Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra – dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia. Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità.»
Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie.
Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324
COMPRENSIONE E ANALISI
- Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
- Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?
- Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?
- Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)?
PRODUZIONE
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni dell’autore.
Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità).
Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso.
Sessione straordinaria 2019 Prima prova scritta
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
SVOLGIMENTO
🔍 La Storia: Una Scienza Complessa e Indispensabile
La questione se la storia possa essere annoverata tra le scienze è un dibattito antico quanto le discipline stesse. Jared Diamond, nel suo saggio Armi, acciaio e malattie, affronta questa problematica con lucidità, smontando la percezione comune che relega la storia a un mero “insieme di fatti” e argomentando con forza a favore della sua natura scientifica. Condivido pienamente la sua tesi: la storia, pur non utilizzando gli stessi metodi della fisica o della chimica, è a tutti gli effetti una scienza, una “scienza storica” nel senso allargato, che opera con metodologie rigorose, ricerca nessi causali complessi, offre forme specifiche di previsione e si confronta con una complessità inarrivabile per altre discipline.
La Controversia sulla Scientificità della Storia
La percezione che la storia non sia una scienza è radicata e pervasiva. Come evidenzia Diamond, si parla di “scienza della politica” o “scienza economica”, ma si esita ad usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici, spesso, non si considerano scienziati e raramente studiano le scienze sperimentali. Questa visione, spesso riassunta in espressioni come “la storia non è che un insieme di fatti”, deriva da una concezione ristretta di “scienza”, basata prevalentemente sul modello delle scienze esatte come la fisica. Questo modello privilegia l’esperimento controllato, la replicabilità dei fenomeni e la capacità di formulare leggi universali e previsioni deterministiche. La storia, che studia eventi unici e irripetibili, e che si basa sull’interpretazione di fonti spesso frammentarie, mal si adatta a tale paradigma, e per questo è stata, e spesso è ancora, ingiustamente sminuita. La solidarietà di Diamond con gli studenti di storia (riga 11) nasce proprio da questa consapevolezza: egli, operando nel campo della geologia e della biologia evolutiva, scienze altrettanto “storiche” nella loro metodologia, comprende la sfida e il senso di ingiustizia nel non vedere riconosciuto il proprio rigore intellettuale.
Le Quattro Caratteristiche Distintive delle Scienze Storiche
Diamond ci invita ad allargare la nostra definizione di scientia, ricordando che essa deriva dal verbo scire, ovvero conoscere, e che la conoscenza si ottiene con “metodi appropriati alle singole discipline”. Le scienze storiche, intese in questo senso più ampio (che includono astronomia, climatologia, ecologia, biologia evolutiva, geologia e paleontologia), condividono quattro caratteristiche fondamentali che le distinguono dalle scienze “esatte”, ma non le rendono meno scientifiche:
1. Metodologia: La metodologia delle scienze storiche si basa sulla ricostruzione a posteriori di eventi passati, spesso non osservabili direttamente o non riproducibili in laboratorio. Questo implica un’attenta analisi delle fonti (documenti, reperti archeologici, testimonianze orali, dati geologici o fossili), la loro critica, l’interpretazione e la comparazione. A differenza dell’esperimento controllato, il metodo storico è più simile a un’indagine forense, dove si raccolgono indizi per ricostruire una sequenza di eventi. Ad esempio, per comprendere le dinamiche di una civiltà antica, lo storico si avvale non solo di testi scritti, ma anche di dati archeologici, analisi climatiche dell’epoca, studi antropologici e linguistici, tessendo una complessa rete di informazioni per formulare ipotesi e teorie. La mia esperienza nello studio della storia, anche solo attraverso la lettura di testi universitari o la visione di documentari ben fatti, mi ha sempre mostrato un processo di ricerca meticoloso e rigoroso, lontano dalla semplice narrazione di “fatti”.
2. Catena di cause ed effetti: Le scienze storiche non cercano leggi universali in senso stretto, ma si dedicano a identificare le complesse catene di cause ed effetti che hanno portato a determinati eventi o fenomeni. Questo significa indagare le interazioni tra molteplici fattori (economici, sociali, politici, culturali, ambientali) che, combinandosi, hanno prodotto un risultato specifico e spesso unico. Non si tratta di determinismo, ma di comprensione delle contingenze e delle interazioni. Ad esempio, studiare le cause della Rivoluzione Francese non significa trovare una formula matematica, ma analizzare le tensioni sociali, le crisi economiche, le idee illuministe, il ruolo degli individui e gli eventi scatenanti, riconoscendo come questi fattori si siano concatenati in un processo unico e irripetibile. Questa ricerca della causalità, seppur complessa, è un’operazione scientifica per eccellenza.
3. Previsioni: È vero che la storia non permette previsioni deterministiche del futuro. Tuttavia, le scienze storiche offrono una forma di previsione probabilistica o di tendenza, basata sulla conoscenza di modelli e dinamiche ricorrenti nel passato. “Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo” recita un famoso aforisma, e questo significa che lo studio della storia, pur non potendo predire l’esatto accadere di eventi, può mettere in guardia su potenziali sviluppi, rischi o esiti di determinate politiche o comportamenti sociali. Ad esempio, l’analisi delle crisi economiche passate può offrire spunti per la gestione di quelle attuali, o lo studio delle ondate migratorie storiche può illuminare le sfide dell’integrazione contemporanea. La storia non ci dice cosa succederà, ma ci fornisce un repertorio di scenari possibili e di lezioni apprese, consentendoci di agire con maggiore consapevolezza.
4. Complessità: La storia umana, in particolare, è intrinsecamente caratterizzata da una complessità immensa. Essa coinvolge un numero sterminato di attori individuali e collettivi, motivazioni spesso irrazionali, decisioni contingenti, imprevisti e variabili interconnesse. Questa complessità non è un difetto, ma una caratteristica che rende la disciplina affascinante e stimolante. Richiede approcci multidisciplinari e la capacità di integrare dati da campi diversi. La sfida della storia non è semplificare per trovare leggi universali, ma comprendere la ricchezza delle sfumature e la specificità degli eventi, pur cercando schemi e tendenze. La mia esperienza nel confrontarmi con la complessità di eventi storici come la caduta del Muro di Berlino o l’ascesa dei totalitarismi, ha sempre dimostrato come ogni tentativo di semplificazione fosse riduttivo, e come la vera comprensione nascesse dalla capacità di abbracciare le molteplici forze in gioco.
In conclusione, la visione di Jared Diamond ci invita a superare una concezione ottocentesca e rigidamente positivista della scienza. La storia, e le altre scienze storiche, sono discipline rigorose che, pur operando con metodologie diverse da quelle delle scienze sperimentali, perseguono la conoscenza attraverso la raccolta e l’analisi critica di prove, la ricerca di nessi causali, la formulazione di ipotesi e l’identificazione di tendenze. Riconoscere la scientificità della storia significa valorizzarne il ruolo cruciale nel fornirci gli strumenti per comprendere chi siamo, da dove veniamo e, soprattutto, per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide di un futuro che, sebbene imprevedibile nei dettagli, è profondamente influenzato dalle dinamiche e dalle lezioni del nostro passato.
![]()
-
Post Storia: la sfida digitale al mestiere del docente prof. Marco Meschini notizie dalla prima linea di un prof. di storia dotato di iPad. Corso di aggiornamento tenuto dal prof. Marco Meschini, docente di storia medievale presso l’Università della Svizzera Italiana (Lugano).
Per una visione più approfondita dei contenuti discussi, è possibile guardare la registrazione completa della conferenza nel seguente video:
Audio Lezioni, ascolta il podcast di Metodologia storica del prof. Gaudio
Ascolta “Metodologia storica” su Spreaker.