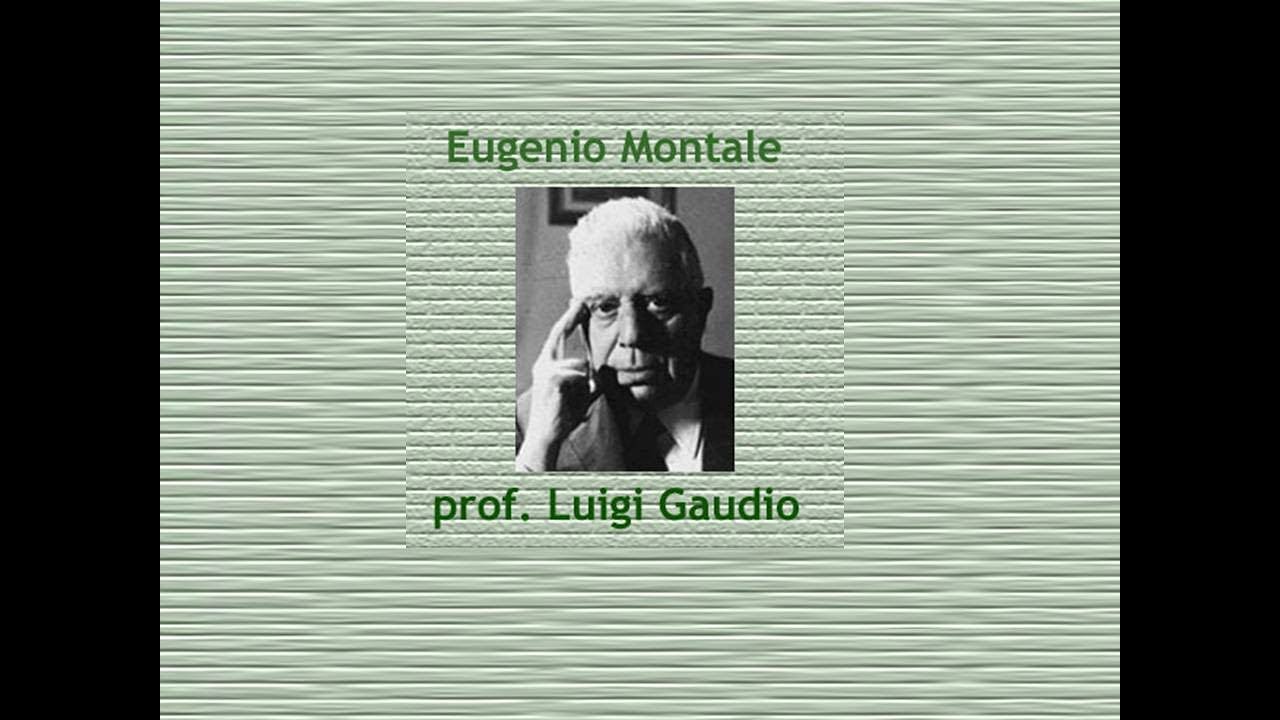Patria di Giovanni Pascoli
28 Maggio 2025
Bombardamento su Roma da La storia di Elsa Morante
28 Maggio 2025Analisi del testo “L’agave sullo scoglio,” di Eugenio Montale, con traccia di un compito per una classe quinta superiore e svolgimento
Traccia Tipologia A – Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio
Esempi da Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e Ombre”).
L’agave sullo scoglio
Scirocco
O rabido[1] ventare di scirocco
che l’arsiccio terreno gialloverde
bruci;
e su nel cielo pieno
di smorte luci
trapassa qualche biocco
di nuvola, e si perde.
Ore perplesse, brividi
d’una vita che fugge
come acqua tra le dita;
inafferrati eventi,
luci-ombre, commovimenti
delle cose malferme della terra;
oh alide[2] ali dell’aria
ora son io
l’agave[3] che s’abbarbica al crepaccio
dello scoglio
e sfugge al mare da le braccia d’alghe
che spalanca ampie gole e abbranca rocce;
e nel fermento
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci
che non sanno più esplodere oggi sento
la mia immobilità come un tormento.
NOTE:
[1] rabido: rapido
[2] alide: aride
[3] agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo
Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno.
Comprensione e analisi
- Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.
- Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia?
- Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato.
- La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?
- La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono?
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.
Svolgimento della Analisi della poesia “L’agave sullo scoglio” di Eugenio Montale
Comprensione e Analisi
1. Temi fondamentali della poesia
La lirica sviluppa diversi nuclei tematici interconnessi che trovano nel titolo la loro sintesi simbolica. L’agave, pianta mediterranea dalle foglie carnose e spinose che fiorisce raramente, diventa metafora della condizione esistenziale del poeta e, più universalmente, dell’uomo moderno.
Il tema dell’immobilità esistenziale emerge come centrale: l’io lirico si identifica con l’agave che, pur dotata di “racchiusi bocci”, non riesce a fiorire, vivendo la propria staticità “come un tormento”. Questa immobilità non è pace, ma paralisi dolorosa di fronte al dinamismo frenetico della natura circostante.
Il tema del rapporto conflittuale con la natura attraversa l’intera composizione: il paesaggio non è idilliaco rifugio, ma forza ostile che “bruci” e minaccia. La natura si presenta ambivalentemente come elemento di identificazione (l’agave) e di opposizione (il mare che “abbranca rocce”).
Il tema del tempo esistenziale si manifesta nelle “ore perplesse” e nella percezione di una “vita che fugge come acqua tra le dita”, rivelando l’angoscia per il fluire inesorabile dell’esistenza e l’impossibilità di afferrarla.
2. Lo stato d’animo nell’invocazione iniziale
L’invocazione “O rabido ventare di scirocco” esprime un complesso stato emotivo che oscilla tra attrazione e repulsione. Il poeta si rivolge al vento con un’apostrofe che contiene insieme fascino e timore: lo scirocco è “rabido” (rapido e rabbioso), elemento di devastazione che “bruci” il terreno, ma è anche forza vitale che spezza la staticità opprimente.
Lo stato d’animo rivelato è quello di chi cerca un contatto drammatico con le forze naturali, quasi invocando una tempesta interiore che spezzi l’immobilità esistenziale. È la tensione tra il bisogno di movimento, di cambiamento, e la paralisi che caratterizza la condizione umana. L’invocazione rivela insieme inquietudine, desiderio di liberazione e una sorta di masochistico piacere nel confrontarsi con l’ostilità degli elementi.
3. Fusione tra paesaggio marino e meditazione esistenziale
Montale realizza questa fusione attraverso diverse soluzioni espressive innovative:
L’uso della sinestesia: “smorte luci” unisce percezione visiva e sensazione di morte, “alide ali dell’aria” fonde tattile e visivo, creando un paesaggio che è insieme fisico e psichico.
La metafora continuata dell’identificazione: il passaggio dalla descrizione oggettiva (“scirocco che bruci”) alla identificazione soggettiva (“ora son io l’agave”) avviene gradualmente, attraverso la serie “ore perplesse, brividi d’una vita”, dove il paesaggio diventa correlativo oggettivo dello stato interiore.
L’antropomorfizzazione della natura: il mare ha “braccia d’alghe”, “spalanca ampie gole”, “abbranca rocce”, diventando entità minacciosa e quasi mostruosa che rispecchia l’ostilità del mondo verso l’individuo.
Il linguaggio impressionistico: “luci-ombre”, “commovimenti delle cose malferme” trasformano il paesaggio in emanazione diretta dell’interiorità, dove i confini tra soggetto e oggetto si dissolvono.
4. Sonorità e disarmonia espressiva
Montale costruisce un tessuto fonico complesso che mira alla disarmonia espressiva attraverso diversi accorgimenti:
Accorgimenti metrici: i versi liberi di misura irregolare (dai 7 ai 16 sillabe) creano un ritmo spezzato che mima l’inquietudine esistenziale. L’assenza di uno schema metrico fisso riflette lo smarrimento del soggetto.
Allitterazioni aspre: “rabido ventare”, “gialloverde bruci”, “braccia… abbranca” creano sonorità dure che riproducono l’asprezza dell’esperienza esistenziale.
Assonanze e consonanze: “scirocco… biocco”, “luci… fugge”, “alghe… ampie gole” producono echi sonori che legano musicalmente il testo ma in modo irregolare, creando un effetto di dissonanza controllata.
Enjambements violenti: “che l’arsiccio terreno / gialloverde bruci”, “oh alide / ali dell’aria” spezzano l’unità sintattica creando effetti di sospensione e inquietudine ritmica.
Accumuli consonantici: “s’abbarbica al crepaccio dello scoglio” con le doppie consonanti produce un effetto di durezza fonica che mima la difficoltà dell’esistere.
5. Opposizioni spaziali e loro significato
La lirica è strutturata su una serie di opposizioni che esprimono la tensione esistenziale del soggetto:
Alto/basso: “su nel cielo” vs “crepaccio dello scoglio” rappresenta l’oscillazione tra aspirazione all’infinito (il cielo con le sue “smorte luci”) e radicamento terrestre, quasi infernale (il crepaccio). L’agave sta nel mezzo, simbolo dell’uomo sospeso tra terra e cielo.
Finito/infinito: lo spazio limitato dello scoglio si oppone all’immensità del mare e del cielo. Il finito è rappresentato dall’agave imprigionata nel suo “crepaccio”, l’infinito dalle “ampie gole” marine e dallo spazio celeste. Questa opposizione esprime il limite umano di fronte all’illimitato dell’esistenza.
Statico/dinamico: l’immobilità tormentosa dell’agave (“la mia immobilità come un tormento”) si contrappone al movimento frenetico degli elementi naturali (vento, nuvole, mare). La staticità non è pace ma paralisi dolorosa, mentre il dinamismo è energia distruttrice. Questa opposizione rivela l’impossibilità di trovare una condizione esistenziale equilibrata.
Queste opposizioni esprimono la condizione tragica dell’uomo moderno, sospeso tra opposti inconciliabili, incapace di trovare una sintesi armonica tra le forze che lo attraversano.
Interpretazione
Il rapporto tra natura e poeta: immobilità e mobilità
La lirica rivela una concezione della natura profondamente diversa da quella romantica o tradizionale. Per Montale, la natura non è madre consolatrice né specchio dell’anima, ma forza estranea e spesso ostile che riflette e amplifica il disagio esistenziale dell’uomo contemporaneo.
Il rapporto tra il poeta e la natura si articola in una dialettica complessa tra identificazione e opposizione. Da un lato, il soggetto si riconosce nell’agave, pianta che resiste aggrappandosi disperatamente allo scoglio; dall’altro, subisce la minaccia del mare che “abbranca rocce” e del vento che devasta. Questa ambivalenza rivela la condizione moderna dell’individuo: parte della natura ma ad essa estraneo, desideroso di comunione ma destinato alla separazione.
L’atmosfera “sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità” rappresenta perfettamente la condizione esistenziale novecentesca. L’immobilità non è quella contemplativa del saggio antico, ma paralisi nevrotica; la mobilità non è energia vitale, ma forza distruttrice. Il poeta si trova in una condizione intermedia di stallo doloroso, simboleggiata dall’agave che vorrebbe fiorire ma non può.
Il disagio del vivere in Montale
Il “male di vivere” montaliano emerge qui in una delle sue formulazioni più efficaci. Il disagio non nasce da eventi specifici ma dalla condizione ontologica dell’esistere stesso. I “racchiusi bocci che non sanno più esplodere” simboleggiano le potenzialità inespresse dell’individuo, le aspirazioni che non riescono a tradursi in atto.
La percezione del tempo come “vita che fugge come acqua tra le dita” rivela l’angoscia per l’irreversibilità dell’esistenza e l’impossibilità di afferrarla in momenti di pienezza. Gli “inafferrati eventi” rappresentano l’esperienza di chi vive senza mai possedere realmente la propria vita, in una condizione di perenne estraneità a se stesso.
Il tormento dell’immobilità esprime la paralisi della volontà tipica della coscienza novecentesca, incapace di azione significativa ma tormentata dalla consapevolezza di questa impotenza. È la condizione dell’intellectuel descritto da Sartre, dell’uomo che pensa ma non agisce, che comprende ma non trasforma.
Confronti e approfondimenti
La condizione dell’agave montaliana trova significativi paralleli in altre espressioni artistiche del Novecento. La paralisi esistenziale richiama l’inettitudine sveviana: come gli eroi di Svevo, l’io lirico montaliano è consapevole della propria inadeguatezza ma incapace di superarla. Tuttavia, mentre in Svevo permane una vena ironica, in Montale domina la tensione tragica.
Il rapporto conflittuale con la natura si ritrova nell’Ungaretti delle prime raccolte, ma con esiti diversi: dove Ungaretti cerca l’essenziale attraverso la sottrazione, Montale accumula dettagli per esprimere la complessità del reale. La “poetica dell’oggetto” montaliana trasforma elementi naturali in correlati oggettivi dell’interiorità, tecnica che influenzerà tutta la poesia del Novecento.
In ambito europeo, l’immobilità tormentosa dell’agave ricorda il Godot di Beckett: l’attesa senza speranza, la condizione di sospensione che è insieme paralisi e tormento. Come i personaggi beckettiani, l’agave-poeta aspetta una fioritura che forse non verrà mai, ma non può smettere di aspettare.
Sul piano pittorico, il paesaggio montaliano richiama certo Espressionismo tedesco: la natura non è rappresentata mimeticamente ma deformata dall’angoscia esistenziale. Come in Munch, il paesaggio diventa proiezione dell’interiorità tormentata.
Considerazioni conclusive
“L’agave sullo scoglio” rappresenta uno dei vertici della poesia montaliana per la capacità di fondere innovazione formale e profondità esistenziale. La tecnica del correlativo oggettivo, qui pienamente realizzata, permette di oggettivare stati d’animo complessi senza cadere nell’effusione sentimentale.
La modernità della lirica sta nell’aver colto la condizione dell’uomo contemporaneo: sospeso tra opposti, incapace di sintesi armonica, tormentato dalla consapevolezza della propria impotenza. L’agave diventa simbolo universale di questa condizione, figura che trascende l’esperienza individuale per rappresentare l’esistenza umana nella sua dimensione più problematica.
La grandezza di Montale sta nell’aver trasformato il disagio esistenziale in forma poetica rigorosa, nell’aver trovato un linguaggio adeguato per dire l’inadeguatezza del vivere. La sua lezione influenzerà profondamente la poesia italiana successiva, indicando una via per esprimere la complessità dell’esperienza moderna senza cedere né all’ottimismo facile né al pessimismo gratuito.