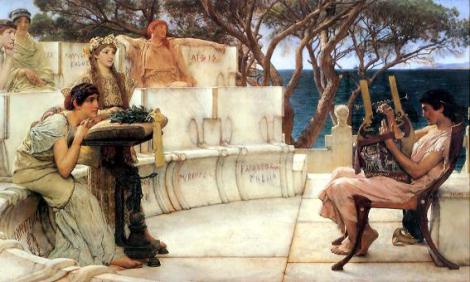
Primi lirici latini e Catullo
28 Dicembre 2019
Da Ottaviano ad Augusto. La pace e le guerre sotto Augusto
28 Dicembre 2019La Chiesa, intesa come comunità dei credenti in Gesù Cristo, ha le sue origini profonde negli eventi della vita, morte e resurrezione di Gesù di Nazareth, sviluppandosi e consolidandosi nei primi secoli dopo Cristo in un contesto culturale e politico complesso, quello dell’Impero Romano.
1. La Nascita e i Primi Passi (I Secolo d.C.)
Le origini della Chiesa si collocano in Palestina, una provincia dell’Impero Romano, all’inizio del I secolo d.C.
- Gesù di Nazareth e la Sua Predicazione: La figura centrale è Gesù di Nazareth, che predicò un messaggio di amore, pace, perdono e salvezza. Sebbene la data esatta della sua nascita sia oggetto di dibattito storico, la sua attività pubblica e la sua predicazione, soprattutto in Galilea e a Gerusalemme, gettarono le basi per una nuova comunità. La sua morte per crocifissione, sotto Ponzio Pilato, e la fede nella sua resurrezione furono gli eventi fondanti.
- Pentecoste e la Prima Comunità: Gli Atti degli Apostoli (scritti da Luca) narrano l’evento della Pentecoste, considerato il momento della nascita della Chiesa. Dopo l’ascensione di Gesù, gli apostoli e i primi discepoli erano riuniti a Gerusalemme quando, secondo la tradizione cristiana, ricevettero lo Spirito Santo. Questo evento diede loro la forza e la capacità di predicare il Vangelo con ardore e in diverse lingue, simboleggiando il messaggio universale del cristianesimo.
- Gli Apostoli e la Diffusione Iniziale: Attorno ai dodici apostoli, testimoni diretti della vita di Gesù, si costituì la prima assemblea cristiana, inizialmente composta prevalentemente da ebrei. Figure come Pietro, considerato il “capo pastore” e il primo vescovo di Roma (e quindi il primo Papa secondo la tradizione cattolica), ebbero un ruolo fondamentale nel coordinare questa nascente comunità.
- Paolo di Tarso e l’Apertura ai Gentili: Un momento decisivo per la separazione del cristianesimo dall’ebraismo fu l’opera di Saulo di Tarso, poi conosciuto come San Paolo. Inizialmente persecutore dei cristiani, si convertì dopo un’esperienza folgorante e divenne il “Apostolo delle Genti”. Paolo ottenne dagli apostoli il permesso di predicare anche ai pagani (non ebrei), sostenendo che la salvezza non dipendeva dall’osservanza della Legge mosaica (come la circoncisione), ma dalla fede in Cristo. I suoi viaggi missionari in tutto il Mediterraneo (Asia Minore, Grecia, Roma) furono cruciali per la fondazione di numerose comunità cristiane, o “chiese” (dal greco ekklesia, “assemblea”). Grazie a Paolo, il cristianesimo iniziò a configurarsi come una religione universale.
- Prime Comunità e Culto: I primi cristiani si riunivano spesso in case private (domus ecclesiae), dove celebravano la loro fede attraverso la preghiera, la lettura delle Scritture (inizialmente i testi ebraici, poi gli scritti evangelici e le lettere degli apostoli) e la condivisione del pane e del vino (la celebrazione della Santa Cena o Eucaristia). Il messaggio di uguaglianza, speranza e amore per il prossimo trovò particolare risonanza tra i poveri, gli schiavi e le donne, offrendo loro un senso di dignità e fratellanza che era spesso negato nella società romana.
2. Diffusione e Organizzazione (II-III Secolo d.C.)
Nonostante le difficoltà e le persecuzioni, il cristianesimo conobbe una rapida espansione, soprattutto nelle aree urbane dell’Impero, e iniziò a darsi una struttura organizzativa più definita.
- Crescita Numerica: Si stima che già nel I secolo gli adepti fossero cresciuti fino a circa 150.000. Nel corso del II e III secolo, il cristianesimo si diffuse in Siria (Antiochia), Asia Minore (Efeso, Corinto), Egitto (Alessandria, un importante centro di diffusione), e poi verso l’Occidente, inclusa Roma, la capitale dell’Impero. Alla fine del II secolo, si trovano testimonianze di comunità cristiane anche in Germania meridionale.
- Organizzazione Gerarchica: Con la diffusione e il proliferare delle comunità, si rese necessaria una struttura organizzativa più solida per coordinare i fedeli e mantenere l’unità dottrinale contro le nascenti “eresie” (dal greco hairesis, “scelta”).
- Presbiteri e Vescovi: Le comunità locali iniziarono a essere guidate da anziani (presbiteri) e, soprattutto, da un sorvegliante (episcopos, da cui “vescovo”), eletto dai fedeli. Il vescovo aveva il compito di organizzare i fedeli, di presiedere al culto, di insegnare la dottrina e di difendere l’ortodossia.
- Diocesi: Il territorio sottoposto al controllo di un vescovo venne definito diocesi.
- Autorità di Roma: Già in questa fase iniziale, il vescovo di Roma (considerato il successore di Pietro) cominciò ad assumere una particolare autorità e prestigio tra le diverse comunità cristiane, sebbene il suo primato non fosse ancora universalmente riconosciuto come nei secoli successivi.
- Sostegno delle Comunità: Le prime comunità cristiane si sostenevano attraverso i contributi volontari dei fedeli. Questi fondi venivano utilizzati per il mantenimento del clero, l’assistenza ai bisognosi (vedove, orfani, malati) e il riscatto dei prigionieri.
3. Le Persecuzioni e il Martirio
La rapida diffusione del cristianesimo e le sue caratteristiche intrinseche lo portarono spesso in conflitto con l’autorità romana e la cultura pagana.
- Motivi delle Persecuzioni:
- Monoteismo Esclusivo: I cristiani, come gli ebrei, credevano in un unico Dio e si rifiutavano di adorare gli dèi romani e l’imperatore, il cui culto era considerato un atto di lealtà civica. Questo li rendeva sospetti di empietà e di dislealtà verso lo Stato.
- “Atei” e “Nemici del Genere Umano”: Erano spesso accusati di “ateismo” (perché non adoravano le divinità tradizionali) e di pratiche immorali o misteriose (come l’incesto, per via del loro chiamarsi “fratelli e sorelle”, o il cannibalismo, per via della celebrazione dell’Eucaristia, i “pasti tiestei”).
- Rifiuto della Vita Civica: Spesso i cristiani rifiutavano di prestare servizio militare o di assumere cariche pubbliche, interpretato come un ulteriore atto di opposizione all’Impero.
- Le Principali Persecuzioni:
- Nerone (64 d.C.): La prima grande persecuzione, scatenata dopo l’incendio di Roma. Nerone accusò i cristiani, e molti furono torturati e uccisi in modi atroci. Secondo la tradizione, Pietro e Paolo subirono il martirio a Roma in questo periodo.
- Domiziano (fine I secolo d.C.): Altre persecuzioni si verificarono sotto imperatori come Domiziano, che perseguitò chi si rifiutava di adorare l’imperatore.
- Decio e Valeriano (metà III secolo d.C.): Queste furono persecuzioni sistematiche e generalizzate, che imposero l’obbligo di compiere sacrifici agli dèi imperiali per tutti i cittadini. Chi si rifiutava, rischiava la morte. Furono colpite anche le gerarchie ecclesiastiche e confiscate le proprietà cristiane.
- Diocleziano (inizio IV secolo d.C.): La “Grande Persecuzione” di Diocleziano (iniziata nel 303 d.C.) fu la più violenta e capillare. Prevedeva la distruzione delle chiese, l’eliminazione dei libri sacri e l’obbligo universale di sacrificare.
- Il Martirio come Testimonianza: Nonostante la violenza, le persecuzioni non riuscirono a estirpare il cristianesimo. Anzi, il martirio (dal greco martyria, “testimonianza”) divenne un potente mezzo di diffusione della fede. La fermezza e la serenità dei martiri di fronte alla morte impressionavano i pagani e attiravano nuovi convertiti. Le tombe dei martiri divennero luoghi di culto e venerazione.
4. La Svolta del IV Secolo e l’Affermazione
Il III secolo fu un periodo di alternanza tra persecuzioni e fasi di relativa pace, ma il IV secolo segnò la svolta decisiva per la Chiesa.
- Editto di Serdica (311 d.C.): L’imperatore Galerio pose fine alla Grande Persecuzione, concedendo ai cristiani una parziale tolleranza.
- Editto di Milano (313 d.C.): L’imperatore Costantino I (sebbene si battezzerà solo in punto di morte) e Licinio emanarono l’Editto di Milano, che concesse la piena libertà di culto ai cristiani in tutto l’Impero. Questo fu un momento epocale, che pose fine all’era delle persecuzioni e aprì la strada alla piena legittimazione del cristianesimo.
- Editto di Tessalonica (380 d.C.): Pochi decenni dopo, l’imperatore Teodosio I, con l’Editto di Tessalonica, fece del cristianesimo (nella sua ortodossia nicena) la religione ufficiale dell’Impero Romano.
In questi primi secoli, la Chiesa si trasformò da un piccolo gruppo di seguaci ebrei a Gerusalemme in un movimento religioso universale, organizzato e resiliente, capace di sopravvivere alle più dure persecuzioni e di affermarsi come una forza spirituale e sociale destinata a plasmare profondamente la civiltà occidentale.




