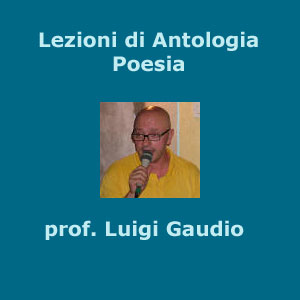
Componimenti poetici e parafrasi
28 Dicembre 2019
Albio Tibullo
28 Dicembre 2019Il Proemio dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, tra epica, amore e dedica
Il Proemio dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto è una delle aperture più celebri e significative della letteratura italiana. Composto da quattro ottave, esso svolge la funzione tradizionale di ogni proemio epico: presenta l’argomento del poema (la protasi), invoca l’ispirazione divina o museale, e dedica l’opera a un protettore. Tuttavia, Ariosto reinterpreta questi elementi con originalità e ironia, anticipando il tono e i temi che caratterizzeranno l’intero poema.
1. Stanza 1: La Protasi (L’Annuncio del Tema)
1 Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie, l’audaci imprese io canto,
che furo al tempo che passaro i Mori
d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,
seguendo l’ire e i giovenil furori
d’Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano.
- Temi dell’Epica Cavalleresca: Ariosto apre il poema con un’enumerazione sintetica e quasi programmatica dei temi che affronterà: “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, / le cortesie, l’audaci imprese”. Questa lista riassume i pilastri della tradizione epico-cavalleresca, dal ciclo carolingio a quello bretone, promettendo un’opera che abbraccerà sia la guerra e l’eroismo (“l’arme, l’audaci imprese”) sia la dimensione più cortese e sentimentale (“le donne, i cavallier, gli amori, le cortesie”).
- Contesto Storico-Leggendario: Il poeta colloca l’azione nel contesto delle guerre tra Cristiani e Mori (“che furo al tempo che passaro i Mori / d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto”), richiamando la leggendaria invasione di Agramante, re dei Mori, che intendeva vendicare la morte di suo padre Troiano contro Carlo Magno. Questo fornisce un quadro epico tradizionale, ma che nel poema sarà spesso sovvertito dall’irrompere del fantastico e del comico.
- “Io canto”: L’uso della prima persona singolare (“io canto”) è un’affermazione della voce autoriale, che si pone come narratore onnisciente e orchestratore di una materia vasta e complessa.
2.  Stanza 2: La “Sua” Musa (L’Invocazione)
Stanza 2: La “Sua” Musa (L’Invocazione)
2 Dirò d’Orlando in un medesmo tratto
cosa non detta in prosa mai, né in rima:
che per amor venne in furore e matto,
d’uom che sì saggio era stimato prima;
se da colei che tal quasi m’ha fatto,
che ’l poco ingegno ad or ad or mi lima,
me ne sarà però tanto concesso,
che mi basti a finir quanto ho promesso.
- L’Originalità del Tema: Ariosto annuncia subito l’elemento più innovativo e centrale del poema: la follia di Orlando (“Dirò d’Orlando… che per amor venne in furore e matto”). Questo è un “cosa non detta in prosa mai, né in rima”, un’affermazione di originalità rispetto alla tradizione che aveva sempre presentato Orlando come l’eroe per eccellenza della ragione e della fede. La follia per amore è un tema che ribalta le aspettative del pubblico.
- L’Invocazione alla Musa Personale: A differenza degli epici classici che invocavano una Musa divina, Ariosto invoca una musa del tutto personale: la sua amata donna (“se da colei che tal quasi m’ha fatto, / che ’l poco ingegno ad or ad or mi lima”). Questa scelta è profondamente ironica e moderna: l’ispirazione non viene dall’alto, ma dalla passione amorosa che, paradossalmente, lo rende quasi folle (“tal quasi m’ha fatto”) e gli “lima” l’ingegno, proprio come la follia colpirà Orlando. È un’autoironia che umanizza il poeta e lo lega al destino del suo eroe.
- La Promessa e il Dubbio: Il poeta esprime un’umile richiesta (“me ne sarà però tanto concesso, / che mi basti a finir quanto ho promesso”), che è sia una formula di modestia retorica sia un’allusione alla vastità dell’impresa e alla sua potenziale difficoltà.
3. Stanza 3: Dedica agli Estensi
3 Piacciavi, generosa Erculea prole,
ornamento e splendor del secol nostro,
Ippolito, aggradir questo che vuole
e darvi sol può l’umil servo vostro.
Quel ch’io vi debbo, posso di parole
pagare in parte e d’opera d’inchiostro;
né che poco io vi dia da imputar sono,
che quanto io posso dar, tutto vi dono.
- Il Dedicatario: Ippolito d’Este: Il poema è dedicato al cardinale Ippolito d’Este (“generosa Erculea prole, / ornamento e splendor del secol nostro, / Ippolito”). Questa dedica è un omaggio al suo protettore e alla potente famiglia degli Este, signori di Ferrara, che hanno commissionato l’opera e la cui glorificazione è uno degli scopi del poema.
- Il Rapporto Poeta-Mecenate: Ariosto si presenta come l'”umil servo vostro”, una formula di modestia e deferenza tipica del rapporto tra artista e mecenate nel Rinascimento. Egli offre ciò che ha: “parole” e “opera d’inchiostro”, riconoscendo il suo debito ma affermando anche il valore della sua arte come il dono più prezioso che può offrire. L’ultima riga (“che quanto io posso dar, tutto vi dono”) sottolinea la totalità del suo impegno artistico.
4. Stanza 4: Ruggiero il Capostipite
4 Voi sentirete fra i più degni eroi,
che nominar con laude m’apparecchio,
ricordar quel Ruggier, che fu di voi
e de’ vostri avi illustri il ceppo vecchio.
L’alto valore e’ chiari gesti suoi
vi farò udir, se voi mi date orecchio,
e vostri alti pensier cedino un poco,
sì che tra lor miei versi abbiano loco.
- Glorificazione Dinastica: Questa stanza introduce un altro tema fondamentale del poema: la glorificazione della dinastia estense attraverso la figura di Ruggiero. Ruggiero, eroe saraceno che si convertirà al cristianesimo e sposerà la guerriera cristiana Bradamante, è il leggendario capostipite della famiglia d’Este (“che fu di voi / e de’ vostri avi illustri il ceppo vecchio”).
- Invito all’Ascolto: Ariosto invita i suoi protettori ad ascoltare (“se voi mi date orecchio”) e a concedere spazio ai suoi versi (“e vostri alti pensier cedino un poco, / sì che tra lor miei versi abbiano loco”), un’ulteriore richiesta di attenzione e di riconoscimento per la sua opera, che si inserisce nel solco della tradizione epica ma con un tocco di familiarità.
Conclusione
Il Proemio dell’Orlando Furioso è un capolavoro di concisione e programmazione. In sole quattro ottave, Ariosto non solo adempie alle convenzioni del genere epico (protasi, invocazione, dedica), ma le reinterpreta con la sua inconfondibile impronta: l’annuncio della follia di Orlando come elemento centrale, l’invocazione ironica a una musa personale (l’amore), e la glorificazione della dinastia estense attraverso la figura di Ruggiero. Questo proemio multifunzionale stabilisce fin da subito il tono del poema: un’opera che mescola il serio e il faceto, il meraviglioso e il quotidiano, l’epica e la lirica, invitando il lettore a un viaggio avventuroso e imprevedibile nel mondo della cavalleria, dell’amore e della fantasia.
Testo delle prime quattro ottave, Proemio dell’Orlando Furioso
- 1) Proemio (la Protasi)
1 Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie, l’audaci imprese io canto,
che furo al tempo che passaro i Mori
d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,
seguendo l’ire e i giovenil furori
d’Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano.
- 2) Proemio: la «sua» musa
2 Dirò d’Orlando in un medesmo tratto
cosa non detta in prosa mai, né in rima:
che per amor venne in furore e matto,
d’uom che sì saggio era stimato prima;
se da colei che tal quasi m’ha fatto,
che ’l poco ingegno ad or ad or mi lima,
me ne sarà però tanto concesso,
che mi basti a finir quanto ho promesso.
- 3) Proemio: dedica agli Estensi
3 Piacciavi, generosa Erculea prole,
ornamento e splendor del secol nostro,
Ippolito, aggradir questo che vuole
e darvi sol può l’umil servo vostro.
Quel ch’io vi debbo, posso di parole
pagare in parte e d’opera d’inchiostro;
né che poco io vi dia da imputar sono,
che quanto io posso dar, tutto vi dono.
- 4) Proemio: Ruggiero il capostipite
4 Voi sentirete fra i più degni eroi,
che nominar con laude m’apparecchio,
ricordar quel Ruggier, che fu di voi
e de’ vostri avi illustri il ceppo vecchio.
L’alto valore e’ chiari gesti suoi
vi farò udir, se voi mi date orecchio,
e vostri alti pensier cedino un poco,
sì che tra lor miei versi abbiano loco.

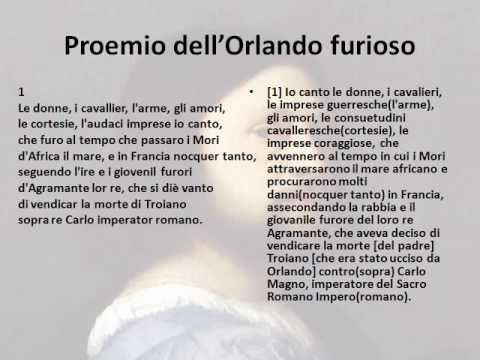
 Stanza 2: La “Sua” Musa (L’Invocazione)
Stanza 2: La “Sua” Musa (L’Invocazione)

