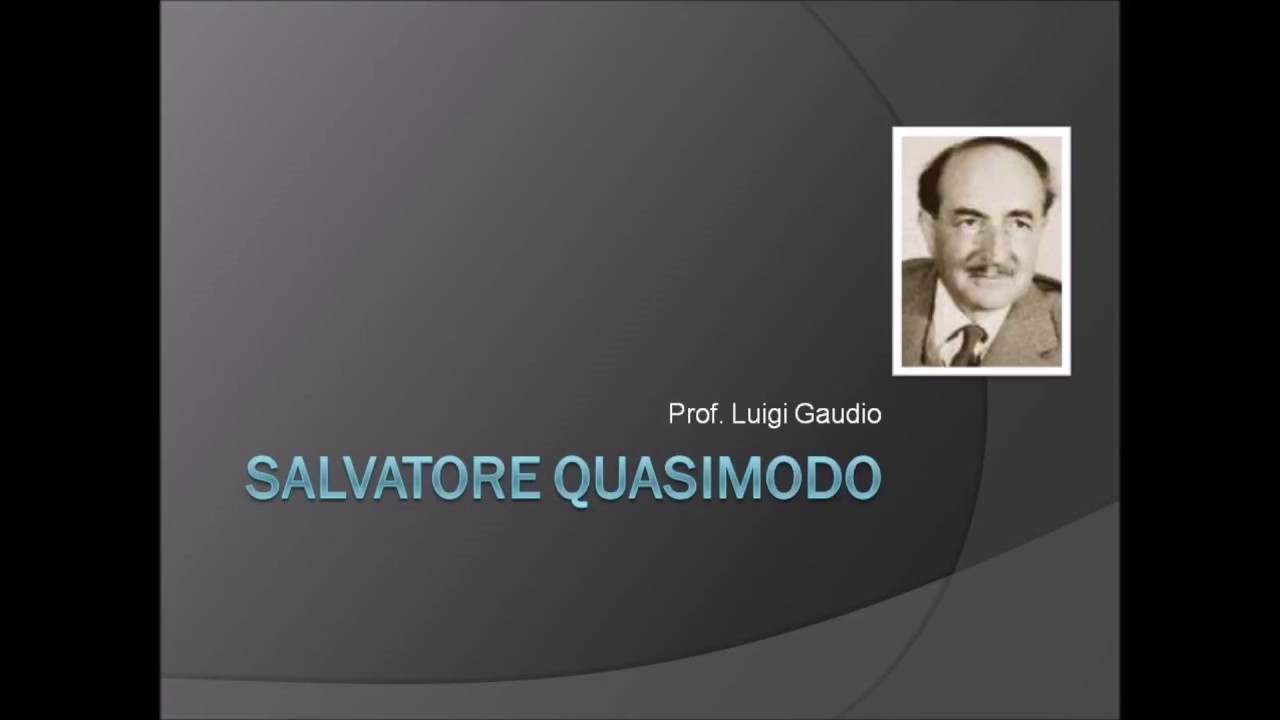
Alla nuova luna di Salvatore Quasimodo
11 Giugno 2025
L’idea di nazione nel risorgimento
11 Giugno 2025Traccia e svolgimento di un brano tratto da “Gli indifferenti” di Alberto Moravia
TRACCIA
SESSIONE ORDINARIA 2023 – PRIMA PROVA SCRITTA – Ministero dell’istruzione e del merito
PROPOSTA A2
Alberto Moravia, Gli indifferenti, edizioni Alpes, Milano, 1929, pp. 27-28.
CONTESTO
Gli indifferenti (1929) è il romanzo d’esordio di Alberto Pincherle, in arte Alberto Moravia (1907 – 1990). I protagonisti sono i fratelli Carla e Michele Ardengo, incapaci di opporsi ai propositi di Leo Merumeci, amante della loro madre Mariagrazia, che in modo subdolo tenta di impossessarsi dei beni e della villa di loro proprietà.
TESTO
«Tutti lo guardarono. – Ma vediamo, Merumeci, – supplicò la madre giungendo le mani, – non vorrà mica mandarci via così su due piedi?… ci conceda una proroga…
- Ne ho già concesse due, – disse Leo, – basta… tanto più che non servirebbe ad evitare la vendita…
- Come a non evitare? – domandò la madre.
Leo alzò finalmente gli occhi e la guardò: – Mi spiego: a meno che non riusciate a mettere insieme ottocentomila lire, non vedo come potreste pagare se non vendendo la villa…
La madre capì, una paura vasta le si aprì davanti agli occhi come una voragine; impallidì, guardò l’amante; ma Leo tutto assorto nella contemplazione del suo sigaro non la rassicurò:
- Questo significa – disse Carla – che dovremo lasciare la villa e andare ad abitare in un appartamento di poche stanze?
- Già, – rispose Michele, – proprio così.
Silenzio. La paura della madre ingigantiva; non aveva mai voluto sapere di poveri e neppure conoscerli di nome, non aveva mai voluto ammettere l’esistenza di gente dal lavoro faticoso e dalla vita squallida. «Vivono meglio di noi» aveva sempre detto; «noi abbiamo maggiore sensibilità e più grande intelligenza e perciò soffriamo più di loro…»; ed ora, ecco, improvvisamente ella era costretta a mescolarsi, a ingrossare la turba dei miserabili; quello stesso senso di ripugnanza, di umiliazione, di paura che aveva provato passando un giorno in un’automobile assai bassa attraverso una folla minacciosa e lurida di scioperanti, l’opprimeva; non l’atterrivano i disagi e le privazioni a cui andava incontro, ma invece il bruciore, il pensiero di come l’avrebbero trattata, di quel che avrebbero detto le persone di sua conoscenza, tutta gente ricca, stimata ed elegante; ella si vedeva, ecco… povera, sola, con quei due figli, senza amicizie chè tutti l’avrebbero abbandonata, senza divertimenti, balli, lumi, feste, conversazioni: oscurità completa, ignuda oscurità. Il suo pallore aumentava: «Bisognerebbe che gli parlassi da sola a solo», pensava attaccandosi all’idea della seduzione; «senza Michele e senza Carla… allora capirebbe». Guardò l’amante.
- Lei, Merumeci, – propose vagamente – ci conceda ancora una proroga, e noi il denaro lo si troverà in qualche modo.»
Alberto Moravia, Gli indifferenti, edizioni Alpes, Milano, 1929, pp. 27-28.
COMPRENSIONE E ANALISI
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.
- Sintetizza il contenuto del brano evitando di ricorrere al discorso diretto.
- Per quale motivo ‘la paura della madre ingigantiva’?
- Pensando al proprio futuro, la madre si vede ‘povera, sola, con quei due figli, senza amicizie’: l’immagine rivela quale sia lo spessore delle relazioni familiari e sociali della famiglia Ardengo. Illustra questa osservazione.
- In che modo la madre pensa di poter ancora intervenire per evitare di cadere in miseria?
INTERPRETAZIONE
Commenta il brano proposto, elaborando una tua riflessione sulla rappresentazione del mondo borghese come delineato criticamente da Moravia. Puoi mettere questo testo in relazione con altri suoi scritti o far riferimento anche ad autori italiani e stranieri che hanno affrontato il tema della rappresentazione dei caratteri della borghesia.
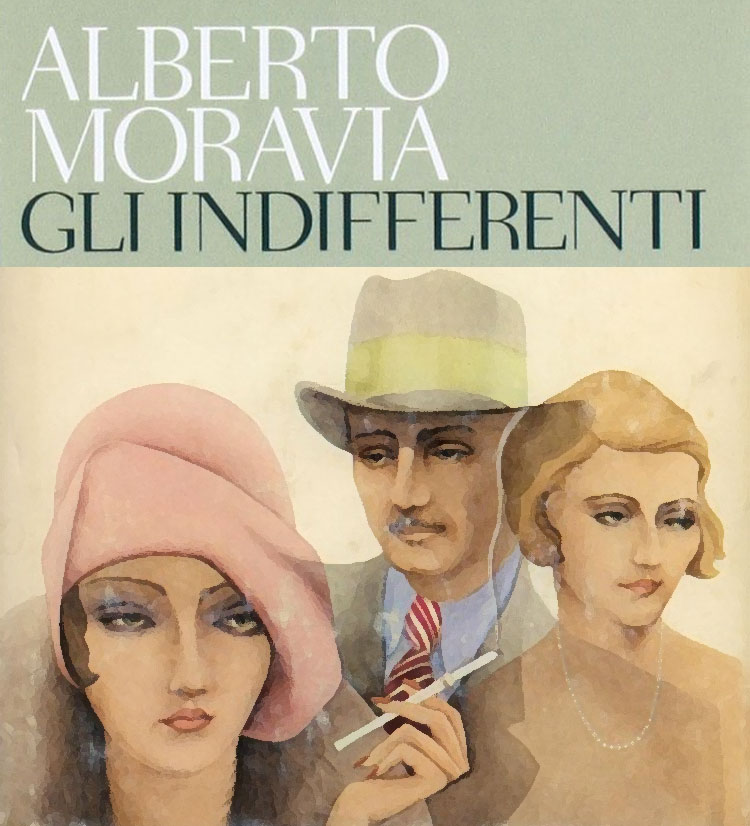
SVOLGIMENTO
Analisi de ‘Gli indifferenti’ di Alberto Moravia
Il brano tratto da Gli indifferenti (1929), romanzo d’esordio di Alberto Moravia, ci introduce nel torbido e soffocante universo della borghesia romana degli anni ’20, rivelandone l’ipocrisia, la superficialità e la sostanziale indifferenza morale. Attraverso il dialogo tra Mariagrazia, i figli Carla e Michele, e l’amante Leo Merumeci, emerge il dramma di una famiglia al declino, incapace di agire di fronte alla perdita imminente del proprio status sociale.
Comprensione e Analisi
1. Sintetizza il contenuto del brano evitando di ricorrere al discorso diretto.
Il brano descrive il momento in cui Leo Merumeci, amante della madre Mariagrazia, rivela alla famiglia Ardengo la gravità della loro situazione economica. Mariagrazia, supplicante, chiede una proroga per il pagamento dei debiti, ma Leo le spiega che ciò sarebbe inutile, a meno che non riescano a raccogliere una somma considerevole, impossibile da ottenere se non vendendo la villa di famiglia. La madre comprende la gravità della situazione e impallidisce per la paura di cadere in miseria, ma Leo non la rassicura. Carla e Michele confermano amaramente che dovranno lasciare la villa per un appartamento più piccolo. La paura di Mariagrazia aumenta, non tanto per i disagi materiali, quanto per l’umiliazione sociale e il giudizio delle persone facoltose di sua conoscenza. Si vede sola, abbandonata dagli amici, privata di divertimenti e feste. Infine, la madre pensa di poter ancora risolvere la situazione provando a sedurre Leo con un colloquio privato.
2. Per quale motivo ‘la paura della madre ingigantiva’?
La paura della madre Mariagrazia ingigantiva non tanto per la prospettiva di un degrado materiale e per le privazioni economiche in sé, quanto piuttosto per le conseguenze sociali e relazionali della miseria.
Il testo lo esplicita chiaramente: “non l’atterrivano i disagi e le privazioni a cui andava incontro, ma invece il bruciore, il pensiero di come l’avrebbero trattata, di quel che avrebbero detto le persone di sua conoscenza, tutta gente ricca, stimata ed elegante”. Mariagrazia era una donna che aveva sempre rifiutato l’idea della povertà e della gente dal “lavoro faticoso e dalla vita squallida”, arrivando a illudersi che “noi abbiamo maggiore sensibilità e più grande intelligenza e perciò soffriamo più di loro”. Il suo terrore deriva dall’essere “costretta a mescolarsi, a ingrossare la turba dei miserabili”, vedendosi umiliata e ripudiata dal suo ambiente sociale. La sua paura è quella di perdere la sua posizione, le sue amicizie superficiali e i suoi divertimenti (balli, lumi, feste, conversazioni), proiettandosi in una “oscurità completa, ignuda oscurità” sociale.
3. Pensando al proprio futuro, la madre si vede ‘povera, sola, con quei due figli, senza amicizie’: l’immagine rivela quale sia lo spessore delle relazioni familiari e sociali della famiglia Ardengo. Illustra questa osservazione.
L’immagine che la madre si crea del proprio futuro – “povera, sola, con quei due figli, senza amicizie” – è estremamente rivelatrice dello spessore e della natura profondamente superficiale e opportunistica delle relazioni familiari e sociali della famiglia Ardengo.
-
Relazioni sociali (amicizie): La madre si vede “senza amicizie chè tutti l’avrebbero abbandonata”. Questo sottolinea che le sue relazioni sociali non erano basate su affetto o stima autentici, ma sullo status economico e sull’opportunità. Gli “amici” erano in realtà frequentazioni legate ai “divertimenti, balli, lumi, feste, conversazioni”, cioè a un’ostentazione di ricchezza e a un’esistenza mondana. Nel momento in cui lo status economico viene meno, anche le amicizie scompaiono, rivelando la loro vuota formalità. È un mondo in cui i legami sono transitori e strumentali al mantenimento di un’immagine sociale.
-
Relazioni familiari (i figli): L’espressione “con quei due figli” (sottolineando il “quei”) è particolarmente significativa. Non è un riferimento affettuoso, ma quasi un’annotazione di un peso, di un problema ulteriore in una situazione già disperata. I figli, Michele e Carla, non sono visti come un sostegno o una fonte di conforto, ma come un dato di fatto della sua condizione, quasi un ingombro nella sua solitudine imminente. Ciò evidenzia la mancanza di autentico affetto e solidarietà all’interno del nucleo familiare. Mariagrazia non pensa a come i figli affronteranno la situazione, ma solo a come la loro presenza (e la loro incapacità di agire) accentuerà la sua condizione di perdita e umiliazione. Le relazioni familiari sono svuotate di calore umano e ridotte a una mera coesistenza funzionale.
L’osservazione rivela un mondo borghese dove i valori umani e affettivi sono stati sostituiti da quelli materiali e di facciata, e dove l’indifferenza e l’egoismo pervadono anche i legami più intimi.
4. In che modo la madre pensa di poter ancora intervenire per evitare di cadere in miseria?
La madre Mariagrazia, di fronte alla prospettiva della miseria, pensa di poter ancora intervenire e risolvere la situazione ricorrendo all’unica “arma” che crede di possedere e che le ha permesso di mantenere finora il suo status: la seduzione e il ricatto affettivo/sessuale nei confronti di Leo.
Il testo lo indica chiaramente quando Mariagrazia pensa: “Bisognerebbe che gli parlassi da sola a solo”, attaccandosi “all’idea della seduzione; ‘senza Michele e senza Carla… allora capirebbe’”. Questo suggerisce che ella crede di poter manipolare Leo attraverso il loro rapporto personale e intimo, lontano dagli occhi critici e moraleggianti dei figli. La sua proposta finale, “Lei, Merumeci, – propose vagamente – ci conceda ancora una proroga, e noi il denaro lo si troverà in qualche modo”, è un tentativo disperato di riattivare il potere che crede di avere su Leo, basato non su argomenti economici o legali, ma sulla sua influenza personale come amante.
Questo modo di pensare è coerente con la sua mentalità superficiale e con la sua incapacità di affrontare i problemi in modo razionale o pragmatico. La seduzione è per lei una scorciatoia, un’illusione di controllo in una situazione che le sta sfuggendo di mano, riflettendo la sua incapacità di comprendere la vera natura delle relazioni e la gravità della crisi.
Interpretazione
Il brano tratto da Gli indifferenti di Alberto Moravia offre una rappresentazione lucida e impietosa del mondo borghese italiano del primo Novecento, delineandone criticamente i caratteri distintivi: l’ipocrisia, l’aridità morale, la superficialità delle relazioni e una profonda alienazione. Moravia, attraverso la vicenda della famiglia Ardengo, mostra come questa classe sociale, apparentemente solida e rispettabile, sia in realtà svuotata di valori autentici, prigioniera delle convenzioni e dell’ossessione per il mantenimento dello status.
Il mondo borghese delineato da Moravia è un universo in cui l’apparire prevale sull’essere. La preoccupazione principale di Mariagrazia non è la povertà in sé, ma l’umiliazione sociale, il giudizio degli “altri”, il “bruciore” di perdere la sua immagine di donna ricca e stimata. Le sue amicizie sono effimere, legate ai “balli, lumi, feste”, rivelando una sociabilità vuota e opportunistica che scompare al primo sentore di disgrazia. Questo è un tratto distintivo della borghesia moraviana: i rapporti umani non sono basati su affetto o solidarietà, ma su calcoli di convenienza e sulla condivisione di uno stesso strato sociale. I figli stessi, Michele e Carla, sono presenze quasi inerti, incapaci di agire o di sostenere la madre, emblemi di una gioventù alienata e priva di ideali.
L’indifferenza che dà il titolo al romanzo è la cifra morale di questa borghesia. Essa si manifesta nell’incapacità dei personaggi di provare sentimenti autentici, di agire con determinazione, di ribellarsi a una situazione che li sta schiacciando. Michele e Carla sono bloccati in una passività che rasenta l’apatia, mentre Mariagrazia, pur impaurita, tenta disperatamente di salvarsi attraverso la seduzione, un gesto che non solo rivela la sua mancanza di dignità, ma anche l’aridità di una relazione che si è ridotta a puro strumento. L’indifferenza non è solo un tratto psicologico, ma una condizione esistenziale che permea l’ambiente sociale e le relazioni familiari, portando all’incomunicabilità e all’impotenza.
La rappresentazione di Moravia si distingue per il suo stile asciutto, quasi cronachistico, privo di giudizi espliciti ma potentemente rivelatore. L’autore non commenta, ma mostra, lasciando che le parole e i gesti dei personaggi svelino la loro vuotezza interiore. Questa tecnica, che anticipa il neorealismo, è tipica della sua critica alla borghesia, di cui Moravia era figlio e attento osservatore. In altri suoi scritti, come ad esempio La Romana o La noia, Moravia continua a indagare l’alienazione, la crisi dei valori e l’incapacità di autenticità che affliggono i personaggi borghesi, spesso attraverso la lente di relazioni fallimentari e di un senso di vuoto esistenziale.
Il tema della rappresentazione dei caratteri della borghesia è stato ampiamente affrontato sia in Italia che all’estero. In Italia, un confronto immediato può essere fatto con Italo Svevo, in particolare con La coscienza di Zeno. Anche Svevo, come Moravia, analizza la borghesia, ma con una lente diversa. Se Moravia ne mette a nudo l’ipocrisia e la crisi morale attraverso la narrazione in terza persona, Svevo si addentra nella psiche del suo “inetto” Zeno, un borghese triestino che, pur immerso nelle sue nevrosi e autoinganni, rappresenta la fragilità e l’incapacità di aderire pienamente alla vita e alle sue forme. La nevrosi di Zeno è la sua “malattia”, ma anche la sua unica via di fuga da un’esistenza borghese che altrimenti sarebbe insopportabile. Entrambi gli autori, seppur con stili e prospettive diverse, denunciano la patologia di una classe sociale.
A livello internazionale, si possono citare diversi autori che hanno dipinto un quadro critico della borghesia. Flaubert, con Madame Bovary, ha mostrato le illusioni e le disillusioni di una donna borghese che cerca nell’amore romantico una via di fuga dalla banalità della sua esistenza provinciale. La sua critica è rivolta alla meschinità e alla volgarità dei valori borghesi che soffocano le aspirazioni individuali. Anche Thomas Mann, in opere come I Buddenbrook, ha esplorato il declino di una famiglia borghese attraverso generazioni, mostrando come l’ossessione per il denaro e il successo economico possa portare alla perdita dei valori umani e al degrado.
In conclusione, il brano de Gli indifferenti di Moravia è un’istantanea potente e amara di una borghesia al tramonto, incapace di reagire di fronte alla crisi che la investe. La sua rappresentazione critica di un mondo fatto di apparenze, in cui l’indifferenza e l’egoismo corrodono i legami più intimi, risuona con forza ancora oggi. Moravia, con la sua prosa incisiva e la sua visione disincantata, ci invita a riflettere sui pericoli di una società che perde il contatto con i valori autentici, condannata a vivere in una “ignuda oscurità” di superficialità e vuoto morale.




