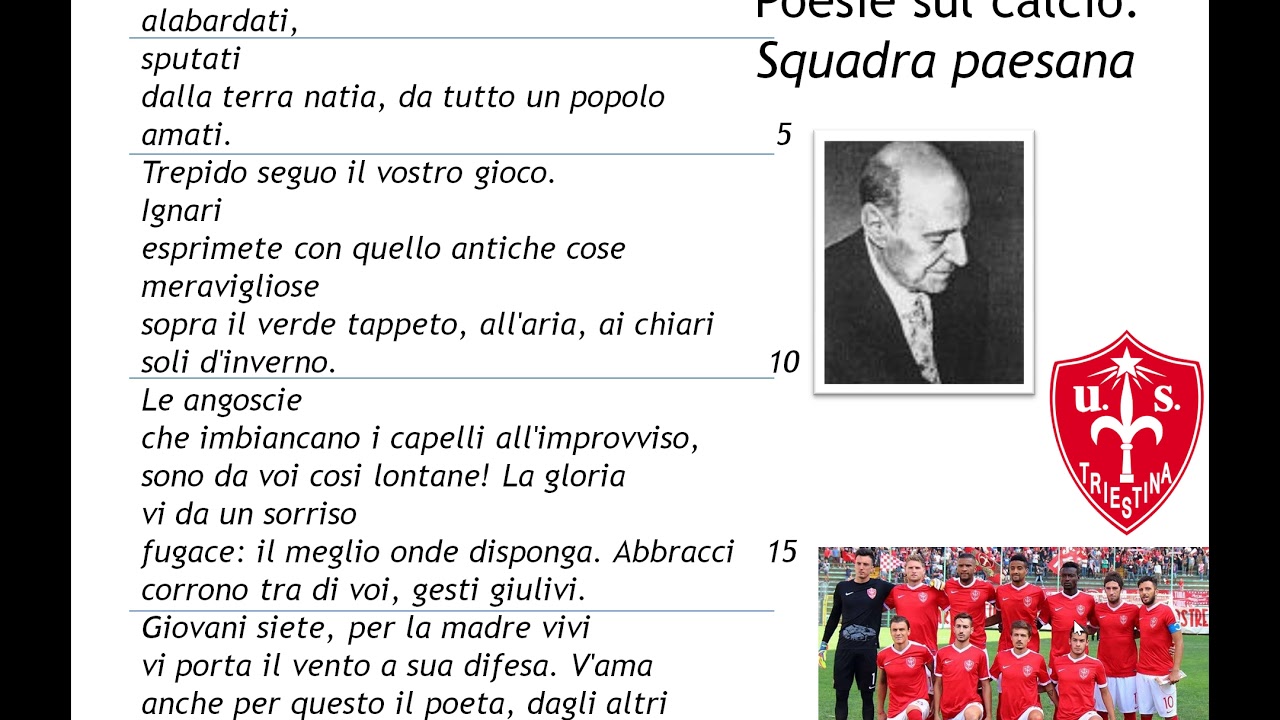
Squadra paesana di Umberto Saba
28 Dicembre 2019
CSI Federazione russa: comunità di Stati Indipendenti
28 Dicembre 2019La poesia “Milano, agosto 1943” di Salvatore Quasimodo è una testimonianza toccante dei bombardamenti alleati su Milano durante la Seconda Guerra Mondiale.
Questo componimento, con il suo linguaggio essenziale e la sua forza evocativa, rappresenta una delle fasi più mature della produzione di Quasimodo, quella in cui si impegna civilmente e partecipa al dramma storico del suo tempo.
La struttura della poesia ruota attorno al tema centrale della morte della città, ripetuto come un triste ritornello che accompagna l’intera composizione.
povera mano, la città è morta.
È morta: s’è udito l’ultimo rombo
sul cuore del Naviglio. E l’usignolo
è caduto dall’antenna, alta sul convento, 5
dove cantava prima del tramonto.
L’incipit “Invano cerchi tra la polvere, / povera mano” catapulta subito il lettore in un paesaggio di devastazione, dove la ricerca tra le macerie diventa un gesto disperato e senza speranza. L’apostrofe alla “povera mano” rende la tragedia più umana, trasformando la distruzione collettiva in un dramma sia individuale che universale.
Il verso “la città è morta” diventa un refrain ossessivo, ripetuto tre volte nel breve componimento, creando un’eco che risuona come un lamento funebre. Questa ripetizione non è solo una scelta stilistica, ma un potente strumento espressivo che comunica l’irreversibilità e l’assolutezza della devastazione. Milano, un centro industriale e simbolo della modernità italiana, viene privata della sua vitalità e ridotta a una necropoli.
L’immagine dell’usignolo che “è caduto dall’antenna, alta sul convento, / dove cantava prima del tramonto” rappresenta uno dei momenti più lirici e carichi di significato della poesia. L’uccello, simbolo tradizionale di poesia e bellezza, precipita dall’antenna del convento, un luogo che unisce sacro e tecnologico. La sua morte segna la fine di un’epoca di bellezza e spiritualità, travolta dalla brutalità della guerra. Il riferimento temporale “prima del tramonto” evoca un tempo perduto, quando c’era ancora spazio per la bellezza e il canto.
Non scavate pozzi nei cortili:
i vivi non hanno più sete.
Non toccate i morti, così rossi, così gonfi:
lasciateli nella terra delle loro case: 10
la città è morta, è morta.
La seconda parte del componimento si distingue per l’uso dell’imperativo negativo, che conferisce al testo un tono profetico e ammonitore. “Non scavate pozzi nei cortili: / i vivi non hanno più sete” presenta un paradosso inquietante: l’acqua, elemento vitale per eccellenza, diventa superflua in un mondo dove anche i sopravvissuti sono spiritualmente morti. La sete fisica si trasforma in una metafora della perdita di ogni desiderio e slancio vitale.
Il verso “Non toccate i morti, così rossi, così gonfi” introduce una crudezza realistica che contrasta con il tono più lirico delle strofe precedenti. Gli aggettivi “rossi” e “gonfi” restituiscono l’orrore fisico della guerra senza alcuna abbellimento estetico, mentre l’imperativo negativo suggerisce una forma di rispetto sacro verso le vittime. L’indicazione “lasciateli nella terra delle loro case” trasforma le macerie in un cimitero, dove i morti trovano sepoltura tra i resti della loro vita quotidiana.
Dal punto di vista metrico, Quasimodo utilizza versi liberi di varia misura, privilegiando endecasillabi e settenari che conferiscono al testo un ritmo solenne e liturgico. La sintassi, caratterizzata da frasi brevi e coordinazione paratattica, riflette l’urgenza comunicativa e l’immediatezza dell’esperienza traumatica. L’assenza di rime tradizionali è compensata da assonanze e consonanze che creano un tessuto fonico coeso e suggestivo.
La poesia si inserisce nella tradizione della letteratura di guerra italiana, dialogando con le esperienze di Giuseppe Ungaretti e anticipando sviluppi successivi. Tuttavia, Quasimodo si distingue per la sua capacità di universalizzare l’esperienza particolare, trasformando il bombardamento di Milano in simbolo della distruzione che la guerra infligge alla civiltà umana. La dimensione locale si espande fino a raggiungere un significato metafisico, interrogando il senso stesso dell’esistenza di fronte all’assurdità della violenza.
“Milano, agosto 1943” segna un momento fondamentale nell’evoluzione poetica di Quasimodo, segnando il passaggio da un ermetismo puro a una poesia più civile. Questa nuova forma, pur mantenendo una forte tensione lirica, si confronta direttamente con la storia e i suoi drammi. Il poema dimostra la straordinaria capacità del poeta siciliano di unire impegno etico e raffinatezza stilistica, offrendo una delle testimonianze più intense della poesia italiana del Novecento sulla tragedia della guerra.
Testo della poesia “Milano, agosto 1943” di Salvatore Quasimodo
Poesia tratta dalla raccolta poetica Giorno dopo giorno pubblicata nel 1947, che rappresenta una svolta nell’ opera di Quasimodo, nel segno di una partecipazione al dramma mondiale della guerra e della distruzione
Milano, agosto 1943 di Salvatore Quasimodo, dalla raccolta Giorno dopo giorno

povera mano, la città è morta.
È morta: s’è udito l’ultimo rombo
sul cuore del Naviglio. E l’usignolo
è caduto dall’antenna, alta sul convento, 5
dove cantava prima del tramonto.
Non scavate pozzi nei cortili:
i vivi non hanno più sete.
Non toccate i morti, così rossi, così gonfi:
lasciateli nella terra delle loro case: 10
la città è morta, è morta.




