
Nozioni preliminari di geografia: cartografia, meridiani e paralleli, orogenesi e …
28 Dicembre 2019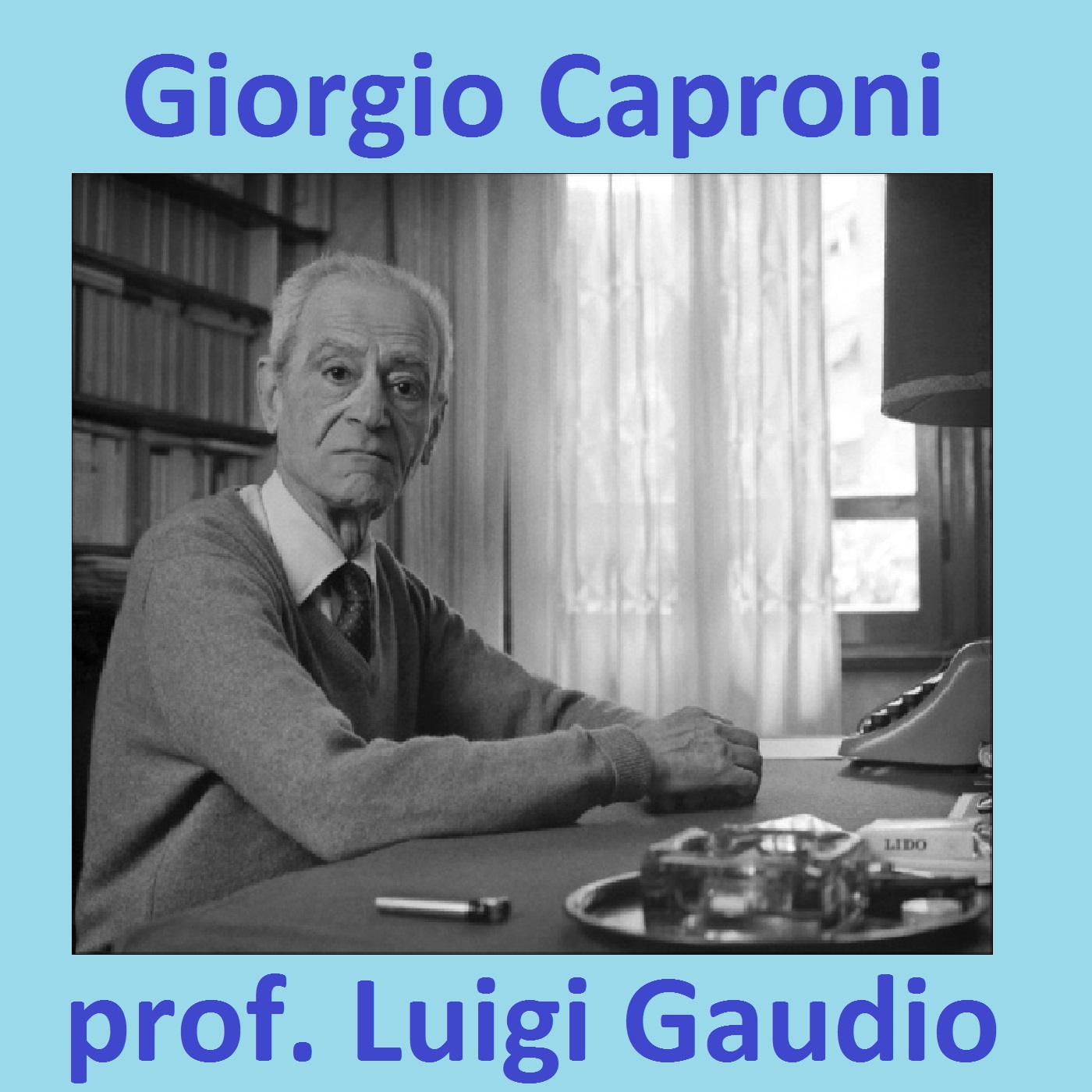
Preghiera di Giorgio Caproni
28 Dicembre 2019
Il legame tra narrazione e morte è uno dei temi centrali dell’esperienza umana e letteraria, con Sheherazade che emerge come il suo archetipo più potente e rappresentativo.
Nelle “Mille e una notte“, Sheherazade trasforma l’arte del racconto in una vera e propria strategia di sopravvivenza: ogni storia interrotta nel momento clou diventa un modo per guadagnare tempo, e ogni “continua domani” rappresenta un giorno di vita in più. Ma c’è di più: questa dinamica svela una verità profonda sul legame tra narrazione e mortalità. La principessa non si limita a guadagnare tempo; attraverso le sue storie, riesce a cambiare gradualmente l’animo del sultano Shahriyar, trasformando la sua sete di vendetta in curiosità, poi in interesse, e infine in amore. La narrazione diventa così uno strumento di redenzione morale e sociale.
Questa funzione salvifica del racconto si estende in tutta la letteratura occidentale, assumendo forme e significati diversi.
In Omero, il racconto di Ulisse alla corte dei Feaci non solo gli fornisce l’aiuto necessario per tornare a Itaca, ma trasforma la sua esperienza di dolore in una memoria eroica che può essere condivisa. Raccontare le proprie avventure diventa un modo per dare senso alla sofferenza e inserirla in un ordine cosmico comprensibile.
Il Medioevo cristiano sviluppa ulteriormente questa idea attraverso l’exemplum e la letteratura agiografica: raccontare vite esemplari significa offrire modelli di salvezza eterna. La “Divina Commedia” rappresenta il culmine di questa tradizione: Dante narra il suo viaggio nell’aldilà per salvare se stesso e l’umanità dal peccato. La narrazione della propria esperienza mistica diventa così una missione pedagogica e soteriologica.
Con l’età moderna, il legame tra narrazione e morte si secolarizza, ma non perde la sua intensità.
Il “Don Chisciotte” di Cervantes trasforma la lettura compulsiva di romanzi cavallereschi in una fuga dalla realtà quotidiana, mentre il protagonista diventa narratore della propria follia, cercando di dare un senso epico a un’esistenza altrimenti insignificante. Qui, la narrazione si fa resistenza contro la banalità della vita di tutti i giorni.
Il Romanticismo amplifica questa dimensione: per Coleridge nell'”Ancient Mariner”, il protagonista è condannato a raccontare eternamente la propria storia come forma di espiazione. Il racconto diventa così una combinazione di pena e redenzione, condanna e liberazione.
Mary Shelley, nel “Frankenstein”, costruisce una struttura narrativa a scatole cinesi, dove ogni personaggio narra la propria storia per giustificare le proprie azioni e cercare comprensione.
Il Novecento radicalizza il tema attraverso le esperienze delle catastrofi storiche. Primo Levi teorizza esplicitamente la narrazione come un dovere di sopravvivenza: raccontare l’Olocausto non solo serve a impedire che si ripeta, ma anche a dare un senso alla propria sopravvivenza, che altrimenti sembrerebbe casuale. “Se questo è un uomo” nasce dall’urgenza di testimoniare, trasformando il racconto in un imperativo morale.
Jorge Luis Borges esplora le implicazioni metafisiche del tema: nel racconto “El Aleph”, la visione dell’infinito rischia di annientare il narratore, che si salva solo traducendo l’esperienza in parole, anche se inadeguate, ma necessarie. In “La lotería en Babilonia”, il racconto stesso della lotteria universale che governa l’esistenza diventa un modo per sopravvivere al caos della vita.
Gabriel García Márquez, in “Cent’anni di solitudine”, fa della narrazione familiare un tentativo di sfuggire alla profezia di estinzione che incombe sui Buendía. Raccontare la propria stirpe significa cercare di spezzare il cerchio della ripetizione che condanna la famiglia alla scomparsa.
Italo Calvino condivide città immaginarie con Kublai Khan per impedire all’imperatore di sprofondare nella malinconia che spesso accompagna il potere. In questa narrazione, la narrazione diventa una forma di resistenza al nichilismo e al caos politico ed esistenziale che li circonda.
La letteratura contemporanea sulla migrazione riprende questo tema con una nuova urgenza: condividere la propria esperienza di esodo diventa un modo per ricostruire un’identità distrutta dal viaggio e dall’esilio. Scrittori come Amara Lakhous e Igiaba Scego sfruttano la narrazione come mezzo per sopravvivere culturalmente in società che spesso cercano di cancellare la loro esistenza.
Il tema trova anche potenti espressioni nel cinema: in “La storia fantastica” di Rob Reiner, un nonno racconta una storia al nipote malato per distrarlo dal suo dolore; in “La vita è bella” di Roberto Benigni, un padre trasforma gli orrori di un campo di concentramento in una narrazione giocosa per proteggere il figlio dalla cruda realtà.
L’aspetto psicologico del “narrare per sopravvivere” si allinea ai principi della terapia narrativa: creare e condividere la propria storia diventa uno strumento terapeutico per elaborare il trauma e ricostruire identità frammentate. Raccontare la propria storia permette agli individui di trasformare esperienze passive in narrazioni significative.
Il panorama digitale ha amplificato queste forme di narrazione salvavita: dai blog ai social media, le narrazioni quotidiane diventano un modo per esistere socialmente, costruire e mantenere relazioni e dare un senso a esperienze frammentate. La narrazione continua sui social media può essere vista come una rivisitazione moderna del meccanismo di Sheherazade.
Anche la letteratura per l’infanzia esplora spesso questo tema: raccontare fiabe ai bambini li aiuta a elaborare le paure primordiali e a sviluppare strategie simboliche per affrontare l’ignoto.
Bruno Bettelheim ha illustrato come le fiabe tradizionali servano da narrazioni salvifiche che permettono ai bambini di sopravvivere psicologicamente alle dure realtà della vita.
Conclusioni
Il legame tra narrazione e morte ci porta a una riflessione profonda: raccontare significa trasformare il tempo lineare e mortale in un ciclo che si ripete. Ogni volta che una storia viene narrata, il passato torna a vivere, i defunti riemergono, e ciò che sembrava irreversibile diventa di nuovo possibile. La narrazione si presenta quindi come una forma di resistenza umana contro il fluire del tempo e l’entropia dell’universo.
In questo contesto, ogni atto di narrazione segue la stessa logica di Sheherazade: rimandare la conclusione, trasformare il tempo in uno spazio di opportunità, e dare vita attraverso le parole. L’intera letteratura può essere vista come una grande strategia collettiva di sopravvivenza, dove ogni storia regala un giorno in più alla vita dell’umanità, e ogni racconto rappresenta una piccola vittoria contro il silenzio eterno.




