
Eguaglianza formale e sostanziale: un impegno costante per una società più giust…
28 Maggio 2025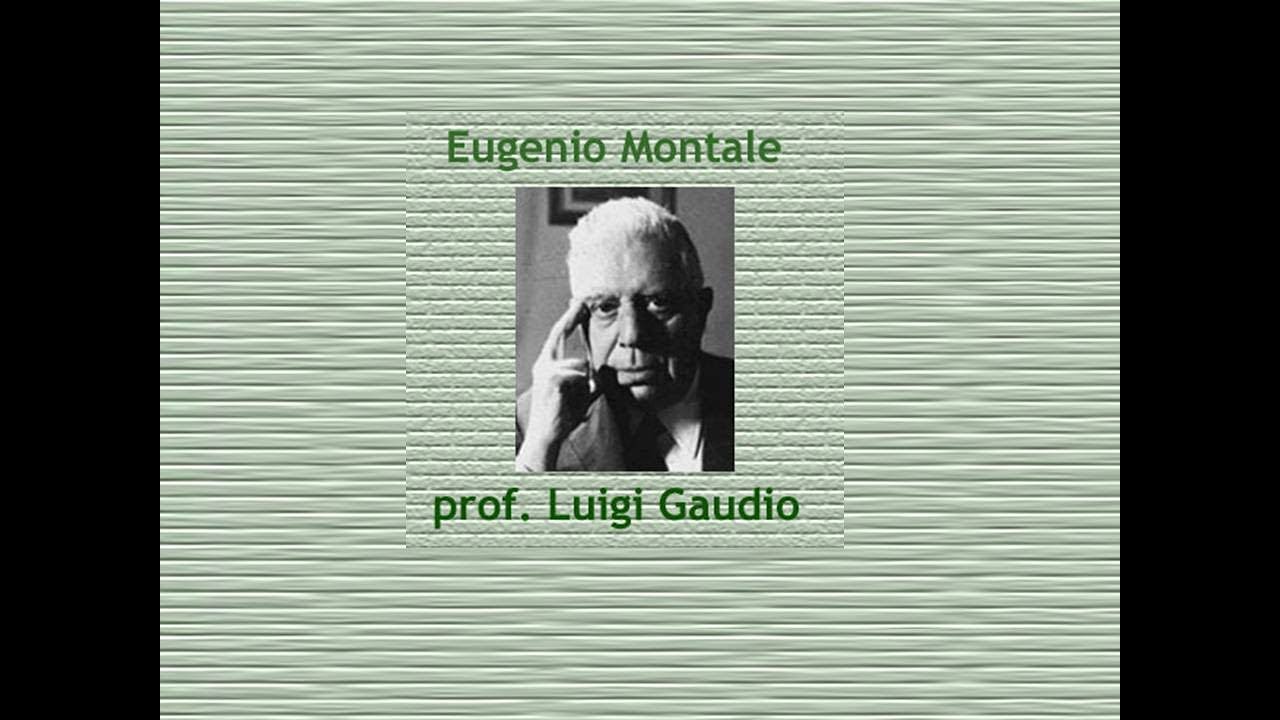
L’agave sullo scoglio di Eugenio Montale
28 Maggio 2025Analisi della poesia “Patria” di Giovanni Pascoli, con traccia di un compito per una classe quinta superiore e svolgimento
Traccia Tipologia A – Giovanni Pascoli, “Patria”
DA ESEMPI DI TRACCE del Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Giovanni Pascoli, Patria
Sogno d’un dí d’estate.
Quanto scampanellare
tremulo di cicale!
Stridule pel filare
moveva il maestrale
le foglie accartocciate
Scendea tra gli olmi il sole
in fascie polverose:
erano in ciel due sole
nuvole, tenui, róse[1]:
due bianche spennellate
in tutto il ciel turchino.
Siepi di melograno,
fratte di tamerice[2],
il palpito lontano
d’una trebbïatrice,
l’angelus argentino[3]…
dov’ero? Le campane
mi dissero dov’ero,
piangendo, mentre un cane
latrava al forestiero,
che andava a capo chino.
NOTE
[1] corrose
[2] cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)
[3] il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d’argento (argentino).
Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell’edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta.
Comprensione e analisi
- Individua brevemente i temi della poesia.
- In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d’un dí d’estate» possono essere entrambi riassuntivi dell’intero componimento?
- La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire.
- Qual è il significato dell’interrogativa “dov’ero” con cui inizia l’ultima strofa?
- Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come “forestiero”, una parola densa di significato.
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
Interpretazione
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l’espressione di un disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura dell’Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell’estraneità, della perdita, dell’isolamento dell’individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un “forestiero”. Approfondisci l’argomento in base alle tue letture ed esperienze.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Svolgimento Tipologia A – Giovanni Pascoli, “Patria”
1. Temi della poesia
La poesia Patria di Giovanni Pascoli affronta temi centrali nella poetica pascoliana:
- Il ricordo e la nostalgia della terra natale : il paesaggio è descritto come luogo dell’anima, carico di significati affettivi.
- Il contrasto tra sogno e realtà : il componimento si apre su un’immagine sognante e idilliaca, per chiudersi con una brusca interruzione che riporta il poeta al presente, segnato da estraneità e dolore.
- L’estraniamento esistenziale : l’atteggiamento del poeta nei confronti del mondo esterno rivela una sensazione di distacco, di non appartenenza.
Questi temi sono resi attraverso immagini semplici ma cariche di emozioni, e riflettono il senso di solitudine e di smarrimento che contraddistingue molta parte della sua opera.
2. Il titolo “Patria” e il primo verso “Sogno d’un dì d’estate”
Il titolo “Patria” , scelto nell’edizione definitiva della raccolta Myricae , funge da chiave interpretativa fondamentale: la poesia non è solo una descrizione estiva, ma un canto all’identità perduta, al luogo d’origine che vive soprattutto nel ricordo. La patria diventa quindi metafora del passato sereno, ormai irraggiungibile.
Il verso iniziale, “Sogno d’un dì d’estate” , introduce immediatamente il carattere onirico del testo, suggerendo che il paesaggio descritto non è reale, ma frutto della memoria o dell’immaginazione. Insieme al titolo, esso riassume i due piani principali del componimento: il sogno/pensiero nostalgico della patria e la sua irrealtà attuale . Questo duplice aspetto permette di leggere il testo come un’immersione emotiva nella dimensione del ricordo, con una successiva brusca caduta nella realtà.
3. Soluzioni metriche ed espressive per trasfigurare la natura
Pascoli utilizza una serie di soluzioni linguistiche e metriche che rendono la natura uno specchio dei suoi sentimenti:
- Musicalità del linguaggio : la presenza di suoni dolci e ripetuti (allitterazioni come “scampanellare”, “stridule”, “spennellate”) evoca un clima sospeso e malinconico.
- Immagini visive delicate : le “fascie polverose” del sole, le “due bianche spennellate” sul cielo azzurro, richiamano un paesaggio ovattato, quasi dipinto.
- Sinestesie : il “palpito” della trebbiatrice e l’“angelus argentino” uniscono udito e tatto, dando profondità sensoriale al paesaggio.
- Metrica irregolare e colloquiale : Pascoli usa versi liberi e strofe brevi, talvolta spezzati, che imitano il ritmo del pensiero e dell’emozione, più che seguire schemi rigidi. Questo contribuisce a dare al testo un tono intimo e confessionale.
- Ripetizioni e pause : elementi come la domanda “dov’ero?” e l’apparire improvviso delle campane e del cane introducono una tensione emotiva che rompe la quiete iniziale, traducendo in forma poetica il conflitto tra sogno e realtà.
4. Significato dell’interrogativa “dov’ero”
La frase “dov’ero?” segna lo spartiacque tra sogno e realtà . Essa esprime il momento in cui il poeta prende coscienza del proprio stato di estraniamento. Fino a quel punto, infatti, tutto sembrava immerso in una visione idilliaca; con questa domanda, invece, emerge il contrasto tra il sogno rasserenante e la realtà dolorosa.
Il poeta sembra chiedersi dove fosse realmente con la mente e con il cuore: era ancora nella calda estate del ricordo o già proiettato nel freddo presente? Questo interrogativo esprime un senso di spaesamento esistenziale, tipico della condizione umana moderna.
5. Ritorno alla realtà e definizione del poeta come “forestiero”
Il ritorno alla realtà avviene con forza grazie a un elemento sonoro: le campane e il latrato del cane. L’immagine del “forestiero” che cammina a testa china conclude il testo con un colpo emotivo netto. Questo termine, apparentemente neutro, assume un valore simbolico: il forestiero è chi non appartiene, chi si sente estraneo al luogo e al tempo in cui vive. Nella chiusura del componimento, il poeta si identifica implicitamente con questo personaggio, rivelando la sua condizione di isolamento , che va oltre il dato biografico per toccare una dimensione universale.
Il sogno, pur consolatorio, non riesce mai a cancellare completamente il dolore dell’esilio e della perdita: ecco perché il poeta si risveglia non in mezzo ai ricordi, ma in un ambiente ostile e indifferente.
Interpretazione complessiva e approfondimento critico
Il tema dello sradicamento e l’estraneità esistenziale
La condizione di estraneità vissuta da Pascoli in Patria è emblematica del suo modo di rapportarsi al mondo. Egli si sente sradicato , non solo fisicamente (fu costretto a lasciare San Mauro da giovane), ma anche spiritualmente: il paese natio non è più accessibile né geograficamente né temporalmente, e il ricordo si colora di malinconia e rimpianto.
Questo sentimento di estraniamento non è però unico a Pascoli: è un tema centrale nella letteratura italiana tra Otto e Novecento , che coglie la crisi dell’individuo moderno di fronte a un mondo che cambia, spesso ostile o incomprensibile.
Confronti con altre opere
- Ugo Foscolo , in Dei Sepolcri , esprime il dolore per la perdita del luogo natio e per il senso di abbandono che ne deriva, anche se in chiave più civile e meno introspettiva.
- Leopardi , in particolare in Canto notturno di un pastore errante dell’Asia , presenta una visione cosmica e disperata dell’esistenza: il pastore si sente forestiero rispetto al mondo, esattamente come Pascoli, ma senza speranza alcuna.
- Luigi Pirandello porterà all’estremo il senso di estraniamento: in Uno, nessuno e centomila , il protagonista si scopre estraneo a sé stesso, mentre nelle novelle e nei romanzi si rappresenta la difficoltà di comprendere e comunicare con gli altri, in un mondo frammentato e illusorio.
- Italo Svevo , in La coscienza di Zeno , mostra un io narrante che si sente fuori posto nella società borghese, incapace di integrarsi pienamente nella vita adulta e familiare.
Anche autori del Novecento come Giuseppe Ungaretti (Soldati , Veglia ) e Eugenio Montale (Cigola il vento , Spume ) esprimono il senso di isolamento e smarrimento dell’uomo contemporaneo, spesso in un contesto di guerra o di crisi morale.
In tutti questi casi, il tema dell’estraneità si accompagna a una riflessione sulla fragilità dell’individuo , sull’illusorietà del sogno e sul contrasto tra desiderio di appartenenza e impossibilità di realizzarlo.
Conclusione
La poesia Patria di Giovanni Pascoli, pur radicata nella sua esperienza personale di esilio e di perdita, riesce a elevarsi a metafora universale dell’uomo moderno , sempre in bilico tra sogno e realtà, tra il bisogno di radici e l’esperienza dello sradicamento. Il paesaggio, descritto con una sensibilità acutissima, diventa lo specchio di un’anima ferita, e la natura non offre conforto definitivo, ma momentaneo sollievo.
Il tema dell’estraneità e del disagio esistenziale è ricorrente nella letteratura italiana e mondiale, e Pascoli lo esprime con una potenza delicata e struggente, che anticipa molte poetiche successive. Il suo essere “forestiero”, sia dentro che fuori dal sogno, lo rende una figura emblematica dell’età moderna, in cui l’individuo fatica a trovare un posto nel mondo.




