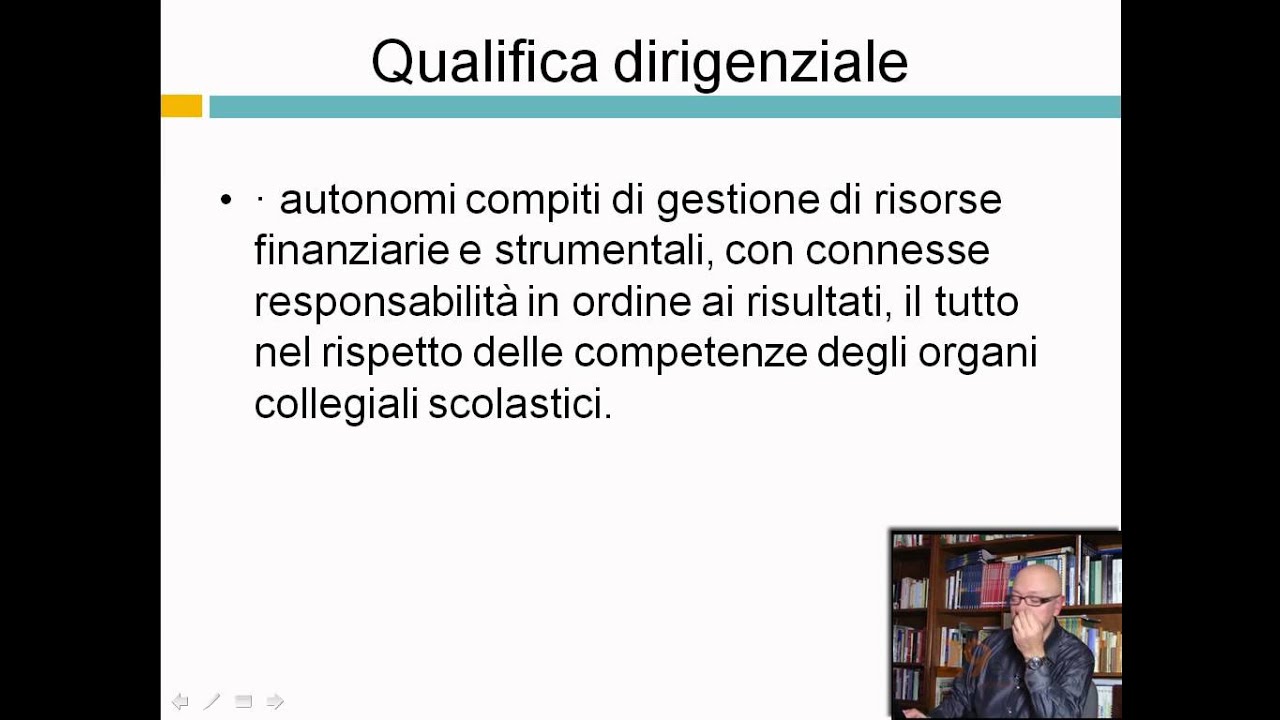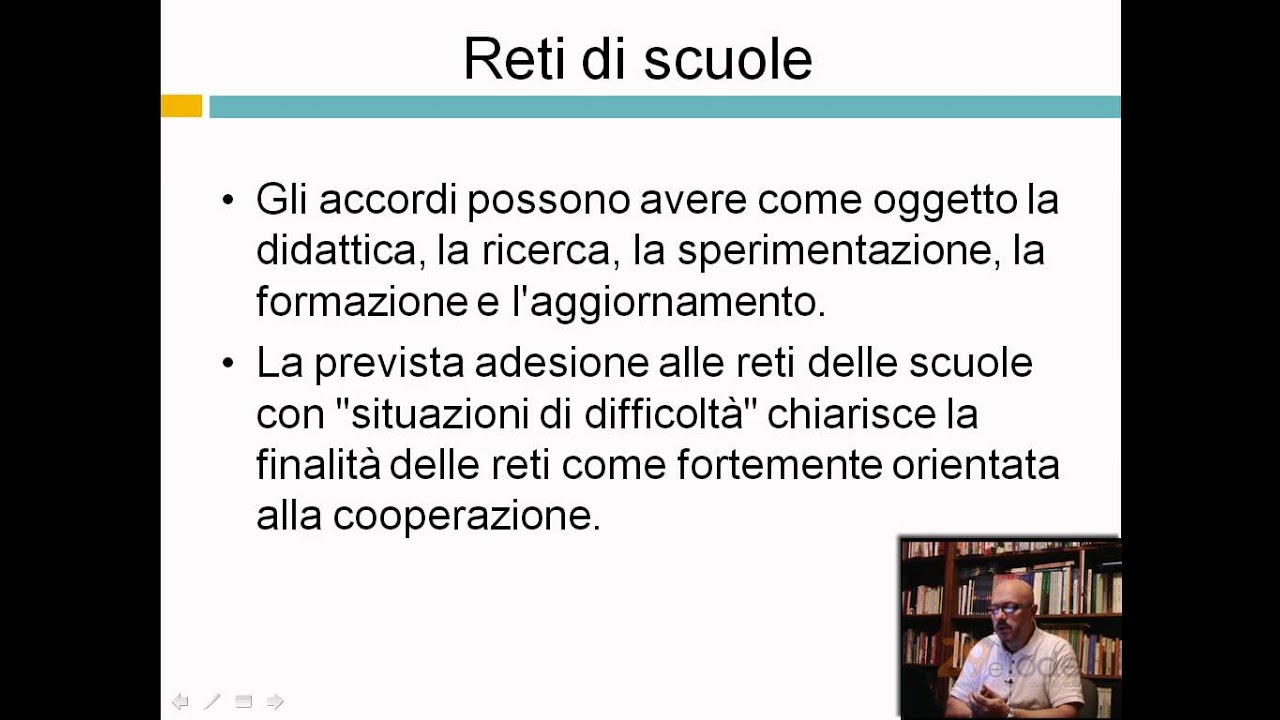
Scuola e territorio – Corso per dirigenti scolastici
28 Dicembre 2019
Ave Maria stella del mattino di Adriana Mascagni
28 Dicembre 2019Il Dirigente Scolastico: Ruolo e Responsabilità
Questo estratto da un video YouTube esamina la qualifica dirigenziale del dirigente scolastico in Italia. Il testo ripercorre l’evoluzione storica di questa figura, dalla legge sull’autonomia del 1997 che ha trasformato presidi e direttori didattici in dirigenti, ai riferimenti normativi attuali, in particolare l’articolo 25 del decreto legislativo 165 del 2001.
Viene sottolineato il passaggio da una figura prettamente burocratica a un ruolo di manager e leader, con autonomi poteri di direzione, coordinamento, gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, e la responsabilità sui risultati.
L’analisi tocca anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato e la valutazione dei dirigenti, sebbene quest’ultima sia spesso carente nella pratica. Infine, vengono illustrate le funzioni del dirigente scolastico nell’organizzazione scolastica, nella promozione della qualità formativa, nelle relazioni sindacali e nel garantire la libertà di insegnamento e il diritto all’apprendimento.
Questo breve video, in realtà, è solo una piccola parte di una videolezione che è possibile vedere nella sua versione integrale, lunga più di cinque volte tanto, acquistando, anche solo per un mese a prezzo ridotto, anche con carta docente e 18app, il corso sulla Dirigenza Scolastica su 29elode,
FAQ: domande e risposte sulla qualifica dirigenziale
Cos’è un Dirigente Scolastico e come si è evoluta questa figura?
La figura del Dirigente Scolastico, come la conosciamo oggi, è nata con la legge sull’autonomia scolastica (Legge 59 del 1997). Prima di questa legge, esistevano il “preside” e il “direttore didattico”. La qualifica dirigenziale è stata conferita ai capi d’istituto in concomitanza con l’acquisizione della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. Questo processo è stato disciplinato dal Decreto Legislativo 59 del 1998, che è poi confluito nell’articolo 25 del Decreto Legislativo 165 del 2001, il riferimento normativo attuale. I presidi e i direttori didattici in servizio all’epoca dovettero frequentare un corso di formazione specifico per acquisire la nuova qualifica.
Quali sono i compiti principali e le responsabilità di un Dirigente Scolastico?
Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, ne ha la rappresentanza legale ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Possiede autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, pur nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici. Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa, è titolare delle relazioni sindacali e promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione con il territorio. Inoltre, predispone le condizioni per il pieno esercizio della libertà di insegnamento e della scelta educativa delle famiglie, garantendo il diritto all’apprendimento degli alunni.
In che modo il ruolo del Dirigente Scolastico differisce da quello di un “burocrate ministeriale”?
A differenza di un “burocrate ministeriale” che si limiterebbe a implementare circolari, il Dirigente Scolastico gode di autonomia nella gestione e direzione. Con l’acquisizione dello status dirigenziale, gli sono stati affidati autonomi compiti di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, nonché compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, connesse responsabilità in ordine ai risultati. Questo significa che ha un potere decisionale significativo e una responsabilità diretta sui risultati della scuola, non essendo una mera “emanazione ministeriale”.
Qual è il rapporto tra il Dirigente Scolastico e gli organi collegiali scolastici?
La riforma che ha istituito la figura del Dirigente Scolastico ha mantenuto intatti i poteri preesistenti degli organi collegiali scolastici. Questo ha portato a una certa complessità nella divisione dei poteri e dei compiti all’interno della scuola, dato che gli organi collegiali non sono stati sostanzialmente riformati dopo la legge sull’autonomia. Nonostante i poteri autonomi del Dirigente, le sue azioni devono sempre rispettare le competenze di tali organi. Ad esempio, il Dirigente assume indirizzi e criteri dal Consiglio d’Istituto e indicazioni dal Collegio Docenti per la gestione delle risorse e del personale.
Come vengono conferiti gli incarichi dirigenziali ai Dirigenti Scolastici?
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e sono disciplinati dal contratto. L’affidamento e l’avvicendamento degli incarichi avvengono nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 165 del 2001. Tuttavia, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale ha la facoltà di confermare un incarico anche alla scadenza del tempo determinato, potendo rinnovarlo più volte.
Come viene valutato il Dirigente Scolastico e quali sono le sue responsabilità in termini di risultati?
I Dirigenti Scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono in ordine ai risultati, secondo quanto stabilito dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 165 del 2001, un articolo che riguarda tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni. La valutazione del Dirigente Scolastico dovrebbe essere effettuata da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto anche da esperti esterni. Tuttavia, la prassi attuale nella scuola italiana evidenzia una quasi assenza di valutazione sostanziale, salvo casi eccezionali o eclatanti in cui la necessità di tale valutazione diventa palese.
In che modo il Dirigente Scolastico promuove la qualità e l’innovazione didattica?
Il Dirigente Scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e predispone le condizioni per il pieno esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come ricerca e innovazione metodologico-didattica. Questo include la creazione di un ambiente che favorisca la ricerca didattica e l’innovazione nelle scuole, elementi cruciali per l’esercizio della libertà di insegnamento.
Qual è il significato dell’autonomia per le istituzioni scolastiche e per il Dirigente Scolastico?
L’autonomia delle istituzioni scolastiche, insieme all’acquisizione della personalità giuridica, è stata una condizione fondamentale per la creazione della figura del Dirigente Scolastico. Questa autonomia implica che le scuole non sono più semplici esecutrici di direttive ministeriali, ma entità con una propria capacità di gestione e decisione. Di conseguenza, il Dirigente Scolastico, non essendo un “burocrate”, ha autonomi poteri di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, il tutto con connesse responsabilità sui risultati. Questa autonomia è fondamentale per permettere al Dirigente di organizzare l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa.
Audio Lezioni sulla Pedagogia e organizzazione della scuola del prof. Gaudio
Ascolta “Pedagogia e organizzazione della scuola” su Spreaker.