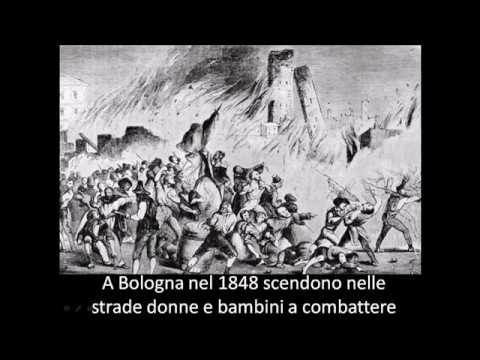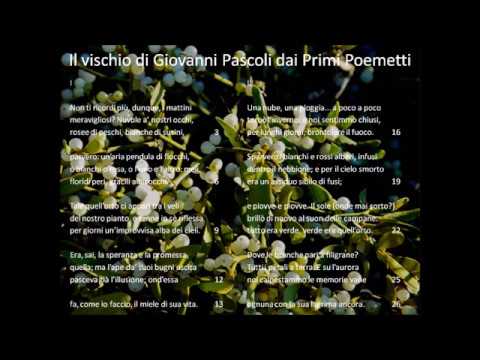
I poemetti e Il vischio di Giovanni Pascoli
28 Dicembre 2019
L’accoglienza di Telemaco a Sparta da parte di Menelao
28 Dicembre 2019Analisi del Brano “Qui c’è roba” da Mastro-don Gesualdo di Giovanni Verga
1. 🌟 Contesto Generale
Il brano è tratto dal romanzo Mastro-don Gesualdo di Giovanni Verga, un capolavoro del Verismo italiano che esplora la vita di un uomo dedito al lavoro e alla ricerca della ricchezza, ma che finisce per essere consumato dalle sue stesse ambizioni. Il protagonista, don Gesualdo Motta, è un uomo di umili origini che si eleva socialmente grazie al duro lavoro e all’accumulo di beni materiali. Tuttavia, la sua ascesa è accompagnata da una serie di tragedie personali e familiari, culminanti nella malattia che lo porta alla morte.
In questo passaggio, Verga descrive gli ultimi giorni di don Gesualdo, ormai ridotto a uno stato di debolezza fisica e psicologica estrema. La scena è dominata dal tema della decadenza: non solo quella fisica di don Gesualdo, ma anche quella morale e sociale della sua famiglia, che approfitta della sua malattia per saccheggiare i suoi averi.
2. 🖼️ Immagini e Simbolismo
1. La Decadenza Fisica di Don Gesualdo
- “Era ridotto quasi uno scheletro, pelle e ossa; soltanto il ventre era gonfio come un otre.”
Questa immagine drammatica rappresenta la trasformazione fisica di don Gesualdo, che passa da un uomo robusto e attivo a un corpo fragile e malato. Il contrasto tra “pelle e ossa” e il “ventre gonfio” simboleggia l’interno vuoto e corrotto di una persona che ha sacrificato tutto per il denaro. - “Ci aveva come una palla di piombo nello stomaco, che gli pesava, voleva uscir fuori, con un senso di pena continuo.”
La “palla di piombo” è un’immagine potente che evoca il peso delle preoccupazioni, dei rimpianti e della sofferenza interiore. È metaforicamente legata ai “bocconi amari” che don Gesualdo ha ingoiato durante la sua vita, ovvero le scelte difficili e i compromessi fatti per accumulare ricchezze.
2. Il Saccheggio della Casa
- “Vino, olio, formaggio, pezze di tela anche, sparivano in un batter d’occhio.”
La casa di don Gesualdo viene messa a sacco dai familiari e dai servi, che vedono nel suo declino fisico l’opportunità di appropriarsi dei suoi beni. Questo simboleggia la fragilità delle relazioni umane e il modo in cui il denaro può corrompere persino i legami più stretti. - “Qui c’è roba.”
L’affermazione di Bomma, il medico, è ambigua e carica di significato. Da un lato, si riferisce letteralmente alla presenza di qualcosa di anomalo nell’addome di don Gesualdo (forse un tumore o un problema intestinale grave). Dall’altro, “roba” può essere interpretato come un’allusione ironica alle ricchezze accumulate da don Gesualdo, che ora diventano oggetto di contesa tra i vivi mentre lui giace morente.
3. La Ricchezza come Maledizione
- “La mano di Dio che l’agguantava e l’affogava nelle ricchezze.”
Questa frase riflette il tema centrale del romanzo: la ricchezza, anziché portare felicità, diventa una maledizione che distrugge chi la insegue ossessivamente. Don Gesualdo, pur avendo raggiunto il successo economico, muore solo, abbandonato dalla famiglia e consumato dai rimpianti.
3. 💡 Temi Principali
1. La Fragilità Umana
Don Gesualdo, nonostante la sua forza e determinazione, è completamente impotente di fronte alla malattia. La sua condizione fisica riflette la fragilità della condizione umana, sottolineando come la ricchezza e il potere non possano proteggere dall’ineluttabilità della morte.
2. Il Denaro come Illusione
Il denaro, che per tutta la vita è stato l’obiettivo principale di don Gesualdo, si rivela inefficace nel momento del bisogno. Le parole furiose di don Gesualdo (“A che mi servono… se non posso comprare neanche la salute?”) evidenziano l’illusorietà del valore materiale e la vacuità delle sue conquiste.
3. La Corruzione Morale
La famiglia di don Gesualdo, anziché prendersi cura di lui, lo abbandona al suo destino, approfittando della sua debolezza per arraffare quanto più possibile. Questo comportamento mostra come il denaro possa corrompere i legami familiari e trasformare le persone in predatori.
4. 🎭 Tono e Stile
1. Realismo Crudo
Verga utilizza un linguaggio semplice e diretto per descrivere la sofferenza di don Gesualdo e il degrado morale della sua famiglia. Non ci sono abbellimenti o romanticismi: tutto è raccontato con crudezza, in linea con i principi del Verismo.
2. Ironia Amara
L’ironia permea il testo, soprattutto quando si parla del rapporto tra don Gesualdo e il denaro. Ad esempio, la frase “Qui c’è roba” assume un doppio significato: oltre a indicare il problema fisico di don Gesualdo, suggerisce sarcasticamente che la sua ricchezza è diventata il vero centro dell’attenzione.
3. Ritmo Incalzante
Il ritmo del brano è scandito dai dolori fisici di don Gesualdo e dalle azioni frenetiche dei personaggi secondari. Questo crea un senso di urgenza e tensione, enfatizzando la precarietà della situazione.
5. 🌌 Riflessione Finale
Il brano illustra magistralmente il tema della vanità delle ricchezze e del prezzo che si paga per inseguirle. Don Gesualdo, che ha dedicato tutta la vita all’accumulo di beni materiali, si ritrova solo e abbandonato nel momento della sua massima vulnerabilità. La sua storia è un monito sulle conseguenze distruttive dell’avidità e sulla fragilità delle conquiste terrene.
Riassumendo : 📜 Il brano da Mastro-don Gesualdo di Verga mette in luce la decadenza fisica e morale del protagonista, simboleggiando la vacuità delle ricchezze e il prezzo dell’ossessione per il denaro. 🌟
6. 📖 Testo originale del brano di Giovanni Verga “Qui c’è roba, Mastro don Gesualdo“
– Non è niente… un po’ di colica. Ho avuto dei dispiaceri. Domani mi alzerò…
Ma non ci credeva più neppur lui, e non si alzava mai. Era ridotto quasi uno scheletro, pelle e ossa; soltanto il ventre era gonfio come un otre. Nel paese si sparse la voce che era spacciato: la mano di Dio che l’agguantava e l’affogava nelle ricchezze.
Qui c’è roba, Mastro don Gesualdo
Non gli davano retta neppur quando tornava a balbettare, spaventato da quelle facce serie: – Mi sento meglio. Domani mi alzo. Mandatemi in campagna che guarirò in ventiquattr’ore. – Gli dicevano di sì, per contentarlo, come a un bambino. – Domani, doman l’altro. – Ma lo tenevano lì, per smungerlo, per succhiargli il sangue, medici, parenti e speziali. Lo voltavano, lo rivoltavano, gli picchiavano sul ventre con due dita, gli facevano bere mille porcherie, lo ungevano di certa roba che gli apriva dei vescicanti sullo stomaco. C’era di nuovo sul cassettone un arsenale di rimedi, come negli ultimi giorni di Bianca, buon’anima. Egli borbottava, tentennando il capo. – Siamo già ai medicamenti che costano cari! Vuol dire che non c’è più rimedio. – Il denaro a fiumi, un va e vieni, una baraonda per la casa, tavola imbandita da mattina a sera. Burgio, che non c’era avvezzo, correva a mostrare la lingua ai medici, come venivano pel cognato; Santo non usciva più nemmeno per andare all’osteria; e i nipoti, quando tornavano dai poderi, si pigliavano pei capelli: liti e quistioni fra di loro che facevano a chi più arraffa, degli strepiti che arrivavano fin nella camera dell’infermo, il quale tendeva l’orecchio, smanioso di sapere quello che facevano della sua roba, e anche lui si metteva a strillare dal letto:
– Lasciatemi andare a Mangalavite. Ci ho tutti i miei interessi alla malora. Qui mi mangio il fegato. Lasciatemi andare, se no crepo!
Ci aveva come una palla di piombo nello stomaco, che gli pesava, voleva uscir fuori, con un senso di pena continuo; di tratto in tratto, si contraeva, s’arroventava e martellava, e gli balzava alla gola, e lo faceva urlare come un dannato, e gli faceva mordere tutto ciò che capitava.
Egli rimaneva sfinito, anelante, col terrore vago di un altro accesso negli occhi stralunati. Tutto ciò che ingoiava per forza, per aggrapparsi alla vita, i bocconi più rari, senza chiedere quel che costassero, gli si mutavano in veleno; tornava a rigettarli come roba scomunicata, più nera dell’inchiostro, amara, maledetta da Dio. E intanto i dolori e la gonfiezza crescevano: una pancia che le gambe non la reggevano più. Bomma, picchiandovi sopra, una volta disse: – Qui c’è roba.
– Che volete dire, vossignoria? – balbettò don Gesualdo, balzando a sedere sul letto, coi sudori freddi addosso.
Bomma lo guardò bene in faccia, accostò la seggiola, si voltò di qua e di là per vedere s’erano soli.
– Don Gesualdo, siete un uomo… Non siete più un ragazzo, eh?
– Sissignore, – rispose lui con voce ferma, calmatosi a un tratto, col coraggio che aveva sempre avuto al bisogno. – Sissignore, parlate.
– Bene, qui ci vuole un consulto. Non avete mica una spina di fico d’India nel ventre! È un affare serio, capite! Non è cosa per la barba di don Margheritino o di qualcun altro… sia detto senza offenderli, qui in confidenza. Chiamate i migliori medici forestieri, don Vincenzo Capra, il dottor Muscio di Caltagirone, chi volete… Denari non ve ne mancano…
A quelle parole don Gesualdo montò in furia: – I denari!… Vi stanno a tutti sugli occhi i denari che ho guadagnato!… A che mi servono… se non posso comprare neanche la salute?… Tanti bocconi amari m’hanno dato… sempre!…