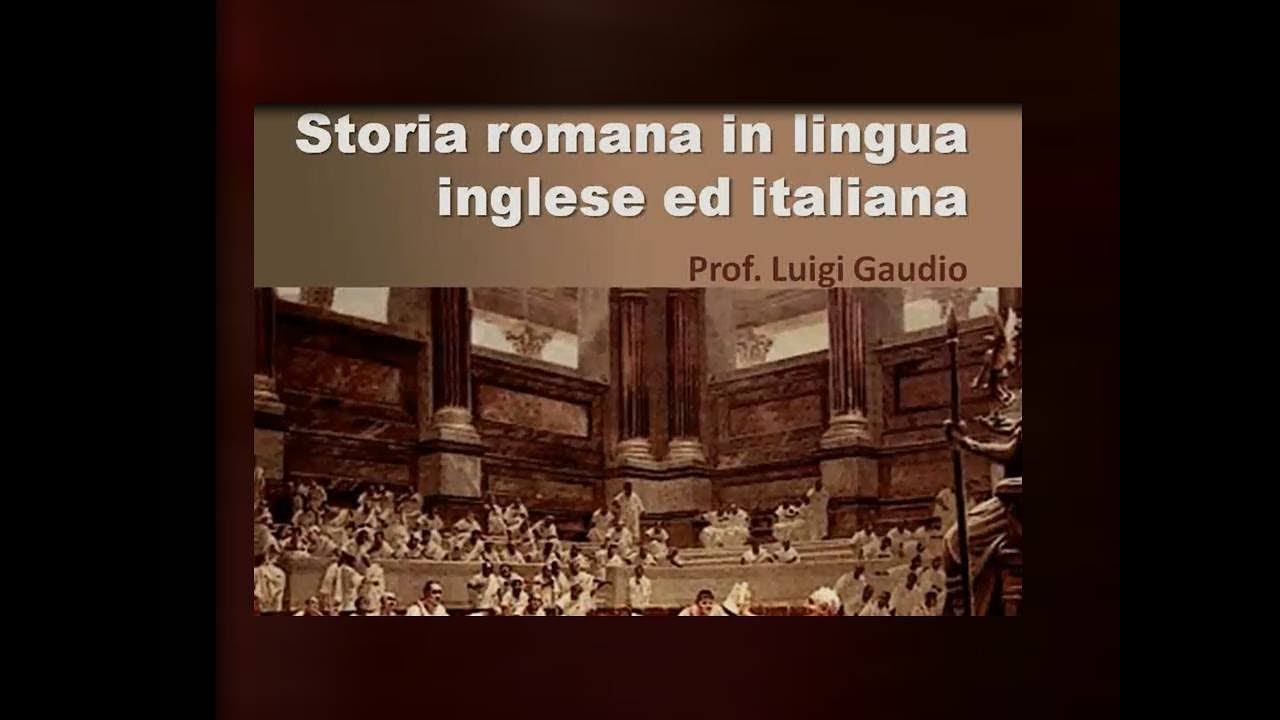
Andare a scuola a Roma
28 Dicembre 2019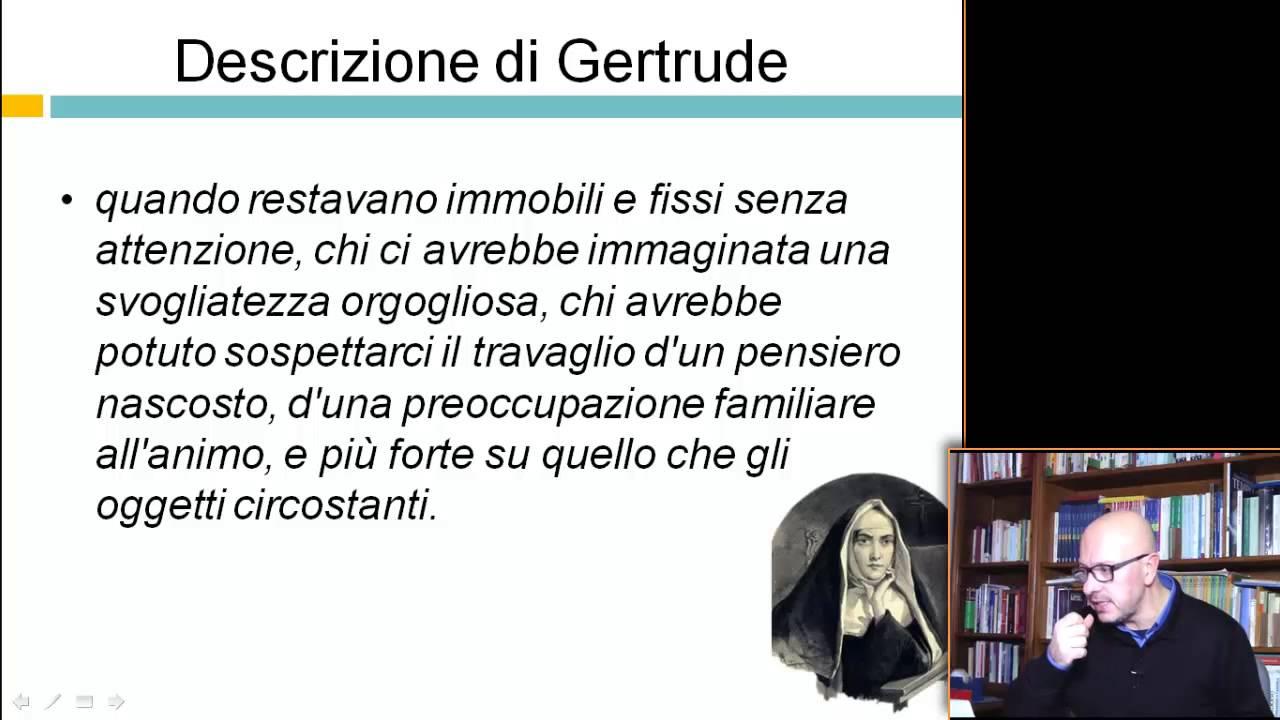
Capitoli nono e decimo dei Promessi Sposi
28 Dicembre 2019📚 Analisi approfondita dei Capitoli XXI e XXIII de I Promessi Sposi, saltando la digressione sul cardinale del Capitolo XXII
Analisi Approfondita dei Capitoli XXI e XXIII de ‘I Promessi Sposi’: Il Tormento dell’Innominato e le Conseguenze della Conversione
I Capitoli XXI e XXIII de I Promessi Sposi, pur separati dalla cruciale narrazione della conversione dell’Innominato (Capitolo XXII), formano un blocco tematico che illustra in modo vivido le dinamiche del male e del bene, la sofferenza degli innocenti e l’efficacia della Provvidenza. Il Capitolo XXI ci cala nella profondità della crisi morale di un uomo votato al male, innescata dalla purezza della vittima; il Capitolo XXIII ne esplora le immediate conseguenze, mettendo in luce i primi passi di una redenzione che impatta la vita di Lucia e introduce nuove complessità.
Capitolo XXI: La Notte Orribile e la Nascita del Rimorso
Il Capitolo XXI è un vertice narrativo e psicologico del romanzo, interamente incentrato sul rapimento e la prigionia di Lucia nel castello dell’Innominato e sulla drammatica crisi interiore che questa vicenda scatena nel signore.
1. Il Rapimento e la Prigionia di Lucia: Il capitolo inizia con il culmine dell’atto di violenza: Lucia viene brutalmente rapita e trasportata in carrozza verso l’inespugnabile castello dell’Innominato. Manzoni descrive la sua condizione di terrore e sfinimento: Lucia è “come intontita”, la sua mente è un turbine di paura e disorientamento. Il viaggio frenetico, il “furore de’ cavalli” e il “frastuono delle ruote” diventano metafore della sua perdita di controllo e del suo stato di incubo. Ogni tentativo di chiedere aiuto viene soffocato, accentuando il suo isolamento e la sua totale vulnerabilità. L’arrivo al castello, descritto come un “nido” sinistro “posto a cavaliere a una giogaia di monti”, con le sue “muraglie nude, scoscese”, amplifica l’orrore e la disperazione di Lucia, che si sente ormai perduta. Lì viene accolta da una “vecchia serva” dell’Innominato, un personaggio anch’esso segnato dal male, ormai insensibile alla compassione, che la conduce nella sua fredda e buia “stanzaccia”, una vera e propria prigione.
2. L’Incontro tra l’Innocenza e il Male Assoluto: Il momento più significativo del capitolo è l’incontro tra l’Innominato e Lucia. L’Innominato, un uomo la cui reputazione di spietatezza e impunità lo precede, un signore che ha accumulato innumerevoli delitti e che vive al di fuori di ogni legge, si trova inaspettatamente di fronte a una forza che non può soggiogare: la purezza e la disperazione inerme di Lucia. Lucia, spinta dal terrore e dalla fede, si getta in ginocchio, supplicandolo con parole che, pur tremolanti, portano con sé una forza quasi “d’ispirazione”. Invoca la misericordia e la giustizia divina: “Lei che può comandare, e può far tanto, faccia un atto di misericordia, un atto di giustizia… Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia! Faccia questa, lei che può; mi liberi… Non mi vuole far fare un peccato!”. Queste parole semplici, intrise di fede pura, e la sua sofferenza innocente, penetrano l’animo indurito del tiranno. La reazione dell’Innominato è sorprendente e inattesa. Per la prima volta nella sua vita, si sente “toccato da una compassione fin allora sconosciuta”. Avverte un “non so che di nuovo”, un “moto d’inquietudine” e un “rimorso confuso”. Questa è la prima crepa nel suo animo di pietra. Per la prima volta, si ritira senza aver completato il suo proposito malvagio, segno che la grazia ha iniziato a operare.
3. Il Voto di Lucia e la Notte di Tormento dell’Innominato: Abbandonata nella sua prigione, Lucia, nella sua totale solitudine e disperazione, cerca rifugio in un atto estremo di fede e sacrificio: pronuncia un voto solenne alla Madonna: “Vergine santissima… io ti prometto di rimaner vergine… purché tu mi salvi… io rinunzio per sempre al mio povero Renzo, per non essere mai più d’altri che tua.” Questo voto è un tentativo disperato di dare un senso alla sua sofferenza, un patto con il sacro per ottenere la salvezza. È un sacrificio della sua felicità terrena (la promessa a Renzo) in cambio della vita e della protezione divina.
Contemporaneamente, il capitolo si concentra sulla “notte orribile” dell’Innominato. Per la prima volta, la sua coscienza si ribella con forza. I suoi innumerevoli delitti passati lo perseguitano, tormentandolo con un rimorso fino ad allora sconosciuto.
- La Nuova Paura: L’Innominato sperimenta una “paura” mai provata prima: non la paura degli uomini o delle conseguenze terrene, ma una paura metafisica, un terrore del giudizio divino e della morte. Questa paura, incontrollabile e opprimente, lo spinge a un’introspezione forzata.
- Il Vuoto Esistenziale: La sua vita di violenza e potere gli appare improvvisamente priva di significato, “vuota”. Sente un “fastidio della vita” e un insopportabile “tedio” della sua stessa esistenza. La sua anima è un “inferno”, e l’idea del suicidio lo tenta, ma un residuo di istinto e, forse, una primordiale fede lo trattengono.
- La Luce dell’Alba e la Decisione: La crisi culmina simbolicamente con l’arrivo dell’alba. I primi raggi di sole che penetrano nella sua stanza buia rappresentano la luce della speranza e della grazia. Il suono delle campane festive dal paese vicino (per la visita del Cardinale Borromeo, evento ancora ignoto all’Innominato) lo spinge a un’improvvisa e inattesa decisione: recarsi dal Cardinale, un gesto che segna l’inizio della sua conversione e redenzione.
Capitolo XXIII: Le Conseguenze della Conversione e i Nuovi Ostacoli
Il Capitolo XXIII ci presenta le immediate ripercussioni della spettacolare conversione dell’Innominato (narrata nel Capitolo XXII, che qui si salta). Il focus si sposta sulla liberazione di Lucia e sulle nuove, complesse sfide che si presentano ai protagonisti.
1. La Liberazione di Lucia e l’Incontro con il Cardinale: Il Cardinale Federigo Borromeo, dopo aver accolto l’Innominato pentito, si reca immediatamente al castello per liberare Lucia. Questo atto è un chiaro segno della carità e dell’azione concreta della Chiesa. Lucia, liberata dalla sua prigione, si trova di fronte al Cardinale. L’incontro è carico di emotività: Lucia, piena di gratitudine, si prostra, ma è incapace di raccontare la sua storia, troppo prostrata dalla sofferenza e dalla sua innata ritrosia a parlare della sua vicenda personale.
2. La Presenza e l’Azione del Cardinale Borromeo: Il Cardinale Borromeo si conferma come una figura di immensa autorità morale e di profonda carità. Nonostante la sua alta posizione, si china sugli umili e agisce con pragmatismo e sollecitudine pastorale.
- Pastoralità e Saggezza: Il Cardinale comprende lo stato d’animo di Lucia e, con delicatezza, non la forza a parlare. Affida la giovane a Don Ferrante e Donna Prassede, due nobili milanesi, ritenendoli persone di sicura moralità. Questo atto, pur mosso da buone intenzioni, avrà sviluppi imprevisti per Lucia, che si troverà in una casa dove la carità è spesso confusa con la pedanteria e il giudizio.
- La gestione della Monaca di Monza: La liberazione di Lucia porta il Cardinale a confrontarsi con la Monaca di Monza, Gertrude. Borromeo, informato forse dall’Innominato e intuendo il dramma della monaca, si reca al monastero. Egli affronta Gertrude con delicatezza e fermezza, cercando di penetrare il suo cuore indurito. Manzoni, pur non approfondendo qui la loro conversazione (poiché la storia di Gertrude è stata narrata nel Capitolo X), sottolinea il tentativo del Cardinale di aiutarla a riconoscere e affrontare i suoi peccati. La reazione di Gertrude, che si mostra inizialmente fredda e altera, ma poi sembra scossa dalle parole del Cardinale, è un preludio alla possibilità di una sua, seppur parziale, redenzione.
3. I Nuovi Ostacoli: Il Voto di Lucia e la Lontananza di Renzo: La liberazione di Lucia, tuttavia, non è una soluzione immediata a tutti i suoi problemi.
- Il Voto: Il voto di castità fatto da Lucia nella prigione dell’Innominato diventa un nuovo, gravissimo ostacolo alla sua unione con Renzo. Lucia si sente vincolata da questa promessa fatta a Dio in un momento di estrema disperazione. Questo voto introduce una complicazione teologica e morale che sarà centrale per gran parte della trama successiva e fonte di profonda sofferenza per Lucia e Renzo.
- La Separazione e l’Incertezza: Lucia è al sicuro, ma è lontana dal suo paese, separata da Agnese e ignara del destino di Renzo, che ora è un ricercato. La sua nuova dimora, seppur sicura, è estranea e impone nuove sfide.
4. L’Innominato e la Nuova Vita: Il Capitolo XXIII mostra l’Innominato che inizia concretamente la sua nuova vita. Ritorna al suo castello trasformato, non più signore della violenza, ma uomo di fede e carità. La sua conversione ha un impatto immediato sul territorio circostante: la violenza diminuisce, le ingiustizie vengono sanate. Egli diventa un esempio vivente della grazia divina.
Connessione Tematica tra Capitolo XXI e XXIII: Provvidenza, Crisi e Redenzione
I Capitoli XXI e XXIII sono intrinsecamente legati e rappresentano un potente percorso di cause ed effetti nel disegno manzoniano:
- L’Opera della Provvidenza: La Provvidenza Divina è il filo conduttore. Il rapimento di Lucia (un atto malvagio) diventa lo strumento attraverso cui la grazia divina opera la conversione dell’Innominato (Capitolo XXI). Questa conversione, a sua volta, è la causa diretta della liberazione di Lucia e del suo ricovero (Capitolo XXIII). Il male è utilizzato come occasione per il bene.
- Dalla Crisi Individuale alle Conseguenze Collettive: Il Capitolo XXI si concentra sulla crisi interiore dell’Innominato, un dramma personale e spirituale. Il Capitolo XXIII mostra le conseguenze concrete di questa trasformazione sull’individuo (Lucia liberata) e sulla comunità (l’ordine ristabilito nel territorio dell’Innominato). La redenzione di un singolo porta beneficio a molti.
- La Sofferenza come Strumento: La sofferenza di Lucia nel Capitolo XXI, la sua preghiera e il suo voto, sono elementi catalizzatori per la crisi dell’Innominato. Nel Capitolo XXIII, la sua sofferenza continua, seppur in una condizione di sicurezza, a causa del voto e della separazione, dimostrando che la Provvidenza non elimina ogni ostacolo, ma offre le vie per affrontarli.
- La Chiesa come Agente di Bene: Il Cardinale Federigo Borromeo emerge come figura esemplare della carità e della saggezza pastorale della Chiesa, che agisce attivamente per sanare le ferite sociali e spirituali. La sua presenza è un punto di riferimento morale e pratico, a differenza delle autorità civili spesso assenti o corrotte.
In conclusione, i Capitoli XXI e XXIII, pur saltando il fondamentale momento della conversione diretta (Capitolo XXII), disegnano un quadro completo dell’azione della grazia. Il tormento notturno dell’Innominato nel XXI capitolo è il preludio necessario alla sua trasformazione e alla conseguente liberazione di Lucia nel XXIII. Manzoni ci mostra come la fede e la Provvidenza possano sovvertire il male e aprire nuove strade, sebbene non senza nuove sfide e prove per i suoi personaggi.
Testo del ventunesimo capitolo dei Promessi Sposi

CAPITOLO XXI
La vecchia era corsa a ubbidire e a comandare, con l’autorità di quel nome che, da chiunque fosse pronunziato in quel luogo, li faceva spicciar tutti; perchè a nessuno veniva in testa che ci fosse uno tanto ardito da servirsene falsamente. Si trovò infatti alla Malanotte un po’ prima che la carrozza ci arrivasse; e vistala venire, uscì di bussola, fece segno al cocchiere che fermasse, s’avvicinò allo sportello; e al Nibbio, che mise il capo fuori, riferì sottovoce gli ordini del padrone.
Lucia, al fermarsi della carrozza, si scosse, e rinvenne da una specie di letargo. Si sentì da capo rimescolare il sangue, spalancò la bocca e gli occhi, e guardò. Il Nibbio s’era tirato indietro; e la vecchia, col mento sullo sportello, guardando Lucia, diceva: “venite, la mia giovine; venite, poverina; venite con me, che ho ordine di trattarvi bene e di farvi coraggio.”
Al suono d’una voce di donna, la poverina provò un conforto, un coraggio momentaneo; ma ricadde subito in uno spavento più cupo. “Chi siete?” disse con voce tremante, fissando lo sguardo attonito in viso alla vecchia.

“Venite, venite, poverina,” andava questa ripetendo. Il Nibbio e gli altri due, argomentando dalle parole e dalla voce così straordinariamente raddolcita di colei, quali fossero l’intenzioni del signore, cercavano di persuader con le buone l’oppressa a ubbidire. Ma lei seguitava a guardar fuori; e benchè il luogo selvaggio e sconosciuto, e la sicurezza de’ suoi guardiani non le lasciassero concepire speranza di soccorso, apriva non ostante la bocca per gridare; ma vedendo il Nibbio far gli occhiacci del fazzoletto, ritenne il grido, tremò, si storse, fu presa e messa nella bussola. Dopo, c’entrò la vecchia; il Nibbio disse ai due altri manigoldi che andassero dietro, e prese speditamente la salita, per accorrere ai comandi del padrone.
“Chi siete?” domandava con ansietà Lucia al ceffo sconosciuto e deforme: “perchè son con voi? dove sono? dove mi conducete?”
“Da chi vuol farvi del bene,” rispondeva la vecchia, “da un gran… Fortunati quelli a cui vuol far del bene! Buon per voi, buon per voi. Non abbiate paura, state allegra, chè m’ha comandato di farvi coraggio. Glielo direte, eh? che v’ho fatto coraggio?”
“Chi è? perchè? che vuol da me? Io non son sua. Ditemi dove sono; lasciatemi andare; dite a costoro che mi lascino andare, che mi portino in qualche chiesa. Oh! voi che siete una donna, in nome di Maria Vergine…!”
Quel nome santo e soave, già ripetuto con venerazione ne’ primi anni, e poi non più invocato per tanto tempo, nè forse sentito proferire, faceva nella mente della sciagurata che lo sentiva in quel momento, un’impressione confusa, strana, lenta, come la rimembranza della luce, in un vecchione accecato da bambino.
Intanto l’innominato, ritto sulla porta del castello, guardava in giù; e vedeva la bussola venir passo passo, come prima la carrozza, e avanti, a una distanza che cresceva ogni momento, salir di corsa il Nibbio. Quando questo fu in cima, il signore gli accennò che lo seguisse; e andò con lui in una stanza del castello.
“Ebbene?” disse, fermandosi lì.
“Tutto a un puntino ” rispose, inchinandosi, il Nibbio: “l’avviso a tempo, la donna a tempo, nessuno sul luogo, un urlo solo, nessuno comparso, il cocchiere pronto, i cavalli bravi, nessun incontro: ma…”
“Ma che?”
“Ma… dico il vero, che avrei avuto più piacere che l’ordine fosse stato di darle una schioppettata nella schiena, senza sentirla parlare, senza vederla in viso.”
“Cosa? cosa? che vuoi tu dire?”
“Voglio dire che tutto quel tempo, tutto quel tempo… M’ha fatto troppa compassione.”
“Compassione! Che sai tu di compassione? Cos’è la compassione?”
“Non l’ho mai capito così bene come questa volta: è una storia la compassione un poco come la paura: se uno la lascia prender possesso, non è più uomo.”
“Sentiamo un poco come ha fatto costei per moverti a compassione.”
“O signore illustrissimo! tanto tempo…! piangere, pregare, e far cert’occhi, e diventar bianca bianca come morta, e poi singhiozzare, e pregar di nuovo, e certe parole…”
— Non la voglio in casa costei, — pensava intanto l’innominato. — Sono stato una bestia a impegnarmi; ma ho promesso, ho promesso. Quando sarà lontana… — E alzando la testa, in atto di comando, verso il Nibbio, “ora,” gli disse, “metti da parte la compassione: monta a cavallo, prendi un compagno, due se vuoi; e va’ di corsa a casa di quel don Rodrigo che tu sai. Digli che mandi… ma subito subito, perchè altrimenti…”
Ma un altro no interno più imperioso del primo gli proibì di finire. “No,” disse con voce risoluta, quasi per esprimere a sè stesso il comando di quella voce segreta, “no: va’ a riposarti; e domattina… farai quello che ti dirò!”
— Un qualche demonio ha costei dalla sua, – pensava poi, rimasto solo, ritto, con le braccia incrociate sul petto, e con lo sguardo immobile sur una parte del pavimento, dove il raggio della luna, entrando da una finestra alta, disegnava un quadrato di luce pallida, tagliata a scacchi dalle grosse inferriate, e intagliata più minutamente dai piccoli compartimenti delle vetriate.

Un qualche demonio, o…. un qualche angelo che la protegge…. Compassione al Nibbio!…. Domattina, domattina di buon’ora, fuor di qui costei; al suo destino, e non se ne parli più, e, — proseguiva tra sè, con quell’animo con cui si comanda a un ragazzo indocile, sapendo che non ubbidirà — e non ci si pensi più. Quell’animale di don Rodrigo non mi venga a romper la testa con ringraziamenti; che…. non voglio più sentir parlar di costei. L’ho servito perchè…. perchè ho promesso: e ho promesso perchè…. è il mio destino. Ma voglio che me lo paghi bene questo servizio, colui. Vediamo un poco…. —
E voleva almanaccare cosa avrebbe potuto richiedergli di scabroso per compenso, e quasi per pena; ma gli si attraversaron di nuovo alla mente quelle parole: compassione al Nibbio! — Come può aver fatto costei? – continuava, strascinato da quel pensiero. — Voglio vederla…. Eh! no…. Sì, voglio vederla.
E d’una stanza in un’altra, trovò una scaletta, e su a tastone, andò alla camera della vecchia, e picchiò all’uscio con un calcio.
“ Chi è? ”
“ Apri. ”
A quella voce, la vecchia fece tre salti; e subito si sentì scorrere il paletto negli anelli, e l’uscio si spalancò. L’innominato, dalla soglia, diede un’occhiata in giro; e, al lume d’una lucerna che ardeva sur un tavolino, vide Lucia rannicchiata in terra, nel canto il più lontano dall’uscio.
“ Chi t’ha detto che tu la buttassi là come un sacco di cenci, sciagurata? ” disse alla vecchia, con un cipiglio iracondo.
“ S’è messa dove le è piaciuto, ” rispose umilmente colei: “ io ho fatto di tutto per farle coraggio: lo può dire anche lei; ma non c’è stato verso. ”
“ Alzatevi, ” disse l’innominato a Lucia, andandole vicino. Ma Lucia, a cui il picchiare, l’aprire, il comparir di quell’uomo, le sue parole, avevan messo un nuovo spavento nell’animo spaventato, stava più che mai raggomitolata nel cantuccio, col viso nascosto tra le mani, e non movendosi, se non che tremava tutta.
“ Alzatevi, chè non voglio farvi del male…. e posso farvi del bene, ” ripetè il signore…. “ Alzatevi! ” tonò poi quella voce, sdegnata d’aver due volte comandato invano.
Come rinvigorita dallo spavento, l’infelicissima si rizzò subito inginocchioni; e giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un’immagine, alzò gli occhi in viso all’innominato, e riabbassandoli subito, disse: “ son qui: m’ammazzi. ”
“ V’ho detto che non voglio farvi del male, ” rispose, con voce mitigata, l’innominato, fissando quel viso turbato dall’accoramento e dal terrore.
“ Coraggio, coraggio, ” diceva la vecchia: “ se ve lo dice lui, che non vuol farvi del male…. ”
“ E perchè, ” riprese Lucia con una voce, in cui, col tremito della paura, si sentiva una certa sicurezza dell’indegnazione disperata, “ perchè mi fa patire le pene dell’inferno? Cosa le ho fatto io?…. ”

“ V’hanno forse maltrattata? Parlate. ”
“ Oh maltrattata! M’hanno presa a tradimento, per forza! perchè?
perchè m’hanno presa? perchè son qui? dove sono? Sono una povera creatura: cosa le ho fatto? In nome di Dio…. ”
“ Dio, Dio, ” interruppe l’innominato: “ sempre Dio: coloro che non possono difendersi da sè, che non hanno la forza, sempre han questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con codesta vostra parola? Di farmi….? ” e lasciò la frase a mezzo.
“ Oh Signore! pretendere! Cosa posso pretendere io meschina, se non che lei mi usi misericordia? Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia! Mi lasci andare; per carità mi lasci andare! Non torna conto a uno che un giorno deve morire di far patir tanto una povera creatura. Oh! lei che può comandare, dica che mi lascino andare! M’hanno portata qui per forza. Mi mandi con questa donna a ***, dov’è mia madre. Oh Vergine santissima! mia madre! mia madre, per carità, mia madre! Forse non è lontana di qui…. ho veduto i miei monti! Perchè lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa. Pregherò per lei, tutta la mia vita. Cosa le costa dire una parola? Oh ecco! vedo che si move a compassione: dica una parola, la dica. Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia! ”
— Oh perchè non è figlia d’uno di que’ cani che m’hanno bandito! — pensava l’innominato: — d’uno di que’ vili che mi vorrebbero morto! che ora godrei di questo suo strillare; e in vece…. —
“ Non iscacci una buona ispirazione! ” proseguiva fervidamente Lucia, rianimata dal vedere una cert’aria d’esitazione nel viso e nel contegno del suo tiranno. “ Se lei non mi fa questa carità, me la farà il Signore: mi farà morire, e per me sarà finita; ma lei!…. Forse un giorno anche lei…. Ma no, no; pregherò sempre io il Signore che la preservi da ogni male. Cosa le costa dire una parola? Se provasse lei a patir queste pene….! ”
“ Via, fatevi coraggio, ” interruppe l’innominato, con una dolcezza che fece strasecolar la vecchia. “ V’ho fatto nessun male? V’ho minacciata? ”
“ Oh no! Vedo che lei ha buon cuore, e che sente pietà di questa povera creatura. Se lei volesse, potrebbe farmi paura più di tutti gli altri, potrebbe farmi morire; e in vece mi ha…. un po’ allargato il cuore. Dio gliene renderà merito. Compisca l’opera di misericordia: mi liberi, mi liberi. ”
“ Domattina…. ”
“ Oh mi liberi ora, subito…. ”
“ Domattina ci rivedremo, vi dico. Via, intanto fatevi coraggio. Riposate. Dovete aver bisogno di mangiare. Ora ve ne porteranno. ”
“ No, no; io moio se alcuno entra qui: io moio. Mi conduca lei in chiesa…. que’ passi Dio glieli conterà. ”
“ Verrà una donna a portarvi da mangiare, ” disse l’innominato; e dettolo, rimase stupito anche lui che gli fosse venuto in mente un tal ripiego, e che gli fosse nato il bisogno di cercarne uno, per rassicurare una donnicciola.
“ E tu, ” riprese poi subito, voltandosi alla vecchia, “ falle coraggio che mangi; mettila a dormire in questo letto: e se ti vuole in compagnia, bene; altrimenti, tu puoi ben dormire una notte in terra. Falle coraggio, ti dico; tienla allegra. E che non abbia a lamentarsi di te! ”
Così detto, si mosse rapidamente verso l’uscio. Lucia s’alzò e corse per trattenerlo, e rinnovare la sua preghiera; ma era sparito.
“ Oh povera me! Chiudete, chiudete subito. ” E sentito ch’ebbe accostare i battenti e scorrere il paletto, tornò a rannicchiarsi nel suo cantuccio. “ Oh povera me! ” esclamò di nuovo singhiozzando: “ chi pregherò ora? Dove sono? Ditemi voi, ditemi per carità, chi è quel signore…. quello che m’ha parlato? ”
“ Chi è, eh? chi è? Volete ch’io ve lo dica. Aspetta ch’io te lo dica.

Perchè vi protegge, avete messo su superbia; e volete esser soddisfatta voi, e farne andar di mezzo me. Domandatene a lui. S’io vi contentassi anche in questo, non mi toccherebbe di quelle buone parole che avete sentite voi. ” — Io son vecchia, son vecchia, — continuò, mormorando tra i denti. — Maledette le giovani, che fanno bel vedere a piangere e a ridere, e hanno sempre ragione. — Ma sentendo Lucia singhiozzare, e tornandole minaccioso alla mente il comando del padrone, si chinò verso la povera rincantucciata, e, con voce raddolcita, riprese: “ via, non v’ho detto niente di male: state allegra. Non mi domandate di quelle cose che non vi posso dire; e del resto, state di buon animo. Oh se sapeste quanta gente sarebbe contenta di sentirlo parlare come ha parlato a voi! State allegra, che or ora verrà da mangiare; e io che capisco…. nella maniera che v’ha parlato, ci sarà della roba buona. E poi anderete a letto, e…. mi lascerete un cantuccino anche a me, spero, ” soggiunse, con una voce, suo malgrado, stizzosa.
“ Non voglio mangiare, non voglio dormire. Lasciatemi stare; non v’accostate; non partite di qui! ”
“ No, no, via, ” disse la vecchia, ritirandosi, e mettendosi a sedere sur una seggiolaccia, donde dava alla poverina certe occhiate di terrore e d’astio insieme; e poi guardava il suo covo, rodendosi d’esserne forse esclusa per tutta la notte, e brontolando contro il freddo. Ma si rallegrava col pensiero della cena, e con la speranza che ce ne sarebbe anche per lei. Lucia non s’avvedeva del freddo, non sentiva la fame, e come sbalordita, non aveva de’ suoi dolori, de’ suoi terrori stessi, che un sentimento confuso, simile all’immagini sognate da un febbricitante.
Si riscosse quando sentì picchiare; e, alzando la faccia atterrita, gridò: “ chi è? chi è? Non venga nessuno! ”
“ Nulla, nulla; buone nuove, ” disse la vecchia: “ è Marta che porta da mangiare. ”
“ Chiudete, chiudete! ” gridava Lucia.
“ Ih! subito, subito, ” rispondeva la vecchia; e presa una paniera dalle mani di quella Marta, la mandò via, richiuse, e venne a posar la paniera sur una tavola nel mezzo della camera. Invitò poi più volte Lucia che venisse a goder di quella buona roba. Adoprava le parole più efficaci, secondo lei, a mettere appetito alla poverina, prorompeva in esclamazioni sulla squisitezza de’ cibi: “ di que’ bocconi che, quando le persone come noi possono arrivare a assaggiarne, se ne ricordan per un pezzo! Del vino che beve il padrone co’ suoi amici…. quando capita qualcheduno di quelli…! e vogliono stare allegri! Ehm! ” Ma vedendo che tutti gl’incanti riuscivano inutili, “ siete voi che non volete, ” disse. “ Non istate poi a dirgli domani ch’io non v’ho fatto coraggio. Mangerò io; e ne resterà più che abbastanza per voi, per quando metterete giudizio, e vorrete ubbidire. ” Così detto, si mise a mangiare avidamente. Saziata che fu, s’alzò, andò verso il cantuccio, e, chinandosi sopra Lucia, l’invitò di nuovo a mangiare, per andar poi a letto.
“ No, no, non voglio nulla, ” rispose questa, con voce fiacca e come sonnolenta. Poi, con più risolutezza, riprese: “ è serrato l’uscio? è serrato bene? ” E dopo aver guardato in giro per la camera, s’alzò, e, con le mani avanti, con passo sospettoso, andava verso quella parte.
La vecchia ci corse prima di lei, stese la mano al paletto, lo scosse, e disse: “ sentite? vedete? è serrato bene? siete contenta ora? ”

“ Oh contenta! contenta io qui! ” disse Lucia, rimettendosi di nuovo nel suo cantuccio. “ Ma il Signore lo sa che ci sono! ”
“ Venite a letto: cosa volete far lì, accucciata come un cane? S’è mai visto rifiutare i comodi, quando si possono avere? ”
“ No, no; lasciatemi stare. ”
“ Siete voi che lo volete. Ecco, io vi lascio il posto buono: mi metto sulla sponda; starò incomoda per voi. Se volete venire a letto, sapete come avete a fare. Ricordatevi che v’ho pregata più volte.” Così dicendo, si cacciò sotto vestita; e tutto tacque.
Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomitolo, con le ginocchia alzate, con le mani appoggiate sulle ginocchia, e col viso nascosto nelle mani. Non era il suo nè sonno nè veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, d’immaginazioni, di spaventi. Ora, più presente a sè stessa, e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata, s’applicava dolorosamente alle circostanze dell’oscura e formidabile realtà in cui si trovava avviluppata; ora la mente, trasportata in una regione ancor più oscura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall’incertezza e dal terrore. Stette un pezzo in quest’angoscia; alfine, più che mai stanca e abbattuta, stese le membra intormentite, si sdraiò, o cadde sdraiata, e rimase alquanto in uno stato più somigliante a un sonno vero. Ma tutt’a un tratto si risentì, come a una chiamata interna, e provò il bisogno di risentirsi interamente, di riaver tutto il suo pensiero, di conoscere dove fosse, come, perchè. Tese l’orecchio a un suono: era il russare lento, arrantolato della vecchia; spalancò gli occhi, e vide un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda: era il lucignolo della lucerna, che, vicino a spegnersi, scoccava una luce tremola, e subito la ritirava, per dir così, indietro, come è il venire e l’andare dell’onda sulla riva: e quella luce, fuggendo dagli oggetti, prima che prendessero da essa rilievo e colore distinto, non rappresentava allo sguardo che una successione di guazzabugli. Ma ben presto le recenti impressioni, ricomparendo nella mente, l’aiutarono a distinguere ciò che appariva confuso al senso. L’infelice risvegliata riconobbe la sua prigione: tutte le memorie dell’orribil giornata trascorsa, tutti i terrori dell’avvenire, l’assalirono in una volta: quella nuova quiete stessa dopo tante agitazioni, quella specie di riposo, quell’abbandono in cui era lasciata, le facevano un nuovo spavento: e fu vinta da un tale affanno, che desiderò di morire. Ma in quel momento, si rammentò che poteva almen pregare, e insieme con quel pensiero, le spuntò in cuore come un’improvvisa speranza. Prese di nuovo la sua corona, e ricominciò a dire il rosario; e, di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante, il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Tutt’a un tratto, le passò per la mente un altro pensiero: che la sua orazione sarebbe stata più accetta e più certamente esaudita, quando, nella sua desolazione, facesse anche qualche offerta. Si ricordò di quello che aveva di più caro, o che di più caro aveva avuto; giacchè, in quel momento, l’animo suo non poteva sentire altra affezione che di spavento, nè concepire altro desiderio che della liberazione; se ne ricordò, e risolvette subito di farne un sacrifizio. S’alzò, e si mise in ginocchio, e tenendo giunte al petto le mani, dalle quali pendeva la corona, alzò il viso e le pupille al cielo, e disse: “o Vergine santissima! Voi, a cui mi sono raccomandata tante volte, e che tante volte m’avete consolata, voi che avete patito tanti dolori, e siete ora tanto gloriosa, e avete fatti tanti miracoli per i poveri tribolati; aiutatemi! fatemi uscire da questo pericolo, fatemi tornar salva con mia madre, o Madre del Signore; e fo voto a voi di rimaner vergine; rinunzio per sempre a quel mio poveretto, per non esser mai d’altri che vostra.”

Proferite queste parole, abbassò la testa, e si mise la corona intorno al collo, quasi come un segno di consacrazione, e una salvaguardia a un tempo, come un’armatura della nuova milizia a cui s’era ascritta. Rimessasi a sedere in terra, sentì entrar nell’animo una certa tranquillità, una più larga fiducia. Le venne in mente quel domattina ripetuto dallo sconosciuto potente, e le parve di sentire in quella parola una promessa di salvazione. I sensi affaticati da tanta guerra s’assopirono a poco a poco in quell’acquietamento di pensieri; e finalmente, già vicino a giorno, col nome della sua protettrice tronco tra le labbra, Lucia s’addormentò d’un sonno perfetto e continuo.

Ma c’era qualchedun altro in quello stesso castello, che avrebbe voluto fare altrettanto, e non potè mai. Partito, o quasi scappato da Lucia, dato l’ordine per la cena di lei, fatta una consueta visita a certi posti del castello, sempre con quell’immagine viva nella mente, e con quelle parole risonanti all’orecchio, il signore s’era andato a cacciare in camera, s’era chiuso dentro in fretta e in furia, come se avesse avuto a trincerarsi contro una squadra di nemici; e spogliatosi, pure in furia, era andato a letto. Ma quell’immagine, più che mai presente, parve che in quel momento gli dicesse: tu non dormirai. — Che sciocca curiosità da donnicciola, — pensava, — m’è venuta di vederla? Ha ragione quel bestione del Nibbio; uno non è più uomo; [p. 406 modifica]è vero, non è più uomo!… Io?… io non son più uomo, io? Cos’è stato? che diavolo m’è venuto addosso? che c’è di nuovo? Non lo sapevo io prima d’ora, che le donne strillano? Strillano anche gli uomini alle volte, quando non si possono rivoltare. Che diavolo! non ho mai sentito belar donne?
E qui, senza che s’affaticasse molto a rintracciare nella memoria, la memoria da sè gli rappresentò più d’un caso in cui nè preghi nè lamenti non l’avevano punto smosso dal compire le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tali imprese, non che gli ridonasse la fermezza, che già gli mancava, di compir questa; non che spegnesse nell’animo quella molesta pietà; vi destava invece una specie di terrore, una non so qual rabbia di pentimento. Di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima immagine di Lucia, contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. — È viva costei, — pensava, — è qui; sono a tempo; le posso dire: andate, rallegratevi; posso veder quel viso cambiarsi, le posso anche dire: perdonatemi…. Perdonatemi? io domandar perdono? a una donna? io…! Ah, eppure! se una parola, una parola tale mi potesse far bene, levarmi d’addosso un po’ di questa diavoleria, la direi; eh! sento che la direi. A che cosa son ridotto! Non son più uomo, non son più uomo!… Via! — disse, poi, rivoltandosi arrabbiatamente nel letto divenuto duro duro, sotto le coperte divenute pesanti pesanti: — via! sono sciocchezze che mi son passate per la testa altre volte. Passerà anche questa. —
E per farla passare, andò cercando col pensiero qualche cosa importante, qualcheduna di quelle che solevano occuparlo fortemente, onde applicarvelo tutto; ma non ne trovò nessuna. Tutto gli appariva cambiato: ciò che altre volte stimolava più fortemente i suoi desidèri, ora non aveva più nulla di desiderabile: la passione, come un cavallo divenuto tutt’a un tratto restìo per un’ombra, non voleva più andare avanti. Pensando all’imprese avviate e non finite, in vece d’animarsi al compimento, in vece d’irritarsi degli ostacoli (chè l’ira in quel momento gli sarebbe parsa soave), sentiva una tristezza, quasi uno spavento de’ passi già fatti. Il tempo gli s’affacciò davanti voto d’ogni intento, d’ogni occupazione, d’ogni volere, pieno soltanto di memorie intollerabili; tutte l’ore somiglianti a quella che gli passava così lenta, così pesante sul capo. Si schierava nella fantasia tutti i suoi malandrini, e non trovava da comandare a nessuno di loro una cosa che gl’importasse; anzi l’idea di rivederli, di trovarsi tra loro, era un nuovo peso, un’idea di schifo e d’impiccio. E se volle trovare un’occupazione per l’indomani, un’opera fattibile, dovette pensare che all’indomani poteva lasciare in libertà quella poverina.
— La libererò, sì; appena spunta il giorno, correrò da lei, e le dirò: andate, andate. La farò accompagnare… E la promessa? e l’impegno? e don Rodrigo?… Chi è don Rodrigo? —
A guisa di chi è colto da una interrogazione inaspettata e imbarazzante d’un superiore, l’innominato pensò subito a rispondere a questa che s’era fatta lui stesso, o piuttosto quel nuovo lui, che cresciuto terribilmente a un tratto, sorgeva come a giudicare l’antico. Andava dunque cercando le ragioni per cui, prima quasi d’esser pregato, s’era potuto risolvere a prender l’impegno di far tanto patire, senz’odio, senza timore, un’infelice sconosciuta, per servire colui; ma, non che riuscisse a trovar ragioni che in quel momento gli paressero buone a scusare il fatto, non sapeva quasi spiegare a sè stesso come ci si fosse indotto. Quel volere, piuttosto che una deliberazione, era stato un movimento istantaneo dell’animo ubbidiente a sentimenti antichi, abituali, una conseguenza di mille fatti antecedenti; e il tormentato esaminator di sè stesso, per rendersi ragione d’un sol fatto, si trovò ingolfato nell’esame di tutta la sua vita. Indietro, indietro, d’anno in anno, d’impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza: ognuna ricompariva all’animo consapevole e nuovo, separata da’ sentimenti che l’avevan fatta volere e commettere; ricompariva con una mostruosità che que’ sentimenti non avevano allora lasciato scorgere in essa. Eran tutte sue, eran lui: l’orrore di questo pensiero, rinascente a ognuna di quell’immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione. S’alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò, e… al momento di finire una vita divenuta insopportabile, il suo pensiero sorpreso da un terrore, da un’inquietudine, per dir così, superstite, si slanciò nel tempo che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine. S’immaginava con raccapriccio il suo cadavere sformato, immobile, in balìa del più vile sopravvissuto; la sorpresa, la confusione nel castello, il giorno dopo: ogni cosa sottosopra; lui, senza forza, senza voce, buttato chi sa dove. Immaginava i discorsi che se ne sarebber fatti lì, d’intorno, lontano; la gioia de’ suoi nemici. Anche le tenebre, anche il silenzio, gli facevan veder nella morte qualcosa di più tristo, di spaventevole; gli pareva che non avrebbe esitato, se fosse stato di [p. 408 modifica]giorno, all’aperto, in faccia alla gente: buttarsi in un fiume e sparire. E assorto in queste contemplazioni tormentose, andava alzando e riabbassando, con una forza convulsiva del pollice, il cane della pistola;

quando gli balenò in mente un altro pensiero. — Se quell’altra vita di cui m’hanno parlato quand’ero ragazzo, di cui parlano sempre, come se fosse cosa sicura; se quella vita non c’è; se è un’invenzione de’ preti; che fo io? perchè morire? cos’importa quello che ho fatto? cos’importa? è una pazzia la mia… E se c’è quest’altra vita…! —
A un tal dubbio, a un tal rischio, gli venne addosso una disperazione più nera, più grave, dalla quale non si poteva fuggire, neppur con la morte. Lasciò cader l’arme, e stava con le mani ne’ capelli, battendo i denti, tremando. Tutt’a un tratto, gli tornarono in mente parole che aveva sentite e risentite, poche ore prima: — Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia! — E non gli tornavan già con quell’accento d’umile preghiera, con cui erano state proferite; ma con un suono pieno d’autorità, e che insieme induceva una lontana speranza. Fu quello un momento di sollievo: levò le mani dalle tempie, e, in un’attitudine più composta, fissò gli occhi della mente in colei da cui aveva sentite quelle parole; e la vedeva, non come la sua prigioniera, non come una supplichevole, ma in atto di chi dispensa grazie e consolazioni. Aspettava ansiosamente il giorno, per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita; s’immaginava di condurla lui stesso alla madre. — E poi? che farò domani, il resto della giornata? che farò doman l’altro? che farò dopo doman l’altro? E la notte? la notte, che tornerà tra dodici ore! Oh la notte! no, no, la notte! — E ricaduto nel vòto penoso dell’avvenire, cercava indarno un impiego del tempo, una maniera di passare i giorni, le notti. Ora si proponeva d’abbandonare il castello, e d’andarsene in paesi lontani, dove nessun lo conoscesse, neppur di nome; ma sentiva che lui, lui sarebbe sempre con sè: ora gli rinasceva una fosca speranza di ripigliar l’animo antico, le antiche voglie; e che quello fosse come un delirio passeggiero; ora temeva il giorno, che doveva farlo vedere a’ suoi così miserabilmente mutato; ora lo sospirava, come se dovesse portar la luce anche ne’ suoi pensieri. Ed ecco, appunto sull’albeggiare, pochi momenti dopo che Lucia s’era addormentata, ecco che, stando così immoto a sedere, sentì arrivarsi all’orecchio come un’onda di suono non bene espresso, ma che pure aveva non so che d’allegro. Stette attento, e riconobbe uno scampanare a festa lontano; e dopo qualche momento, sentì anche l’eco del monte, che ogni tanto ripeteva languidamente il concento, e si confondeva con esso. Di lì a poco, sente un altro scampanìo più vicino, anche quello a festa; poi un altro. — Che allegria c’è? cos’hanno di bello tutti costoro? — Saltò fuori da quel covile di pruni; e vestitosi a mezzo, corse a aprire una finestra, e guardò. Le montagne eran mezze velate di nebbia; il cielo, piuttosto che nuvoloso, era tutto una nuvola cenerognola; ma, al chiarore che pure andava a poco a poco crescendo, si distingueva, nella strada in fondo alla valle, gente che passava, altra che usciva dalle case, e s’avviava, tutti dalla stessa parte, verso lo sbocco, a destra del castello, tutti col vestito delle feste, e con un’alacrità straordinaria.
— Che diavolo hanno costoro? che c’è d’allegro in questo maledetto paese? dove va tutta quella canaglia? — E data una voce a un bravo fidato che dormiva in una stanza accanto, gli domandò qual fosse la cagione di quel movimento. Quello, che ne sapeva quanto lui, rispose che anderebbe subito a informarsene. Il signore rimase appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo. Erano uomini, donne, fanciulli, a brigate, a coppie, soli; uno, raggiungendo chi gli era avanti, s’accompagnava con lui; un altro, uscendo di casa, s’univa col primo che rintoppasse; e andavano insieme, come amici a un viaggio convenuto. Gli atti indicavano manifestamente una fretta e una gioia comune; e quel rimbombo non accordato ma consentaneo delle varie campane, quali più, quali meno vicine, pareva, per dir così, la voce di que’ gesti, e il supplimento delle parole che non potevano arrivar lassù. Guardava, guardava; e gli cresceva in cuore una più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa.

Testo del CAPITOLO ventitreesimo

CAPITOLO XXIII
Il cardinal Federigo, intanto che aspettava l’ora d’andar in chiesa a celebrar gli ufizi divini, stava studiando, com’era solito di fare in tutti i ritagli di tempo; quando entrò il cappellano crocifero, con un viso alterato.
“Una strana visita, strana davvero, monsignore illustrissimo!”
“Chi è?” domandò il cardinale.
“Niente meno che il signor…” riprese il cappellano; e spiccando le sillabe con una gran significazione, proferì quel nome che noi non possiamo scrivere ai nostri lettori. Poi soggiunse: “è qui fuori in persona; e chiede nient’altro che d’esser introdotto da vossignoria illustrissima.”
“Lui!” disse il cardinale, con un viso animato, chiudendo il libro, e alzandosi da sedere: “venga! venga subito!”
“Ma…” replicò il cappellano, senza moversi: “vossignoria illustrissima deve sapere chi è costui: quel bandito, quel famoso…”
“E non è una fortuna per un vescovo, che a un tal uomo sia nata la volontà di venirlo a trovare?”
“Ma…” insistette il cappellano: “noi non possiamo mai parlare di certe cose, perchè monsignore dice che le son ciance: però, quando viene il caso, mi pare che sia un dovere… Lo zelo fa de’ nemici, monsignore; e noi sappiamo positivamente che più d’un ribaldo ha osato vantarsi che, un giorno o l’altro…”
“E che hanno fatto?” interruppe il cardinale.
“Dico che costui è un appaltatore di delitti, un disperato, che tiene corrispondenza co’ disperati più furiosi, e che può esser mandato…”
“Oh, che disciplina è codesta,” interruppe ancora sorridendo Federigo, “che i soldati esortino il generale ad aver paura?” Poi, divenuto serio e pensieroso, riprese: “san Carlo non si sarebbe trovato nel caso di dibattere se dovesse ricevere un tal uomo: sarebbe andato a cercarlo. Fatelo entrar subito: ha già aspettato troppo.”

Il cappellano si mosse, dicendo tra sè: — non c’è rimedio: tutti questi santi sono ostinati. —
Aperto l’uscio, e affacciatosi alla stanza dov’era il signore e la brigata, vide questa ristretta in una parte, a bisbigliare e a guardar di sott’occhio quello, lasciato solo in un canto. S’avviò verso di lui; e intanto squadrandolo, come poteva, con la coda dell’occhio, andava pensando che diavolo d’armeria poteva esser nascosta sotto quella casacca; e che, veramente, prima d’introdurlo, avrebbe dovuto proporgli almeno… ma non si seppe risolvere. Gli s’accostò, e disse: “monsignore aspetta vossignoria. Si contenti di venir con me.” E precedendolo in quella piccola folla, che subito fece ala, dava a destra e a sinistra occhiate, le quali significavano: cosa volete? non lo sapete anche voi altri, che fa sempre a modo suo?

Appena introdotto l’innominato, Federigo gli andò incontro, con un volto premuroso e sereno, e con le braccia aperte, come a una persona desiderata, e fece subito cenno al cappellano che uscisse: il quale ubbidì.
I due rimasti stettero alquanto senza parlare, e diversamente sospesi. L’innominato, ch’era stato come portato lì per forza da una smania inesplicabile, piuttosto che condotto da un determinato disegno, ci stava anche come per forza, straziato da due passioni opposte, quel desiderio e quella speranza confusa di trovare un refrigerio al tormento interno, e dall’altra parte una stizza, una vergogna di venir lì come un pentito, come un sottomesso, come un miserabile, a confessarsi in colpa, a implorare un uomo: e non trovava parole, nè quasi ne cercava. Però, alzando gli occhi in viso a quell’uomo, si sentiva sempre più penetrare da un sentimento di venerazione imperioso insieme e soave, che, aumentando la fiducia, mitigava il dispetto, e senza prender l’orgoglio di fronte, l’abbatteva, e, dirò così, gl’imponeva silenzio.
La presenza di Federigo era infatti di quelle che annunziano una superiorità, e la fanno amare. Il portamento era naturalmente composto, e quasi involontariamente maestoso, non incurvato nè impigrito punto dagli anni; l’occhio grave e vivace, la fronte serena e pensierosa; con la canizie, nel pallore, tra i segni dell’astinenza, della meditazione, della fatica, una specie di floridezza verginale: tutte le forme del volto indicavano che, in altre età, c’era stata quella che più propriamente si chiama bellezza; l’abitudine de’ pensieri solenni e benevoli, la pace interna d’una lunga vita, l’amore degli uomini, la gioia continua d’una speranza ineffabile, vi avevano sostituita una, direi quasi, bellezza senile, che spiccava ancor più in quella magnifica semplicità della porpora.
Tenne anche lui, qualche momento, fisso nell’aspetto dell’innominato il suo sguardo penetrante, ed esercitato da lungo tempo a ritrarre dai sembianti i pensieri; e, sotto a quel fosco e a quel turbato, parendogli di scoprire sempre più qualcosa di conforme alla speranza da lui concepita al primo annunzio d’una tal visita, tutt’animato, “oh!” disse: “che preziosa visita è questa! e quanto vi devo esser grato d’una sì buona risoluzione; quantunque per me abbia un po’ del rimprovero!”
“Rimprovero!” esclamò il signore maravigliato, ma raddolcito da quelle parole e da quel fare, e contento che il cardinale avesse rotto il ghiaccio, e avviato un discorso qualunque.
“Certo, m’è un rimprovero,” riprese questo, “ch’io mi sia lasciato prevenir da voi; quando, da tanto tempo, tante volte, avrei dovuto venir da voi io.”
“Da me, voi! Sapete chi sono? V’hanno detto bene il mio nome?”
“E questa consolazione ch’io sento, e che, certo, vi si manifesta nel mio aspetto, vi par egli ch’io dovessi provarla all’annunzio, alla vista d’uno sconosciuto? Siete voi che me la fate provare; voi, dico, che avrei dovuto cercare; voi che almeno ho tanto amato e pianto, per cui ho tanto pregato; voi, de’ miei figli, che pure amo tutti e di cuore, quello che avrei più desiderato d’accogliere e d’abbracciare, se avessi creduto di poterlo sperare. Ma Dio sa fare Egli solo le maraviglie, e supplisce alla debolezza, alla lentezza de’ suoi poveri servi.”
L’innominato stava attonito a quel dire così infiammato, a quelle parole, che rispondevano tanto risolutamente a ciò che non aveva ancor detto, nè era ben determinato di dire; e commosso ma sbalordito, stava in silenzio. “E che?” riprese, ancor più affettuosamente, Federigo: “voi avete una buona nuova da darmi, e me la fate tanto sospirare?”

“Una buona nuova, io? Ho l’inferno nel cuore; e vi darò una buona nuova? Ditemi voi, se lo sapete, qual è questa buona nuova che aspettate da un par mio.”
“Che Dio v’ha toccato il cuore, e vuol farvi suo,” rispose pacatamente il cardinale.
“Dio! Dio! Dio! Se lo vedessi! Se lo sentissi! Dov’è questo Dio?”
“Voi me lo domandate? voi? E chi più di voi l’ha vicino? Non ve lo sentite in cuore, che v’opprime, che v’agita, che non vi lascia stare, e nello stesso tempo v’attira, vi fa presentire una speranza di quiete, di consolazione, d’una consolazione che sarà piena, immensa, subito che voi lo riconosciate, lo confessiate, l’imploriate?”
“Oh, certo! ho qui qualche cosa che m’opprime, che mi rode! Ma Dio! Se c’è questo Dio, se è quello che dicono, cosa volete che faccia di me?”
Queste parole furon dette con un accento disperato; ma Federigo, con un tono solenne, come di placida ispirazione, rispose: “cosa può far Dio di voi? cosa vuol farne? Un segno della sua potenza e della sua bontà: vuol cavar da voi una gloria che nessun altro gli potrebbe dare. Che il mondo gridi da tanto tempo contro di voi, che mille e mille voci detestino le vostre opere…” (l’innominato si scosse, e rimase stupefatto un momento nel sentir quel linguaggio così insolito, più stupefatto ancora di non provarne sdegno, anzi quasi un sollievo); “che gloria,” proseguiva Federigo, “ne viene a Dio? Son voci di terrore, son voci d’interesse; voci forse anche di giustizia, ma d’una giustizia così facile, così naturale! alcune forse, pur troppo, d’invidia di codesta vostra sciagurata potenza, di codesta, fino ad oggi, deplorabile sicurezza d’animo. Ma quando voi stesso sorgerete a condannare la vostra vita, ad accusar voi stesso, allora! allora Dio sarà glorificato! E voi domandate cosa Dio possa far di voi? Chi son io pover’uomo, che sappia dirvi fin d’ora che profitto possa ricavar da voi un tal Signore? cosa possa fare di codesta volontà impetuosa, di codesta imperturbata costanza, quando l’abbia animata, infiammata d’amore, di speranza, di pentimento? Chi siete voi, pover’uomo, che vi pensiate d’aver saputo da voi immaginare e fare cose più grandi nel male, che Dio non possa farvene volere e operare nel bene? Cosa può Dio far di voi? E perdonarvi? e farvi salvo? e compire in voi l’opera della redenzione? Non son cose magnifiche e degne di Lui? Oh pensate! se io omiciattolo, io miserabile, e pur così pieno di me stesso, io qual mi sono, mi struggo ora tanto della vostra salute, che per essa darei con gaudio (Egli m’è testimonio) questi pochi giorni che mi rimangono; oh pensate! quanta, quale debba essere la carità di Colui che m’infonde questa così imperfetta, ma così viva; come vi ami, come vi voglia Quello che mi comanda e m’ispira un amore per voi che mi divora!”
A misura che queste parole uscivan dal suo labbro, il volto, lo sguardo, ogni moto ne spirava il senso. La faccia del suo ascoltatore, di stravolta e convulsa, si fece da principio attonita e intenta; poi si compose a una commozione più profonda e meno angosciosa; i suoi occhi, che dall’infanzia più non conoscevan le lacrime, si gonfiarono; quando le parole furon cessate, si coprì il viso con le mani, e diede in un dirotto pianto, che fu come l’ultima e più chiara risposta.
“Dio grande e buono!” esclamò Federigo, alzando gli occhi e le mani al cielo: “che ho mai fatto io, servo inutile, pastore sonnolento, perchè Voi mi chiamaste a questo convito di grazia, perchè mi faceste degno d’assistere a un sì giocondo prodigio!” Così dicendo, stese la mano a prender quella dell’innominato.
“No!” gridò questo, “no! lontano, lontano da me voi: non lordate quella mano innocente e benefica. Non sapete tutto ciò che ha fatto questa che volete stringere.”
“Lasciate,” disse Federigo, prendendola con amorevole violenza, “lasciate ch’io stringa codesta mano che riparerà tanti torti, che spargerà tante beneficenze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disarmata, pacifica, umile a tanti nemici.”
“È troppo!” disse, singhiozzando, l’innominato. “Lasciatemi, monsignore; buon Federigo, lasciatemi. Un popolo affollato v’aspetta; tant’anime buone, tant’innocenti, tanti venuti da lontano, per vedervi una volta, per sentirvi: e voi vi trattenete… con chi!”
“Lasciamo le novantanove pecorelle,” rispose il cardinale: “sono in sicuro sul monte: io voglio ora stare con quella ch’era smarrita. Quell’anime son forse ora ben più contente, che di vedere questo povero vescovo. Forse Dio, che ha operato in voi il prodigio della misericordia, diffonde in esse una gioia di cui non sentono ancora la cagione. Quel popolo è forse unito a noi senza saperlo: forse lo Spirito mette ne’ loro cuori un ardore indistinto di carità, una preghiera ch’esaudisce per voi, un rendimento di grazie di cui voi siete l’oggetto non ancor conosciuto.” Così dicendo, stese le braccia al collo dell’innominato; il quale, dopo aver tentato di sottrarsi, e resistito un momento, cedette, come vinto da quell’impeto di carità, abbracciò anche lui il cardinale, e abbandonò sull’omero di lui il suo volto tremante e mutato. Le sue lacrime ardenti cadevano sulla porpora incontaminata di Federigo; e le mani incolpevoli di questo stringevano affettuosamente quelle membra, premevano quella casacca, avvezza a portar l’armi della violenza e del tradimento.
L’innominato, sciogliendosi da quell’abbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con una mano, e, alzando insieme la faccia, esclamò: “Dio veramente grande! Dio veramente buono! io mi conosco ora, comprendo chi sono; le mie iniquità mi stanno davanti; ho ribrezzo di me stesso; eppure…! eppure provo un refrigerio, una gioia, sì una gioia, quale non ho provata mai in tutta questa mia orribile vita!”
“È un saggio,” disse Federigo, “che Dio vi dà per cattivarvi al suo servizio, per animarvi ad entrar risolutamente nella nuova vita in cui avrete tanto da disfare, tanto da riparare, tanto da piangere!”
“Me sventurato!” esclamò il signore, “quante, quante…. cose, le quali non potrò se non piangere! Ma almeno ne ho d’intraprese, d’appena avviate, che posso, se non altro, rompere a mezzo: una ne ho, che posso romper subito, disfare, riparare.”
Federigo si mise in attenzione; e l’innominato raccontò brevemente, ma con parole d’esecrazione anche più forti di quelle che abbiamo adoprato noi, la prepotenza fatta a Lucia, i terrori, i patimenti della poverina, e come aveva implorato, e la smania che quell’implorare aveva messa addosso a lui, e come essa era ancor nel castello….
“Ah, non perdiam tempo!” esclamò Federigo, ansante di pietà e di sollecitudine. “Beato voi! Questo è pegno del perdono di Dio! far che possiate diventare strumento di salvezza a chi volevate esser di rovina. Dio vi benedica! Dio v’ha benedetto! Sapete di dove sia questa povera nostra travagliata?”
Il signore nominò il paese di Lucia.
“Non è lontano di qui,” disse il cardinale: “lodato sia Dio; e probabilmente….” Così dicendo, corse a un tavolino, e scosse un campanello. E subito entrò con ansietà il cappellano crocifero, e per la prima cosa, guardò l’innominato; e vista quella faccia mutata, e quegli occhi rossi di pianto, guardò il cardinale; e sotto quell’inalterabile compostezza, scorgendogli in volto come un grave contento, e una premura quasi impaziente, era per rimanere estatico con la bocca aperta, se il cardinale non l’avesse subito svegliato da quella contemplazione, domandandogli se, tra i parrochi radunati lì, si trovasse quello di ***.
“C’è, monsignore illustrissimo,” rispose il cappellano.
“Fatelo venir subito,” disse Federigo, “e con lui il parroco qui della chiesa.”
Il cappellano uscì, e andò nella stanza dov’eran que’ preti riuniti: tutti gli occhi si rivolsero a lui. Lui, con la bocca tuttavia aperta, col viso ancor tutto dipinto di quell’estasi, alzando le mani, e movendole per aria, disse: “signori! signori! haec mutatio dexterae Excelsi.” E stette un momento senza dir altro. Poi, ripreso il tono e la voce della carica, soggiunse: “sua signoria illustrissima e reverendissima vuole il signor curato della parrocchia, e il signor curato di ***.”
Il primo chiamato venne subito avanti, e nello stesso tempo, uscì di mezzo alla folla un: “io?” strascicato, con un’intonazione di maraviglia.
“Non è lei il signor curato di ***?” riprese il cappellano.
“Per l’appunto; ma…”
“Sua signoria illustrissima e reverendissima vuol lei.”
“Me?” disse ancora quella voce, significando chiaramente in quel monosillabo: come ci posso entrar io? Ma questa volta, insieme con la voce, venne fuori l’uomo, don Abbondio in persona, con un passo forzato, e con un viso tra l’attonito e il disgustato. Il cappellano gli fece un cenno con la mano, che voleva dire: a noi, andiamo; ci vuol tanto? E precedendo i due curati, andò all’uscio, l’aprì, e gl’introdusse.

Il cardinale lasciò andar la mano dell’innominato, col quale intanto aveva concertato quello che dovevan fare; si discostò un poco, e chiamò con un cenno il curato della chiesa. Gli disse in succinto di che si trattava; e se saprebbe trovar subito una buona donna che volesse andare in una lettiga al castello, a prender Lucia: una donna di cuore e di testa, da sapersi ben governare in una spedizione così nuova, e usar le maniere più a proposito, trovar le parole più adattate, a rincorare, a tranquillizzare quella poverina, a cui, dopo tante angosce, e in tanto turbamento, la liberazione stessa poteva metter nell’animo una nuova confusione. Pensato un momento, il curato disse che aveva la persona a proposito, e uscì. Il cardinale chiamò con un altro cenno il cappellano, al quale ordinò che facesse preparare subito la lettiga e i lettighieri, e sellare due mule. Uscito anche il cappellano, si voltò a don Abbondio.
Questo, che già gli era vicino, per tenersi lontano da quell’altro signore, e che intanto dava un’occhiatina di sotto in su ora all’uno ora all’altro, seguitando a almanaccar tra sè che cosa mai potesse essere tutto quel rigirìo, s’accostò di più, fece una riverenza, e disse: “m’hanno significato che vossignoria illustrissima mi voleva me; ma io credo che abbiano sbagliato.”
“Non hanno sbagliato,” rispose Federigo: “ho una buona nuova da darvi, e un consolante, un soavissimo incarico. Una vostra parrocchiana, che avrete pianta per ismarrita, Lucia Mondella, è ritrovata, è qui vicino, in casa di questo mio caro amico; e voi anderete ora con lui, e con una donna che il signor curato di qui è andato a cercare, anderete, dico, a prendere quella vostra creatura, e l’accompagnerete qui.”
Don Abbondio fece di tutto per nascondere la noia, che dico? l’affanno e l’amaritudine che gli dava una tale proposta, o comando che fosse; e non essendo più a tempo a sciogliere e a scomporre un versaccio già formato sulla sua faccia, lo nascose, chinando profondamente la testa, in segno d’ubbidienza. E non l’alzò che per fare un altro profondo inchino all’innominato, con un’occhiata pietosa che diceva: sono nelle vostre mani: abbiate misericordia: parcere subjectis.
Gli domandò poi il cardinale, che parenti avesse Lucia.
“Di stretti, e con cui viva, o vivesse, non ha che la madre,” rispose don Abbondio.
“E questa si trova al suo paese?”
“Monsignor, sì.”
“Giacchè,” riprese Federigo, “quella povera giovine non potrà esser così presto restituita a casa sua, le sarà una gran consolazione di veder subito la madre: quindi, se il signor curato di qui non torna prima ch’io vada in chiesa, fatemi voi il piacere di dirgli che trovi un baroccio o una cavalcatura; e spedisca un uomo di giudizio a cercar quella donna, per condurla qui.”
“E se andassi io?” disse don Abbondio.
“No, no, voi: v’ho già pregato d’altro,” rispose il cardinale.
“Dicevo,” replicò don Abbondio, “per disporre quella povera madre. È una donna molto sensitiva; e ci vuole uno che la conosca, e la sappia prendere per il suo verso, per non farle male in vece di bene.”
“E per questo, vi prego d’avvertire il signor curato che scelga un uomo di proposito: voi siete molto più necessario altrove,” rispose il cardinale. E avrebbe voluto dire: quella povera giovine ha molto più bisogno di veder subito una faccia conosciuta, una persona sicura, in quel castello, dopo tant’ore di spasimo, e in una terribile oscurità dell’avvenire. Ma questa non era ragione da dirsi così chiaramente davanti a quel terzo. Parve però strano al cardinale che don Abbondio non l’avesse intesa per aria, anzi pensata da sè; e così fuor di luogo gli parve la proposta e l’insistenza, che pensò doverci esser sotto qualche cosa. Lo guardò in viso, e vi scoprì facilmente la paura di viaggiare con quell’uomo tremendo, d’andare in quella casa, anche per pochi momenti. Volendo quindi dissipare affatto quell’ombre codarde, e non piacendogli di tirare in disparte il curato e di bisbigliar con lui in segreto, mentre il suo nuovo amico era lì in terzo, pensò che il mezzo più opportuno era di far ciò che avrebbe fatto anche senza questo motivo, parlare all’innominato medesimo; e dalle sue risposte don Abbondio intenderebbe finalmente che quello non era più uomo da averne paura. S’avvicinò dunque all’innominato, e con quell’aria di spontanea confidenza, che si trova in una nuova e potente affezione, come in un’antica intrinsichezza, “non crediate,” gli disse, “ch’io mi contenti di questa visita per oggi. Voi tornerete, n’è vero? in compagnia di questo ecclesiastico dabbene?”
“S’io tornerò?” rispose l’innominato: “quando voi mi rifiutaste, rimarrei ostinato alla vostra porta, come il povero. Ho bisogno di parlarvi! ho bisogno di sentirvi, di vedervi! ho bisogno di voi!”
Federigo gli prese la mano, gliela strinse, e disse: “favorirete dunque di restare a desinare con noi. V’aspetto. Intanto, io vo a pregare, e a render grazie col popolo; e voi a cogliere i primi frutti della misericordia.”
Don Abbondio, a quelle dimostrazioni, stava come un ragazzo pauroso, che veda uno accarezzar con sicurezza un suo cagnaccio grosso, rabbuffato, con gli occhi rossi, con un nomaccio famoso per morsi e per ispaventi, e senta dire al padrone che il suo cane è un buon bestione, quieto, quieto: guarda il padrone, e non contraddice nè approva; guarda il cane, e non ardisce accostarglisi, per timore che il buon bestione non gli mostri i denti, fosse anche per fargli le feste; non ardisce allontanarsi, per non farsi scorgere; e dice in cuor suo: oh se fossi a casa mia!
Al cardinale, che s’era mosso per uscire, tenendo sempre per la mano e conducendo seco l’innominato, diede di nuovo nell’occhio il pover’uomo, che rimaneva indietro, mortificato, malcontento, facendo il muso senza volerlo. E pensando che forse quel dispiacere gli potesse anche venire dal parergli d’esser trascurato, e come lasciato in un canto, tanto più in paragone d’un facinoroso così ben accolto, così accarezzato, se gli voltò nel passare, si fermò un momento, e con un sorriso amorevole, gli disse: “signor curato, voi siete sempre con me nella casa del nostro buon Padre; ma questo… questo perierat, et inventus est.”
“Oh quanto me ne rallegro!” disse don Abbondio, facendo una gran riverenza a tutt’e due in comune.
L’arcivescovo andò avanti, spinse l’uscio, che fu subito spalancato di fuori da due servitori, che stavano uno di qua e uno di là: e la mirabile coppia apparve agli sguardi bramosi del clero raccolto nella stanza. Si videro que’ due volti sui quali era dipinta una commozione diversa, ma ugualmente profonda; una tenerezza riconoscente, un’umile gioia nell’aspetto venerabile di Federigo; in quello dell’innominato, una confusione temperata di conforto, un nuovo pudore, una compunzione, dalla quale però traspariva tuttavia il vigore di quella selvaggia e risentita natura. E si seppe poi, che a più d’uno de’ riguardanti era allora venuto in mente quel detto d’Isaia: il lupo e l’agnello andranno ad un pascolo; il leone e il bue mangeranno insieme lo strame. Dietro veniva don Abbondio, a cui nessuno badò.

Quando furono nel mezzo della stanza, entrò dall’altra parte l’aiutante di camera del cardinale, e gli s’accostò, per dirgli che aveva eseguiti gli ordini comunicatigli dal cappellano; che la lettiga e le due mule eran preparate, e s’aspettava soltanto la donna che il curato avrebbe condotta. Il cardinale gli disse che, appena arrivato questo, lo facesse parlar subito con don Abbondio: e tutto poi fosse agli ordini di questo e dell’innominato; al quale strinse di nuovo la mano, in atto di commiato, dicendo: “ v’aspetto. ” Si voltò a salutar don Abbondio, e s’avviò dalla parte che conduceva alla chiesa. Il clero gli andò dietro, tra in folla e in processione: i due compagni di viaggio rimasero soli nella stanza.
Stava l’innominato tutto raccolto in sè, pensieroso, impaziente che venisse il momento d’andare a levar di pene e di carcere la sua Lucia: sua ora in un senso così diverso da quello che lo fosse il giorno avanti: e il suo viso esprimeva un’agitazione concentrata, che all’occhio ombroso di don Abbondio poteva facilmente parere qualcosa di peggio. Lo sogguardava, avrebbe voluto attaccare un discorso amichevole; ma, — cosa devo dirgli? — pensava: — devo dirgli ancora: mi rallegro? Mi rallegro di che? che essendo stato finora un demonio, vi siate finalmente risoluto di diventare un galantuomo come gli altri? Bel complimento! Eh eh eh! in qualunque maniera io le rigiri, le congratulazioni non vorrebbero dir altro che questo. E se sarà poi vero che sia diventato galantuomo: così a un tratto! Delle dimostrazioni se ne fanno tante a questo mondo, e per tante cagioni! Che so io, alle volte? E intanto mi tocca a andar con lui! in quel castello! Oh che storia! che storia! che storia! Chi me l’avesse detto stamattina! Ah, se posso uscirne a salvamento, m’ha da sentire la signora Perpetua, d’avermi cacciato qui per forza, quando non c’era necessità, fuor della mia pieve: e che tutti i parrochi d’intorno accorrevano, anche più da lontano; e che non bisognava stare indietro; e che questo, e che quest’altro; e imbarcarmi in un affare di questa sorte! Oh povero me! Eppure qualcosa bisognerà dirgli a costui. — E pensa e ripensa, aveva trovato che gli avrebbe potuto dire: non mi sarei mai aspettato questa fortuna d’incontrarmi in una così rispettabile compagnia; e stava per aprir bocca, quando entrò l’aiutante di camera, col curato del paese, il quale annunziò che la donna era pronta nella lettiga; e poi si voltò a don Abbondio, per ricevere da lui l’altra commissione del cardinale. Don Abbondio se ne sbrigò come potè, in quella confusione di mente; e accostatosi poi all’aiutante, gli disse: “ mi dia almeno una bestia quieta; perchè, dico la verità, sono un povero cavalcatore. ”
“ Si figuri, ” rispose l’aiutante, con un mezzo sogghigno: “ è la mula del segretario, che è un letterato. ”
“ Basta… ” replicò don Abbondio, e continuò pensando: — il cielo me la mandi buona. —
Il signore s’era incamminato di corsa, al primo avviso: arrivato all’uscio, s’accorse di don Abbondio, ch’era rimasto indietro. Si fermò ad aspettarlo; e quando questo arrivò frettoloso, in aria di chieder perdono, l’inchinò, e lo fece passare avanti, con un atto cortese e umile: cosa che raccomodò alquanto lo stomaco al povero tribolato. Ma appena messo piede nel cortiletto, vide un’altra novità che gli guastò quella poca consolazione; vide l’innominato andar verso un canto, prender per la canna, con una mano, la sua carabina, poi per la cigna con l’altra, e, con un movimento spedito, come se facesse l’esercizio, mettersela ad armacollo.
— Ohi! ohi! ohi! — pensò don Abbondio: — cosa vuol farne di quell’ordigno, costui? Bel cilizio, bella disciplina da convertito! E se gli salta qualche grillo? Oh che spedizione! oh che spedizione! —

Se quel signore avesse potuto appena sospettare che razza di pensieri passavano per la testa al suo compagno, non si può dire cosa avrebbe fatto per rassicurarlo; ma era lontano le mille miglia da un tal sospetto; e don Abbondio stava attento a non far nessun atto che significasse chiaramente: non mi fido di vossignoria. Arrivati all’uscio di strada, trovarono le due cavalcature in ordine: l’innominato saltò su quella che gli fu presentata da un palafreniere.
“ Vizi non ne ha? ” – disse all’aiutante di camera don Abbondio, rimettendo in terra il piede, che aveva già alzato verso la staffa.
“ Vada pur su di buon animo: è un agnello. ” Don Abbondio, arrampicandosi alla sella, sorretto dall’aiutante, su, su, su, è a cavallo.

La lettiga, ch’era innanzi qualche passo, portata da due mule, si mosse, a una voce del lettighiero; e la comitiva partì.
Si doveva passar davanti alla chiesa piena zeppa di popolo, per una piazzetta piena anch’essa d’altro popolo del paese e forestieri, che non avevan potuto entrare in quella. Già la gran nuova era corsa; e all’apparir della comitiva, all’apparir di quell’uomo, oggetto ancor poche ore prima di terrore e d’esecrazione, ora di lieta maraviglia, s’alzò nella folla un mormorìo quasi d’applauso; e facendo largo, si faceva insieme alle spinte, per vederlo da vicino. La lettiga passò, l’innominato passò; e davanti alla porta spalancata della chiesa, si levò il cappello, e chinò quella fronte tanto temuta, fin sulla criniera della mula, tra il susurro di cento voci che dicevano: Dio la benedica! Don Abbondio si levò anche lui il cappello, si chinò, si raccomandò al cielo; ma sentendo il concerto solenne de’ suoi confratelli che cantavano a distesa, provò un’invidia, una mesta tenerezza, un accoramento tale, che durò fatica a tener le lacrime.

Fuori poi dell’abitato, nell’aperta campagna, negli andirivieni talvolta affatto deserti della strada, un velo più nero si stese sui suoi pensieri. Altro oggetto non aveva su cui riposar con fiducia lo sguardo, che il lettighiero, il quale, essendo al servizio del cardinale, doveva essere certamente un uomo dabbene, e insieme non aveva aria d’imbelle. Ogni tanto, comparivano viandanti, anche a comitive, che accorrevano per vedere il cardinale; ed era un ristoro per don Abbondio; ma passeggiero, ma s’andava verso quella valle tremenda, dove non s’incontrerebbe che sudditi dell’amico: e che sudditi! Con l’amico avrebbe desiderato ora più che mai d’entrare in discorso, tanto per tastarlo sempre più, come per tenerlo in buona; ma vedendolo così soprappensiero, gliene passava la voglia. Dovette dunque parlar con se stesso; ed ecco una parte di ciò che il pover’uomo si disse in quel tragitto: chè, a scriver tutto, ci sarebbe da farne un libro.
— È un gran dire che tanto i santi come i birboni gli abbiano a aver l’argento vivo addosso, e non si contentino d’esser sempre in moto loro, ma voglian tirare in ballo, se potessero, tutto il genere umano; e che i più faccendoni mi devan proprio venire a cercar me, che non cerco nessuno, e tirarmi per i capelli ne’ loro affari: io che non chiedo altro che d’esser lasciato vivere! Quel matto birbone di don Rodrigo! Cosa gli mancherebbe per esser l’uomo il più felice di questo mondo, se avesse appena un pochino di giudizio? Lui ricco, lui giovine, lui rispettato, lui corteggiato: gli dà noia il bene stare; e bisogna che vada accattando guai per sè e per gli altri. Potrebbe far l’arte di Michelaccio; no signore: vuol fare il mestiere di molestar le femmine: il più pazzo, il più ladro, il più arrabbiato mestiere di questo mondo; potrebbe andare in paradiso in carrozza, e vuol andare a casa del diavolo a piè zoppo. E costui…! — E qui lo guardava, come se avesse sospetto che quel costui sentisse i suoi pensieri, — costui, dopo aver messo sottosopra il mondo con le scelleratezze, ora lo mette sottosopra con la conversione… se sarà vero. Intanto tocca a me a farne l’esperienza!… È finita: quando son nati con quella smania in corpo, bisogna che faccian sempre fracasso. Ci vuol tanto a fare il galantuomo tutta la vita, com’ho fatt’io? No signore: si deve squartare, ammazzare, fare il diavolo… oh povero me!… e poi uno scompiglio, anche per far penitenza. La penitenza, quando s’ha buona volontà, si può farla a casa sua, quietamente, senza tant’apparato, senza dar tant’incomodo al prossimo. E sua signoria illustrissima, subito subito, a braccia aperte, caro amico, amico caro; stare a tutto quel che gli dice costui, come se l’avesse visto far miracoli; e prendere addirittura una risoluzione, mettercisi dentro con le mani e co’ piedi, presto di qua, presto di là: a casa mia si chiama precipitazione. E senza avere una minima caparra, dargli in mano un povero curato! questo si chiama giocare un uomo a pari e caffo. Un vescovo santo, com’è lui, de’ curati dovrebbe esserne geloso, come della pupilla degli occhi suoi. Un pochino di flemma, un pochino di prudenza, un pochino di carità, mi pare che possa stare anche con la santità… E se fosse tutto un’apparenza? Chi può conoscer tutti i fini degli uomini? e dico degli uomini come costui? A pensare che mi tocca a andar con lui, a casa sua! Ci può esser sotto qualche diavolo: oh povero me! è meglio non ci pensare. Che imbroglio è questo di Lucia? Che ci fosse un’intesa con don Rodrigo? che gente! ma almeno la cosa sarebbe chiara. Ma come l’ha avuta nell’unghie costui? Chi lo sa? È tutto un segreto con monsignore: e a me che mi fanno trottare in questa maniera, non si dice nulla. Io non mi curo di sapere i fatti degli altri; ma quando uno ci ha a metter la pelle, ha anche ragione di sapere. Se fosse proprio per andare a prendere quella povera creatura, pazienza! Benchè, poteva ben condurla con sè addirittura. E poi, se è così convertito, se è diventato un santo padre, che bisogno c’era di me? Oh che caos! Basta; voglia il cielo che la sia così: sarà stato un incomodo grosso, ma pazienza! Sarò contento anche per quella povera Lucia: anche lei deve averla scampata grossa; sa il cielo cos’ha patito: la compatisco; ma è nata per la mia rovina… Almeno potessi vedergli proprio in cuore a costui, come la pensa. Chi lo può conoscere? Ecco lì, ora pare sant’Antonio nel deserto; ora pare Oloferne in persona. Oh povero me! povero me! Basta: il cielo è in obbligo d’aiutarmi, perchè non mi ci son messo io di mio capriccio. —
Infatti, sul volto dell’innominato si vedevano, per dir così, passare i pensieri, come, in un’ora burrascosa, le nuvole trascorrono dinanzi alla faccia del sole, alternando ogni momento una luce arrabbiata e un freddo buio. L’animo, ancor tutto inebriato dalle soavi parole di Federigo, e come rifatto e ringiovanito nella nuova vita, s’elevava a quell’idee di misericordia, di perdono e d’amore; poi ricadeva sotto il peso del terribile passato. Correva con ansietà a cercare quali fossero le iniquità riparabili, cosa si potesse troncare a mezzo, quali i rimedi più espedienti e più sicuri, come scioglier tanti nodi, che fare di tanti complici: era uno sbalordimento a pensarci. A quella stessa spedizione, ch’era la più facile e così vicina al termine, andava con un’impazienza mista d’angoscia, pensando che intanto quella creatura pativa, Dio sa quanto, e che lui, il quale pure si struggeva di liberarla, era lui che la teneva intanto a patire. Dove c’eran due strade, il lettighiero si voltava, per saper quale dovesse prendere: l’innominato gliel’indicava con la mano, e insieme accennava di far presto.
Entrano nella valle. Come stava allora il povero don Abbondio! Quella valle famosa, della quale aveva sentito raccontar tante storie orribili, esserci dentro: que’ famosi uomini, il fiore della braveria d’Italia, quegli uomini senza paura e senza misericordia, vederli in carne e in ossa; incontrarne uno o due o tre a ogni voltata di strada. Si chinavano sommessamente al signore; ma certi visi abbronzati! certi baffi irti! certi occhiacci, che a don Abbondio pareva che volessero dire: fargli la festa a quel prete?

A segno che, in un punto di somma costernazione, gli venne detto tra sè: — gli avessi maritati! non mi poteva accader di peggio. — Intanto s’andava avanti per un sentiero sassoso, lungo il torrente: al di là quel prospetto di balze aspre, scure, disabitate; al di qua quella popolazione da far parer desiderabile ogni deserto: Dante non istava peggio nel mezzo di Malebolge.
Passan davanti la Malanotte; bravacci sull’uscio, inchini al signore, occhiate al suo compagno e alla lettiga. Coloro non sapevan cosa si pensare: già la partenza dell’innominato solo, la mattina, aveva dello straordinario; il ritorno non lo era meno. Era una preda che conduceva? E come l’aveva fatta da sè? E come una lettiga forestiera? E di chi poteva esser quella livrea? Guardavano, guardavano, ma nessuno si moveva, perchè questo era l’ordine che il padrone dava loro con dell’occhiate.
Fanno la salita, sono in cima. I bravi che si trovan sulla spianata e sulla porta, si ritirano di qua e di là, per lasciare il passo libero: l’innominato fa segno che non si movan di più; sprona, e passa davanti alla lettiga; accenna al lettighiero e a don Abbondio che lo seguano; entra in un primo cortile, da quello in un secondo; va verso un usciolino, fa stare indietro con un gesto un bravo che accorreva per tenergli la staffa, e gli dice: “ tu sta’ costì, e non venga nessuno.” Smonta, lega in fretta la mula a un’inferriata, va alla lettiga, s’accosta alla donna, che aveva tirata la tendina, e le dice sottovoce: “ consolatela subito; fatele subito capire che è libera, in mano d’amici. Dio ve ne renderà merito. ” Poi fa cenno al lettighiero, che apra; poi s’avvicina a don Abbondio, e, con un sembiante così sereno come questo non gliel aveva ancor visto, né credeva che lo potesse avere, con dipintavi la gioia dell’opera buona che finalmente stava per compire, gli dice, ancora sotto voce: “ signor curato, non le chiedo scusa dell’incomodo che ha per cagion mia: lei lo fa per Uno che paga bene, e per questa sua poverina. ” Ciò detto, prende con una mano il morso, con l’altra la staffa, per aiutar don Abbondio a scendere.
Quel volto, quelle parole, quell’atto, gli avevan dato la vita. Mise un sospiro, che da un’ora gli s’aggirava dentro, senza mai trovar l’uscita; si chinò verso l’innominato, rispose a voce bassa bassa: “le pare? Ma, ma, ma, ma,…! ” e sdrucciolò alla meglio dalla sua cavalcatura. L’innominato legò anche quella, e detto al lettighiero che stesse lì a aspettare, si levò una chiave di tasca, aprì l’uscio, entrò, fece entrare il curato e la donna, s’avviò davanti a loro alla scaletta; e tutt’e tre salirono in silenzio.







