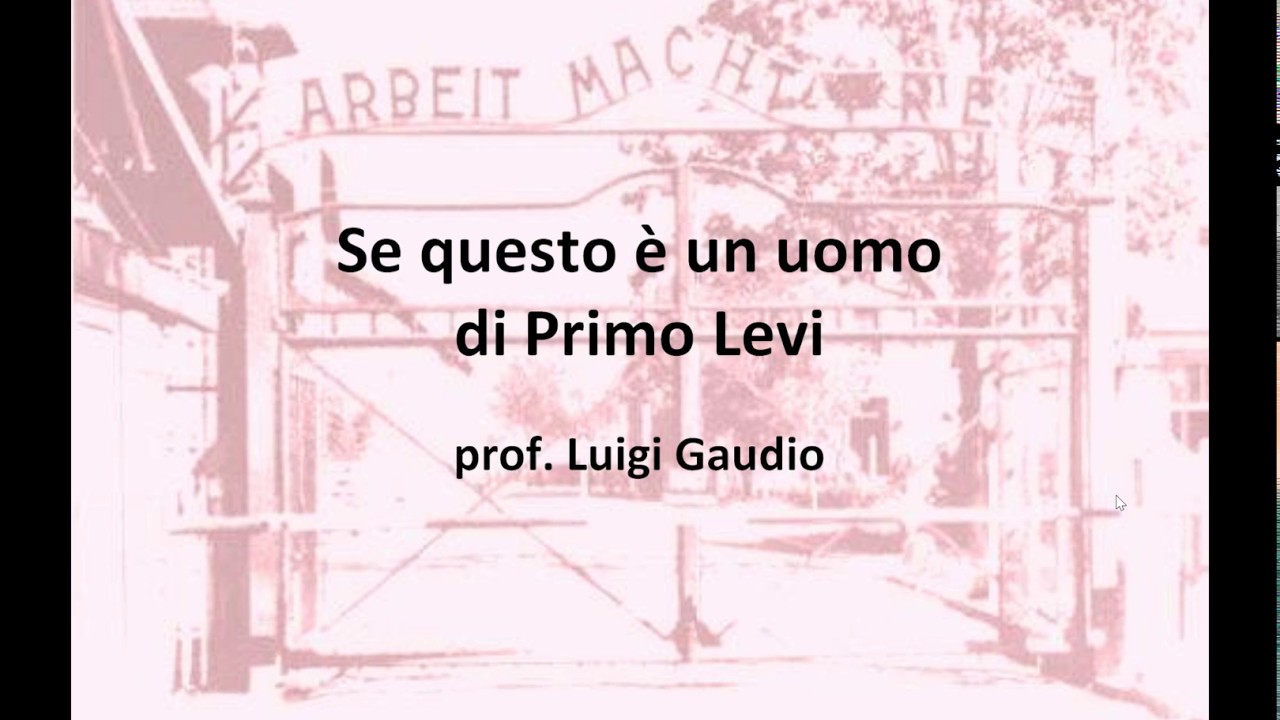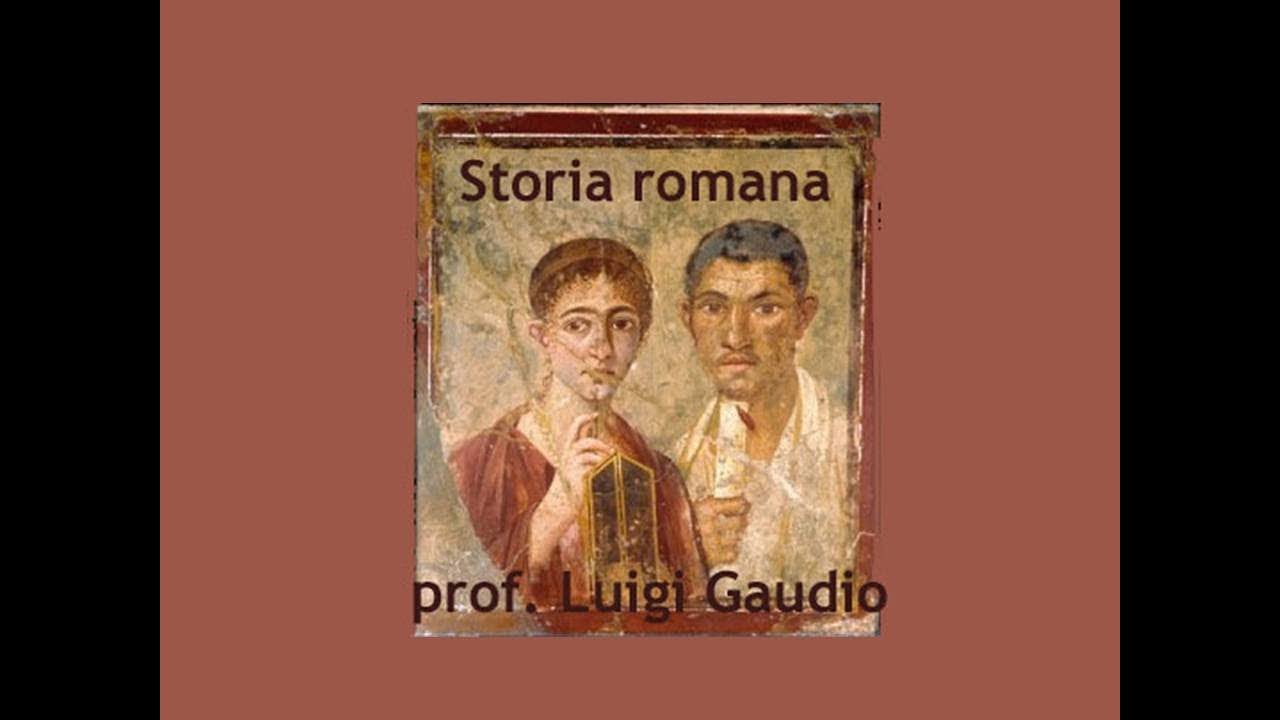
Guerre contro i Sanniti e contro Pirro
28 Dicembre 2019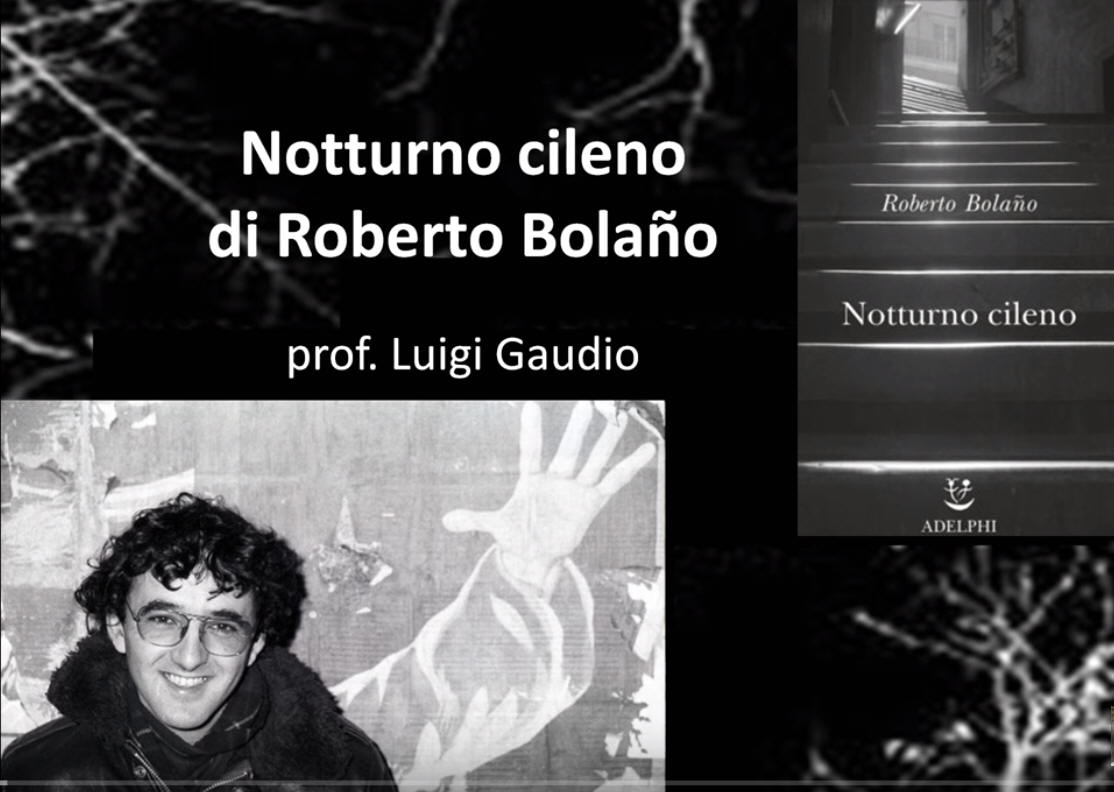
Notturno cileno di Roberto Bolano
28 Dicembre 2019Se questo è un uomo di Primo Levi: La Memoria dell’Orrore e la Dignità Umana
Se questo è un uomo è il memoir più celebre di Primo Levi (1919-1987), chimico e scrittore italiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz. Scritto tra il 1945 e il 1947, immediatamente dopo il suo ritorno dalla prigionia, il libro non è solo una cronaca degli orrori subiti, ma un’indagine lucida e spietata sulla natura umana, sulla deumanizzazione sistematica operata dal sistema concentrazionario nazista e sulla ricerca di un significato nella sofferenza più estrema. È un’opera fondamentale per comprendere la Shoah e per mantenere viva la memoria.
1. Il Contesto: Auschwitz e la Deumanizzazione
Il libro è la testimonianza diretta dell’esperienza di Levi ad Auschwitz III – Monowitz (Buna-Monowitz), il campo di lavoro annesso alla fabbrica di gomma sintetica IG Farben, dove fu internato dall’inizio del 1944 fino alla liberazione da parte dell’Armata Rossa nel gennaio 1945. L’obiettivo primario del regime nazista, oltre allo sterminio fisico, era la distruzione dell’identità e della dignità umana, trasformando gli individui in “pezzi” (Stück).
- L’Arrivo e l’Annichilimento dell’Identità: Levi descrive con precisione quasi scientifica il processo di spersonalizzazione: il furto di ogni oggetto personale, il taglio dei capelli, la doccia disinfettante, la rasatura, l’uniforme a strisce e, soprattutto, la marchiatura del numero di matricola (il suo era A-4517) sul braccio. Questo numero sostituiva il nome, rendendo l’individuo anonimo e interscambiabile.Testo Significativo (Riferimento – Capitolo “L’Iniziazione”)
In quest’ora nula ci hanno tolto il nome. E avremo il numero, noi che eravamo uomini, noi che eravamo donne, noi che eravamo vivi.
Un braccio con un numero di matricola tatuato, simbolo della deumanizzazione nei campi.
2. La Vita nel Lager: La Lotta per la Sopravvivenza
Il cuore del libro è la descrizione della quotidianità nel campo, una lotta incessante contro la fame, il freddo, la fatica, la violenza e la malattia.
- La Fame Onnipresente: La razione di cibo è insufficiente per la sopravvivenza. Ogni pasto è un rito disperato, ogni briciola preziosa. La fame porta all’annullamento di ogni altro pensiero, riducendo l’esistenza alla mera ricerca di cibo.Testo Significativo (Riferimento – Capitolo “Il Canto di Ulisse”)
Qui non c’è altro da fare che mangiare, e per mangiare bisogna essere in forza per lavorare, e per lavorare bisogna mangiare. E se uno non mangia, non lavora, e se non lavora, non mangia.
Interno di baracche in un campo di concentramento, che evoca le condizioni disumane di vita.
- Il Freddo: L’inverno ad Auschwitz è micidiale. Gli abiti insufficienti e la fatica costante rendono il freddo un nemico mortale quanto la fame.
- La Fatica e il Lavoro Forzato: Il lavoro è estenuante, spesso inutile e punitivo, finalizzato a distruggere fisicamente e psicologicamente i prigionieri.
- La Violenza e l’Arbitrio: La brutalità delle SS e dei Kapò (prigionieri-funzionari) è onnipresente e imprevedibile. Le regole sono spesso arbitrarie e la violenza fisica e psicologica è costante.
- Il Lingua Franca del Lager: Levi descrive il linguaggio ibrido e brutale del campo, un misto di tedesco, yiddish, polacco e italiano, che riflette la frammentazione e la confusione.
3. I “Sommersi” e i “Salvato”: La Morale del Lager
Levi introduce una delle sue categorie più celebri: i “sommersi” e i “salvati”.
- I “Sommersi”: La maggioranza, coloro che soccombono fisicamente e moralmente al sistema del Lager. Sono i deboli, gli indifferenti, coloro che hanno perso ogni volontà di resistere e si lasciano andare. Essi non sono necessariamente i morti, ma coloro che hanno perso la loro essenza umana.
- I “Salvato”: Coloro che riescono a sopravvivere, non per superiorità morale, ma spesso per fortuna, per piccole opportunità o per la capacità di adattarsi, anche a costo di compromessi morali. Levi si include in questa categoria, consapevole del peso e della responsabilità della sopravvivenza.Testo Significativo (Riferimento – Capitolo “I Sommersi e i Salvati”)
Noi, i pochi che siamo tornati, non siamo i veri testimoni. I veri testimoni sono i sommersi, quelli che sono morti. Loro hanno visto tutto, non si sono piegati. Quelli che sono tornati sono i “salvati”, ma non hanno visto il fondo, non hanno toccato il fondo.
Due mani che simboleggiano i “sommersi” (in basso) e i “salvati” (in alto), un’immagine della lotta per la sopravvivenza.
4. La Dignità Umana e la Memoria
Nonostante l’inferno del Lager, Levi cerca e a volte trova scintille di umanità e resistenza:
- L’Importanza della Memoria: Il libro stesso è un atto di resistenza, un imperativo morale a ricordare e a far ricordare, affinché l’orrore non si ripeta. Levi scrive per testimoniare, per “raccontare perché accada”, per insegnare.
- La Lingua e la Poesia: Anche nelle condizioni più disperate, l’attaccamento alla propria lingua e alla poesia (celebre l’episodio del “Canto di Ulisse” con Jean, in cui Levi tenta di ricordare e recitare a memoria versi della Divina Commedia) diventa un atto di resistenza contro la deumanizzazione, un modo per affermare la propria identità e la propria cultura.
- L’Amicizia e la Solidarietà: Seppur rare e difficili, i momenti di solidarietà e di aiuto reciproco tra i prigionieri sono descritti come isole di umanità in un mare di bestialità.
Una persona che scrive, simbolo della forza della testimonianza e della memoria.
5. Lo Stile di Scrittura: La Lucidità del Chimico
Lo stile di Primo Levi è una delle sue caratteristiche più distintive:
- Chiarezza e Precisione: Levi, da chimico, adotta un linguaggio sobrio, preciso, quasi analitico. Evita retorica e sentimentalismi, concentrandosi sui fatti e sulle osservazioni. Questa lucidità rende il racconto ancora più agghiacciante e credibile.
- Oggettività Apparente: Nonostante la natura personale del racconto, Levi cerca un’oggettività quasi scientifica, analizzando il “sistema Lager” come un esperimento sociale di annientamento.
- Umorismo Amaro e Ironia: A volte, emerge un umorismo nero o un’ironia sottile, che alleggerisce momentaneamente il peso dell’orrore e rivela la capacità umana di trovare una forma di distacco persino nelle situazioni più tragiche.
- Voci e Didascalie: Il testo è disseminato di termini tedeschi, yiddish e del gergo del campo, che aggiungono autenticità e creano un’atmosfera immersiva.
Conclusione: Un Monito per l’Umanità
Se questo è un uomo non è solo un resoconto di un’esperienza limite, ma un’opera di riflessione profonda sulla condizione umana. Primo Levi ci obbliga a confrontarci con la capacità dell’uomo di infliggere e subire il male più assoluto, ma anche con la tenacia della dignità e della memoria. Il suo appello a “meditare che questo è stato” è un monito universale per le generazioni future, un invito a non dimenticare per non ripetere gli errori del passato. La sua scrittura chiara e potente rimane un faro di umanità nell’oscurità della storia.
🎤🎧 Audio Lezioni, ascolta il podcast sulla Letteratura del novecento del prof. Gaudio
Ascolta “Letteratura del novecento” su Spreaker.