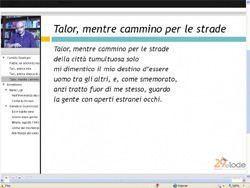Testimone inconsapevole di Gianrico Carofiglio
28 Dicembre 2019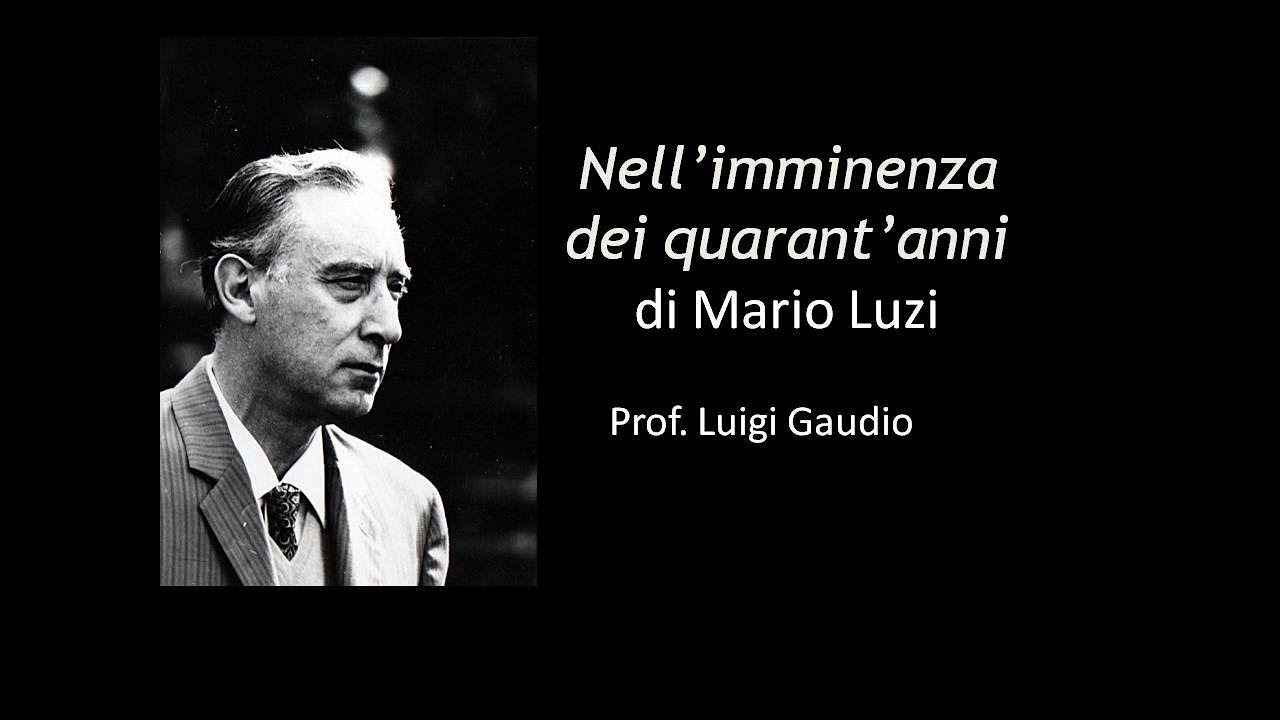
Traccia e svolgimento analisi testuale di Nell’imminenza dei quarant’a…
28 Dicembre 2019Traccia e analisi del testo della poesia Talor mentre cammino per le strade di Camillo Sbarbaro
Traccia
Leggi attentamente questa poesia di Camillo Sbarbaro.
Talor, mentre cammino per le strade
- Talor, mentre cammino per le strade
- della città tumultuosa solo
- mi dimentico il mio destino d’essere
- uomo tra gli altri, e, come smemorato,
- anzi tratto fuor di me stesso, guardo
- la gente con aperti estranei occhi.
- M’occupa allora un puerile, un vago
- senso di sofferenza e d’ansietà
- come per mano che mi opprima il cuore.
- fronti calve di vecchi, inconsapevoli
- occhi di bimbi, facce consuete
- di nati a faticare e a riprodursi,
- facce volpine[1] stupide beate,
- facce ambigue di preti, pitturate[2]
- facce di meretrici, entro il cervello
- mi s’imprimono dolorosamente.
- E conosco l’inganno pel qual vivono,
- il dolore che mise quella piega
- sul loro labbro, le speranze sempre
- deluse,
- e l’inutilità della lor vita
- amara e il lor destino ultimo, il buio.
- Chè[3] ciascuno di loro porta seco[4]
- la condanna d’esistere, ma vanno
- dimentichi di ciò e di tutto, ognuno
- occupato dall’attimo che passa,
- distratto dal suo vizio prediletto
- Provo un disagio simile a chi veda
- inseguire farfalle lungo l’orlo
- d’un precipizio, od una compagnia
- di strani condannati sorridenti.
- E se poco ciò dura, io veramente
- in quell’attimo dentro m’impauro[5]
- a vedere che gli uomini son tanti.
Camillo Sbarbaro, Talor, mentre cammino per le strade, tratta da Pianissimo, Edizioni della Voce (1914)
NOTE:
[1] potrebbe indicare “musi allungati come quelli di una volpe”, ma anche “volpine” per la astuzia e la furbizia con cui affrontano la vita
[2] tinte e truccate vistosamente
[3] poiché, giacché
[4] con sé, in se stesso
[5] spavento (“impauro” è reminiscenza dall’Infinito leopardiano)
Questo testo è inserito nella raccolta Pianissimo pubblicata per le Edizioni della Voce nel 1914. Il titolo della raccolta fu suggerito al poeta dall’amico musicista Bastianelli. La raccolta, infatti, è piccola, e le poesie sono caratterizzate da un tono dimesso e umile, e non hanno nulla della poesia retorica e urlata nelle piazze.
Rispondi alle seguenti domande:
- Sintetizza brevemente il contenuto del testo, diviso nelle quattro strofe.
- Analizza la metrica e trai le opportune riflessioni.
- Qual è la figura retorica più frequente nel brano?
- Analizza il lessico della poesia.
- Qual è la tesi contenuta nel testo di Sbarbaro?
- Quali analogie vi sono fra questa poesia e le opere di altri autori da te conosciuti?
SVOLGIMENTO
- Talvolta mi capita, mentre cammino solo per le strade della città frenetica, di dimenticarmi di essere anch’io un uomo tra gli altri, e come estraniato, osservo le persone, come fa uno spettatore. Sopraggiunge allora un impulsivo senso di sofferenza e di ansia che mi schiaccia, come se una mano premesse sopra il cuore. Mi tormentano le facce delle persone che incontro per la strada: i vecchi calvi, i bimbi ingenui, le persone che sembrano destinate solo a lavorare e a far famiglia, le persone furbe con la loro felicità beota, i preti ambigui, le prostitute truccate. Riconosco in tutti le illusioni che li sostengono, il dolore che si intravede da una piega delle labbra, la profonda insoddisfazione, l’inutilità della loro vita e, in una parola sola, la nullità della loro esistenza. Infatti ciascuno di loro porta in sé la condanna di essere nati, ma se ne dimenticano e si occupano solo del momento che passa e della loro occupazione preferita. Mi sembra di vedere persone che inseguono farfalle lungo il margine di un burrone, oppure di vedere uno strano gruppo di persone sorridenti, anche se condannate. Si tratta di impressioni che possono durare anche solo un attimo, ma in quell’attimo provo un’angoscia incredibile a vedere quanti sono gli uomini destinati a questa amara sorte.
- Tutti i versi sono endecasillabi sciolti, e questo dà un tono di “canzone leopardiana” al componimento, in sintonia con le tesi pessimistiche qui esposte. Il verso 20, però, è un ternario. È evidente che il poeta vuole dare particolare risalto a quella parola-verso, “deluse”, che connota di sé l’intero componimento, che ruota infatti intorno alla delusione dell’uomo, scaraventato in una vita che non corrisponde al suo grande desiderio di felicità (la “condanna dell’esistenza” del verso 24).
- La figura retorica più presente nel testo è l’enjambement, che permette di adottare un tono discorsivo anche con la presenza degli endecasillabi. In tal modo la continuità del discorso non viene interrotta per motivi metrici o retorici. Altre figure retoriche presenti nel brano sono: inversione nesso sostantivo-aggettivo nel verso 6 (“aperti estranei occhi”); similitudine nel verso 9 (“come per mano che mi opprima il cuore”); anafora e ripetizione di “facce…di” nei versi 11-15; similitudini nei versi 28-31. Comunque le similitudini hanno il solo scopo di esemplificare alcune tesi astratte formulate nel testo.
- Le parole utilizzate da Sbarbaro sono estremamente semplici, il tono è dimesso e colloquiale. In tal modo Sbarbaro abbandona l’espressionismo degli altri poeti vociani (Campana, Rebora) fatto di neologismi, trasgressioni grammaticali e visioni deformate, utilizzando un linguaggio anti-eloquente che avrà grande influenza sul conterraneo Eugenio Montale.
- Sbarbaro spiega, e dimostra con la sua esperienza, che tutti gli uomini sono destinati ad un’esistenza amara e inutile. Su questo argomento egli riceve molto dal pessimismo leopardiano, ma senza la giustificazioni filosofiche del poeta recanatese. Sbarbaro sembra dirci: l’uomo è fatto così, e non ci sono spiegazioni razionali di questo.
- Anche nella poesia “La città vecchia” di Umberto Saba si descrivono gli ambienti e le figure malfamate e degradate della città, ma senza il pessimismo di fondo del testo di Sbarbaro, anzi proprio per cogliere in essi un barlume di presenza divina. L’insistenza sulla parola “facce”, poi, fa venire in mente l’umorismo pirandelliano, per cui Sbarbaro, così come Pirandello, è in grado di vedere al di là delle apparenze, scavando nella insoddisfazione e nella delusione profonda anche di chi ostenta felicità, come le “facce volpine stupide beate”. Anche qui, quindi, si tolgono, vengono messe a nudo le “maschere” che troppi indossano per il consueto spettacolo della vita quotidiana. Infine, senz’altro, questa poesia può essere ben accostata ai testi dei poeti crepuscolari. In particolare: per il tono umile e compassato ai testi di Corazzini e Moretti, e per la velata ironia delle “facce ambigue di preti” a quelli di Gozzano.
Schematizzazione della poetica di Sbarbaro:
- Il tono discorsivo e informale
- La discreta ironia
- L’antidannunzianesimo