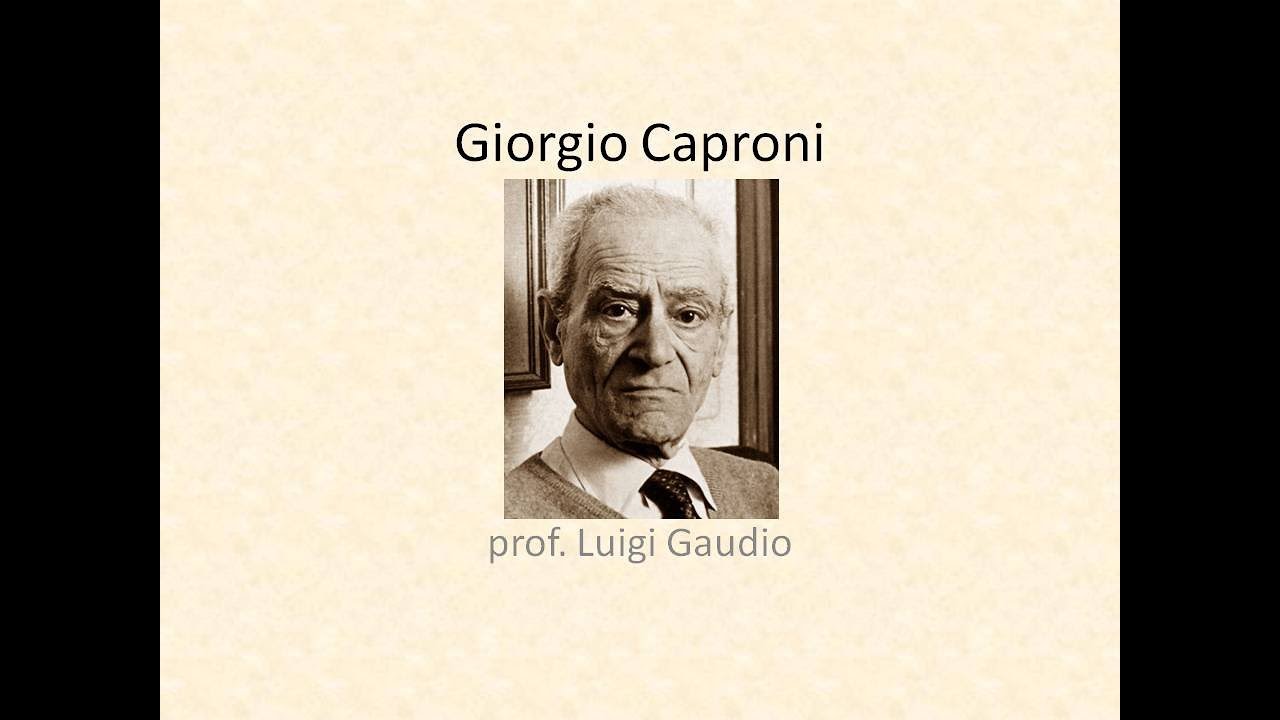
Il delfino di Giorgio Caproni
13 Giugno 2025
Il miracolo economico italiano negli anni sessanta
13 Giugno 2025Traccia e svolgimento di una analisi di un testo tratto da “Senilità” di Italo Svevo
SESSIONE STRAORDINARIA 2023 – PRIMA PROVA SCRITTA Ministero dell’istruzione e del merito
Analisi di ‘Senilità’ di Italo Svevo
Il brano tratto da Senilità (1898), romanzo d’esordio di Alberto Pincherle, in arte Italo Svevo, costituisce l’incipit dell’opera e introduce il lettore alla complessa figura del protagonista, Emilio Brentani. Attraverso una presentazione che è al contempo descrizione e analisi psicologica, Svevo delinea un personaggio emblema dell’inettitudine, della fragilità morale e di una vita vissuta in uno stato di perenne attesa e autoinganno, gettando le basi per i temi che caratterizzeranno tutta la sua produzione narrativa.
Comprensione e Analisi
1. Riassumi il contenuto del brano.
Il brano presenta Emilio Brentani, un uomo di trentacinque anni che vive con la sorella Amalia, più giovane di lui ma caratterialmente più “vecchia” e dedita a lui come una madre. Emilio si descrive come un egoista, sentendosi gravato dalla responsabilità della sorella e vivendo la vita con cautela, evitando pericoli ma anche godimenti e felicità. A quest’età si ritrova con un’insoddisfatta brama di piaceri e amore, e il rimpianto di non averli goduti, unito a una grande paura del proprio carattere debole, più sospettata che sperimentata. La sua vita si divide in due occupazioni: un impieguccio modesto in una società di assicurazioni per sostenere economicamente la famiglia, e una carriera letteraria che, dopo un romanzo lodato dalla stampa cittadina, non gli ha reso nulla se non una “riputazioncella” e non è progredita per inerzia. Nonostante la consapevolezza della “nullità della propria opera” passata, Emilio si considera ancora in un “periodo di preparazione”, immaginando sé stesso come una “potente macchina geniale in costruzione”, in attesa di un successo artistico o di fortuna che deve venirgli sia dal suo cervello che dall’esterno, come se la sua giovinezza e le sue energie migliori non fossero tramontate.
2. Nella presentazione iniziale del personaggio vengono evidenziati gli elementi che lo contrappongono al profilo della sorella: illustrali.
Nella presentazione iniziale, Svevo evidenzia nettamente gli elementi che contrappongono Emilio al profilo della sorella Amalia, definendone le rispettive nature:
- Ingombro fisico/morale vs. Gravità psicologica: Amalia è descritta come “non ingombrante né fisicamente né moralmente”, suggerendo una presenza discreta e non invasiva. Emilio, al contrario, pur essendo l’egoista, vive con le “spalle gravate di tanta responsabilità” per il destino di lei, attribuendo a questa un peso psicologico su di sé (“pesava sul suo”).
- Carattere/Destino (vecchiaia vs. giovinezza): Amalia è “più vecchia per carattere o forse per destino”, implicando una precoce rassegnazione o una saggezza silenziosa. Emilio, a trentacinque anni, si definisce “l’egoista, il giovane”, suggerendo una giovinezza prolungata, un’immaturità emotiva e un’incapacità di assumere responsabilità adulta.
- Altruismo/Sacrificio vs. Egoismo/Egocentrismo: Amalia “viveva per lui come una madre dimentica di se stessa”, evidenziando il suo altruismo e la sua dedizione disinteressata. Emilio è apertamente definito “l’egoista”, la cui percezione del peso della sorella non gli impedisce di mantenere la sua centralità narcisistica.
- Accettazione passiva vs. Brama insoddisfatta: Amalia sembra accettare la sua condizione senza brama, mentre Emilio vive con una “brama insoddisfatta di piaceri e di amore” e l’amarezza di non averne goduto, rivelando un’interiorità tormentata e passiva.
In sostanza, Amalia è un personaggio di dedizione silenziosa e accettazione, quasi rassegnata, mentre Emilio è l’inettone egoista, perennemente in attesa, che proietta su di lei le sue responsabilità e paure, rimanendo bloccato in una giovinezza psicologica.
3. Quali sono i due scopi che il protagonista attribuisce alle sue due occupazioni? In che cosa queste due occupazioni si contrappongono?
Il protagonista Emilio Brentani attribuisce due scopi ben distinti alle sue due occupazioni:
- Impieguccio di poca importanza (presso una società di assicurazioni): Lo scopo di questa occupazione è puramente economico e di sostentamento. Egli ne traeva “giusto il denaro di cui la famigliuola abbisognava”. È un lavoro pragmatico, di necessità, volto a garantire la sopravvivenza e la stabilità economica del piccolo nucleo familiare.
- Carriera letteraria: Lo scopo di questa occupazione è personale e di vanità/ambizione. Emilio ne traeva una “riputazioncella, – soddisfazione di vanità più che d’ambizione”. Non gli rendeva denaro, ma appagava il suo ego e la sua aspirazione a essere riconosciuto come intellettuale. Sebbene il romanzo fosse “lodatissimo” e gli avesse dato una “specie di rispettabilità letteraria”, la sua inerzia nel non aver fatto nulla dopo la prima pubblicazione dimostra che l’obiettivo non era una vera e propria carriera, ma piuttosto il mantenimento di un’immagine.
Queste due occupazioni si contrappongono in diversi modi:
- Necessità vs. Vanità/Aspirazione: L’impiego è per la necessità materiale, la scrittura per la vanità e un’ambizione latente, ma inerte.
- Sostentamento vs. Assenza di reddito: L’uno è fonte di denaro, l’altra “non gli rendeva nulla”.
- Concretezza vs. Illusione/Inerzia: L’impiego è concreto e funzionale, mentre la carriera letteraria è fatta di un passato glorificato ma senza seguito, basata su un’illusione di grandezza e caratterizzata dall’inerzia. L’impiego è un “dovere”, la carriera letteraria un “sogno” non perseguito.
4. ‘Come nella vita così anche nell’arte, egli credeva di trovarsi ancora sempre nel periodo di preparazione’: quale atteggiamento del protagonista del romanzo deriva da tale condizione psicologica?
La convinzione di Emilio di trovarsi “ancora sempre nel periodo di preparazione” (sia nella vita che nell’arte) deriva da una specifica condizione psicologica che lo porta a un atteggiamento di inettitudine, procrastinazione e autoinganno.
Da questa condizione psicologica derivano i seguenti atteggiamenti:
- Procrastinazione e inerzia: La sua “preparazione” non si traduce mai in azione concreta. Nonostante avesse pubblicato un romanzo “lodatissimo”, per “molti anni… non aveva fatto nulla, per inerzia non per sfiducia”. Questo indica una tendenza a rimandare, a non impegnarsi attivamente nella realizzazione dei suoi obiettivi. La vita e l’arte sono viste come qualcosa da cui si deve “prepararsi”, piuttosto che qualcosa in cui ci si deve immergere.
- Autoinganno e illusione di grandezza: Si considera una “potente macchina geniale in costruzione, non ancora in attività”. Questa è una forma di autoinganno che gli permette di giustificare la sua inerzia. Invece di riconoscere la sua incapacità di agire, si convince di essere un genio in potenza, la cui vera attività è solo rimandata a un futuro indefinito.
- Attesa passiva e non paziente: “Viveva sempre in un’aspettativa, non paziente, di qualche cosa che doveva venirgli dal cervello, l’arte, di qualche cosa che doveva venirgli di fuori, la fortuna, il successo”. L’attesa è “non paziente”, il che sottolinea la sua ansia latente, ma al contempo passiva, perché non accompagnata da un’azione concreta per favorire l’arrivo di ciò che desidera. Egli attende che il successo gli “venga” dall’esterno o che la sua “arte” emerga spontaneamente, senza un lavoro costante.
- Evitamento del godimento e della felicità: Sentendosi gravato da responsabilità (“spalle gravate di tanta responsabilità”), Emilio attraversa la vita “cauto, lasciando da parte tutti i pericoli ma anche il godimento, la felicità”. La sua inettitudine lo porta a rifugiarsi in un’esistenza mediocre, priva di rischi ma anche di autentiche gioie, giustificando questa rinuncia con la sua presunta condizione di “preparazione”.
- Paura di sé e della propria debolezza: L’affermazione “nel cervello una grande paura di se stesso e della debolezza del proprio carattere, invero piuttosto sospettata che saputa per esperienza” rivela che questa “preparazione” è anche un meccanismo di difesa per evitare di mettersi alla prova e confrontarsi con i propri limiti e le proprie paurezze.
In sintesi, la condizione di “preparazione” è il simbolo di una profonda inettitudine che impedisce a Emilio di vivere pienamente, bloccandolo in un limbo di potenzialità inespresse e illusioni auto-costruite.
Interpretazione
Il brano, incipit di Senilità, è un’introduzione magistrale al tema dell’inettitudine, elemento centrale e caratteristico della produzione di Italo Svevo. L’inettitudine di Emilio Brentani non è solo una debolezza caratteriale, ma diventa la rappresentazione della crisi di valori e di certezze che permea la borghesia a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Questa condizione esistenziale, frutto di un’epoca di profonde trasformazioni, si manifesta in una sostanziale incapacità di vivere pienamente, di agire, di affrontare la realtà con autenticità, rifugiandosi nell’autoinganno e in un’eterna “preparazione”.
Emilio è l’emblema dell’inetto, un uomo che a trentacinque anni non ha ancora realizzato le sue aspirazioni, né in amore né nell’arte, e che vive in un limbo di potenzialità inespresse. La sua “brama insoddisfatta di piaceri e di amore” è affiancata dall'”amarezza di non averne goduto”, una condizione di passività e di rimpianto che lo blocca. La sua inettitudine è una fuga dalla vita, giustificata da un’illusione di essere una “potente macchina geniale in costruzione”. Questa attesa passiva di un successo che deve “venirgli dal cervello” o “di fuori” è la cifra della sua incapacità di assumere responsabilità e di agire nel mondo.
L’inettitudine di Emilio si inserisce perfettamente nel contesto della crisi di valori e di certezze che caratterizza l’epoca di Svevo. La borghesia triestina, descritta dall’autore, è una classe sociale che ha perso la vitalità e la concretezza delle generazioni precedenti, rifugiandosi in una mediocre tranquillità o in ambizioni superficiali. La vita di Emilio è divisa tra un “impieguccio di poca importanza” per il sostentamento e una “riputazioncella” letteraria per la vanità. Mancano ideali forti, passioni autentiche (se non quella per Angiolina, che si rivelerà distruttiva), e una volontà di autoaffermazione. Questa assenza di valori solidi si traduce in una debolezza del carattere, in un’incapacità di scegliere e di agire, lasciando i personaggi preda delle circostanze o delle proprie nevrosi.
Questa rappresentazione dell’inettitudine è un filo rosso che attraversa tutta l’opera di Svevo. In Una vita, Alfonso Nitti è un altro “inetto” che non riesce a inserirsi nel mondo del lavoro e dell’amore, finendo per soccombere. Ma è soprattutto ne La coscienza di Zeno che il tema dell’inettitudine raggiunge la sua massima espressione, seppur con una tonalità diversa. Zeno Cosini è un borghese triestino che tenta invano di liberarsi della “malattia della vita” (il fumo, l’amore, l’affare), ma la sua inettitudine è anche la sua “salvezza”. La sua nevrosi, il suo non essere “perfettamente adatto” alla vita, gli consente di osservare il mondo con distacco critico, di ironizzare su se stesso e sulle convenzioni sociali. Se Emilio è intrappolato in un’inettitudine che lo rende un “vecchio” prematuro, Zeno scopre che la sua stessa “malattia” gli permette di sopravvivere in un mondo che considera “malato” (come emerge dalla celebre digressione sull’umanità alla fine del romanzo). L’inettitudine, in Zeno, diventa una forma di difesa e di adattamento.
Il tema dell’inetto e della crisi della borghesia è stato esplorato anche da altri autori italiani e stranieri. In Italia, un confronto immediato è con Luigi Pirandello. I suoi personaggi, come Vitangelo Moscarda in Uno, nessuno e centomila o Mattia Pascal ne Il fu Mattia Pascal, sono anch’essi in crisi identitaria, prigionieri delle “maschere” sociali e dell’impossibilità di un’esistenza autentica. La loro “inettitudine” è spesso una paralisi di fronte alla percezione dell’assurdo e della relatività della realtà. Il loro tentativo di liberarsi dalle forme sociali li porta non alla libertà, ma alla non-esistenza, come nel caso di Mattia Pascal che si scopre un “uccello senza nido”.
A livello europeo, il tema dell’uomo in crisi, dell’alienazione e dell’incapacità di agire è centrale in molti autori del Novecento.
- Franz Kafka: In opere come Il processo o Il castello, i suoi personaggi (Josef K., K.) sono emblematici dell’impotenza dell’individuo di fronte a un sistema burocratico e oppressivo, o a un’esistenza priva di senso. La loro “inettitudine” si manifesta come una disperata incapacità di comprendere e di opporsi a forze soverchianti.
- Robert Musil: Ne L’uomo senza qualità, Ulrich, il protagonista, è un intellettuale che vive in uno stato di “possibilità” non realizzate, osservando il mondo con distacco critico ma senza mai agire concretamente. Anche lui incarna una forma di inettitudine, legata alla crisi della cultura e dei valori della Mitteleuropa pre-bellica.
In altre forme d’arte, il cinema, in particolare, ha spesso rappresentato l’uomo inetto. Si pensi a certi personaggi di Michelangelo Antonioni (come quelli de L’Avventura o La notte), che vagano in paesaggi urbani moderni, preda di un’alienazione e di una noia esistenziale, incapaci di comunicare o di trovare un senso alla loro vita.
In conclusione, il ritratto di Emilio Brentani in Senilità è una delle più acute analisi dell’inettitudine come sintomo di una profonda crisi esistenziale. L’incapacità di vivere pienamente, la passività, l’autoinganno e la procrastinazione non sono solo difetti individuali, ma riflettono il degrado morale di una borghesia che ha perso i suoi valori e le sue certezze. Svevo, con la sua prosa introspettiva e la sua visione disincantata, ci invita a riflettere sulle patologie dell’anima moderna e sulla difficoltà dell’uomo di trovare un senso autentico alla propria esistenza in un mondo in rapido cambiamento.




