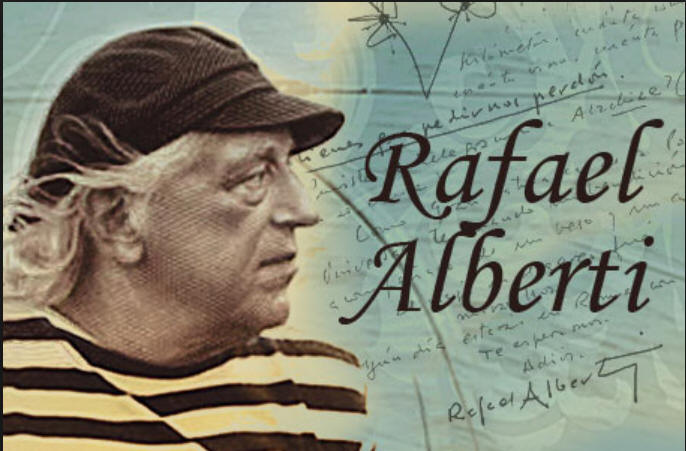
Han sradicato un albero di Rafael Alberti
28 Dicembre 2019
Mediterraneo: economia, stati e conflitti
28 Dicembre 2019Analisi e testo delle ultime cinque terzine del Canto quindicesimo del Paradiso
Analisi: Paradiso, Canto XV, vv. 133-147 di Dante Alighieri
Gli ultimi versi del Canto XV del Paradiso sono dedicati alla diretta rivelazione dell’identità di Cacciaguida, il trisavolo di Dante. Dopo aver lodato l’antica Firenze e aver preparato il terreno con la descrizione di un’epoca di virtù, Cacciaguida si presenta, fornendo dettagli sulla sua vita terrena, la sua famiglia, la sua partecipazione alle Crociate e il suo martirio, che lo ha condotto alla pace celeste. Questi versi sono cruciali per stabilire il legame personale tra Dante e la sua stirpe, e per rafforzare il tema della missione profetica del poeta.
1. La Nascita e il Battesimo di Cacciaguida (vv. 133-135)
Cacciaguida inizia la sua presentazione con un riferimento alla sua nascita e al suo battesimo, avvenuti in un contesto di fede e semplicità.
Maria mi diè, chiamata in alte grida; e ne l’antico vostro Batisteo insieme fui cristiano e Cacciaguida. (vv. 133-135)
Il verso “Maria mi diè, chiamata in alte grida” si riferisce all’usanza delle donne fiorentine di invocare la Vergine Maria durante il parto. Cacciaguida fu battezzato nel “vostro Batisteo” (il Battistero di San Giovanni a Firenze, che per Dante era il luogo sacro per eccellenza, simbolo dell’identità fiorentina e della fede cristiana), e lì ricevette sia il nome cristiano che quello familiare, “Cacciaguida”. Questo sottolinea la profonda integrazione tra fede e identità civica nell’antica Firenze.
Il Battistero di San Giovanni a Firenze.
2. La Famiglia di Cacciaguida e l’Origine del Cognome Alighieri (vv. 136-138)
Cacciaguida prosegue presentando i suoi fratelli e l’origine del cognome di Dante, “Alighieri”.
Moronto fu mio frate ed Eliseo; mia donna venne a me di val di Pado, e quindi il sopranome tuo si feo. (vv. 136-138)
Egli nomina i suoi fratelli, Moronto ed Eliseo. Poi rivela che sua moglie proveniva dalla “val di Pado” (la Val Padana), e da lei derivò il “sopranome” (cognome) di Dante, Alighieri. Questo dettaglio genealogico è di grande importanza per Dante, che in questo modo vede riconosciuta e nobilitata la sua stirpe, legandola a un passato di virtù.
Un albero genealogico stilizzato.
3. La Partecipazione alla Crociata e il Martirio (vv. 139-147)
Il racconto di Cacciaguida culmina con la sua partecipazione alla Seconda Crociata (1147-1149), sotto la guida dell’imperatore Corrado III (che Dante chiama “Currado”).
Poi seguitai lo ’mperador Currado; ed el mi cinse de la sua milizia, tanto per bene ovrar li venni in grado. (vv. 139-141)
Cacciaguida fu armato cavaliere dall’Imperatore stesso (“el mi cinse de la sua milizia”), segno del suo valore e della sua dedizione. La sua partecipazione alla Crociata è presentata come una lotta contro la “nequizia di quella legge il cui popolo usurpa, / per colpa d’i pastor, vostra giustizia”.
Dietro li andai incontro a la nequizia di quella legge il cui popolo usurpa, per colpa d’i pastor, vostra giustizia. (vv. 142-144)
La “legge” è l’Islam, e il “popolo” sono i Saraceni. L’accusa che essi “usurpano vostra giustizia” (cioè la giustizia cristiana, o la Terra Santa che appartiene ai cristiani) è un riferimento alla visione medievale delle Crociate come guerra santa. La frase “per colpa d’i pastor” è un’importante critica di Dante alla corruzione del clero e dei papi, che con il loro malgoverno hanno favorito l’avanzata degli infedeli o ne hanno compromesso la sconfitta.
Cavalieri crociati in battaglia.
Il racconto si conclude con il suo martirio, che lo ha liberato dal “mondo fallace” e lo ha condotto alla pace del Paradiso.
Quivi fu’ io da quella gente turpa disviluppato dal mondo fallace, lo cui amor molt’ anime deturpa; e venni dal martiro a questa pace». (vv. 145-148)
Cacciaguida fu “disviluppato” (liberato) dal suo corpo e dal “mondo fallace” (il mondo terreno, ingannevole) per mano dei Saraceni (“quella gente turpa”). La sua morte in battaglia per la fede è un martirio, che gli ha garantito l’accesso diretto a questa “pace” celeste. Il “mondo fallace” è quello che “deturpa” (corrompe) molte anime con il suo amore per le cose terrene.
Una mano che si libera da catene luminose, che simboleggia l’essere “disviluppato dal mondo fallace”.
4. Temi e Significati
- Riconoscimento e Identità: La rivelazione di Cacciaguida è fondamentale per Dante. Non solo gli fornisce un legame con il passato glorioso della sua famiglia, ma rafforza la sua identità e il suo senso di appartenenza a una stirpe di uomini virtuosi.
- La Lode della Virtù Antica: La figura di Cacciaguida incarna la virtù, la fede e la semplicità della Firenze antica, contrapposta alla corruzione contemporanea.
- Missione Profetica di Dante: Il martirio di Cacciaguida e la sua presenza in Paradiso conferiscono a Dante un’autorità morale e spirituale. La sua missione di testimone e profeta è rafforzata dal legame con un antenato che ha combattuto per la fede e ha raggiunto la beatitudine.
- Critica alla Chiesa: La frase “per colpa d’i pastor, vostra giustizia” è un’ulteriore, seppur velata, critica alla decadenza morale della Chiesa del tempo di Dante, che ha compromesso la causa della Cristianità.
- Il Valore del Martirio: La morte in difesa della fede è presentata come la via più alta per raggiungere la salvezza e la pace eterna.
- Il Mondo Terreno come “Fallace”: Il mondo è visto come un luogo di inganno e corruzione, da cui solo la morte (o il martirio) può liberare l’anima.
5. Stile e Linguaggio
- Tono Solenne e Affettuoso: Il linguaggio di Cacciaguida è elevato e dignitoso, ma al tempo stesso intriso di affetto paterno verso Dante.
- Dettagli Biografici: La precisione nei dettagli (nomi dei fratelli, provenienza della moglie, riferimento all’imperatore Corrado) conferisce concretezza storica al personaggio.
- Espressioni Teologiche e Militari: Il linguaggio mescola termini religiosi (“Maria”, “Batisteo”, “cristiano”, “martiro”, “pace”) con quelli militari (“milizia”, “legge”, “popolo usurpa”).
- Immagini di Liberazione: L’immagine di essere “disviluppato dal mondo fallace” suggerisce un processo di liberazione e purificazione.
- Sintassi Chiara: La sintassi è diretta e chiara, facilitando la comprensione della narrazione biografica.
Conclusione
Gli ultimi versi del Canto XV del Paradiso sono il culmine della presentazione di Cacciaguida, che si rivela a Dante non solo come antenato, ma come figura esemplare di virtù e fede. Il suo racconto, che culmina nel martirio per la causa cristiana, non solo rafforza il legame personale di Dante con un passato glorioso, ma gli fornisce anche un modello di rettitudine e un’ulteriore conferma della giustizia divina. La critica implicita alla Chiesa contemporanea e la visione del mondo terreno come “fallace” preparano il terreno per le successive, più esplicite, profezie di Cacciaguida e per la piena consapevolezza di Dante della sua missione di poeta e profeta.

Testo originale di Paradiso, Canto XV, vv. 134-145 di Dante Alighieri
Dante Alighieri – Divina Commedia
Paradiso – Canto XV (vv. 133-145)
(Conclusione: Cacciaguida rivela la sua vita terrena e la morte da crociato)
133 Maria mi diè, chiamata in alte grida;
134 e ne l’antico vostro Batisteo
135 insieme fui cristiano e Cacciaguida.
-
Battesimo: Ricevuto nel Battistero di San Giovanni (“Batisteo”), simbolo dell’identità fiorentina.
-
Nome: “Cacciaguida” è presentato come nome di battesimo, legato alla tradizione familiare.
136 Moronto fu mio frate ed Eliseo;
137 mia donna venne a me di val di Pado,
138 e quindi il sopranome tuo si feo.
-
Famiglia: Fratelli Moronto ed Eliseo (nomi di origine germanica, tipici dell’aristocrazia medievale).
-
Matrimonio: La moglie proveniva dalla Val Padana (“val di Pado”), da cui deriverebbe il cognome Alighieri (“Eliseo” → “Aligerius”).
139 Poi seguitai lo ’mperador Currado;
140 ed el mi cinse de la sua milizia,
141 tanto per bene ovrar li venni in grado.
-
Servizio militare: Sotto l’imperatore Corrado III di Svevia (1093-1152, crociato), che lo armò cavaliere (“cinse de la sua milizia”).
-
Valore: “per bene ovrar” (per il suo coraggio).
142 Dietro li andai incontro a la nequizia
143 di quella legge il cui popolo usurpa,
144 per colpa d’i pastor, vostra giustizia.
-
Crociata: Contro i musulmani (“quella legge” = Islam), con critica ai papi corrotti (“pastor”) che trascurano la difesa della Cristianità.
145 Quivi fu’ io da quella gente turpa
146 disviluppato dal mondo fallace,
147 lo cui amor molt’ anime deturpa;
-
Morte in battaglia: Ucciso dai “turpi” infedeli, liberato (“disviluppato”) dal mondo corrotto.
-
Condanna dell’attaccamento terreno: “lo cui amor” (amore per il mondo) rovina le anime.
148 e venni dal martiro a questa pace».
-
Apoteosi: Dal martirio alla gloria celeste, conclusione solenne.
Struttura e temi chiave
-
Origini fiorentine (vv. 133-138):
-
Battesimo nel Battistero (simbolo di purezza civica).
-
Legami familiari e etimologia del cognome Alighieri.
-
-
Vita cavalleresca (vv. 139-144):
-
Servizio sotto Corrado III, crociata come dovere morale.
-
Polemica antipapale: accuse ai papi negligenti (cfr. Inferno, XIX).
-
-
Morte e redenzione (vv. 145-148):
-
Martirio come liberazione dalla corruzione terrena.
-
Contrapposizione mondo fallace / pace eterna.
-
Note linguistiche
-
“Batisteo” (v. 134): Latinismo per “Battistero”, enfasi sulla tradizione.
-
“Nequizia” (v. 142): Termine dantesco per “malvagità” (usato anche per i peccatori infernali).
-
“Disviluppato” (v. 146): Metafora di liberazione da un groviglio morale.
Contesto storico
-
Crociate: Cacciaguida partecipa alla Seconda Crociata (1147-1149), fallita per discordie interne.
-
Firenze nel XII secolo: Città ancora legata a valori medievali, prima delle lotte tra Guelfi e Ghibellini.




