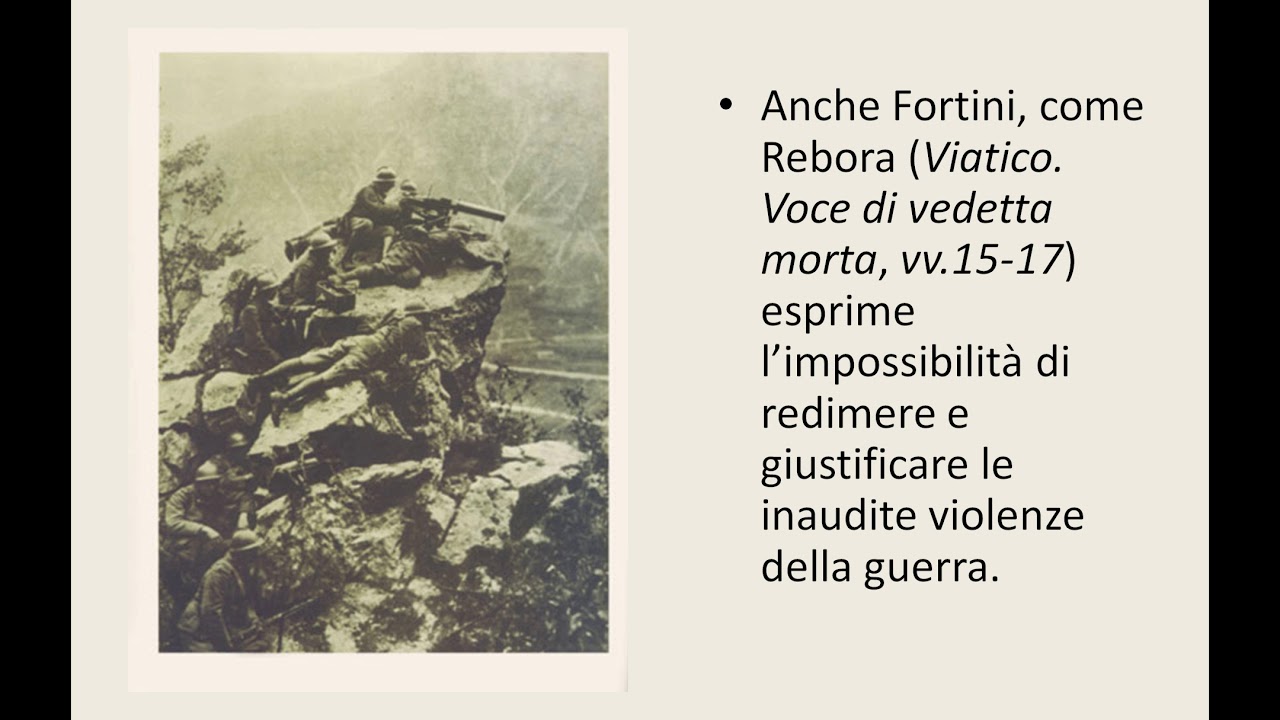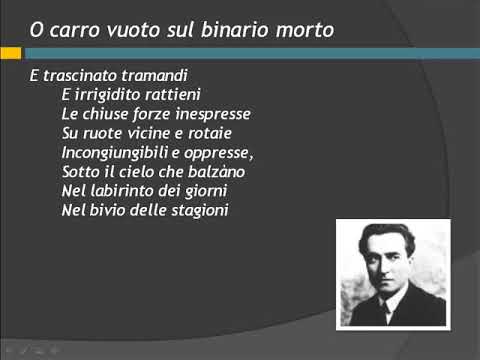
Analisi del testo O carro vuoto sul binario morto di Clemente Rebora
29 Luglio 2019
Bielorussia: lezione di geografia
29 Luglio 2019Quel giovane tedesco di Franco Fortini si distingue come una delle voci più acute e tormentate della poesia italiana di fine Novecento.
Affronta l’intricato tema della responsabilità intellettuale e il legame tra letteratura e impegno politico. Quest’opera, pubblicata nella raccolta del 1969 “Poesia ed errore”, è strutturata in tre parti, ciascuna delle quali offre una drammatica riflessione sul ruolo del poeta di fronte alla storia e alla violenza.
Quel giovane tedesco
ferito sul Lungosenna
ai piedi d’una casa
durante l’insurrezione
che moriva solo 5
mentre Parigi era urla
intorno all’Hôtel de Ville
e moriva senza lamenti
la fronte sul marciapiede.
La prima sezione dipinge un vivido ritratto di un soldato tedesco morente durante la Liberazione di Parigi nell’agosto del 1944. L’immagine del giovane “ferito sul Lungosenna ai piedi di una casa” evoca immediatamente un senso di compassione umana che trascende le divisioni politiche. I precisi riferimenti geografici (“Lungosenna”, “Hôtel de Ville”) ancorano la memoria a precise coordinate storiche, mentre la rappresentazione della sua morte solitaria – “morì solo mentre Parigi urlava” – crea uno stridente contrasto tra la tragedia individuale e la celebrazione collettiva della liberazione.
Il dettaglio della sua “fronte sul marciapiede” assume un significato simbolico: il legame con il suolo urbano suggerisce una riconciliazione finale dell’individuo con la dura realtà, ben lontana dalle ideologie che lo hanno condotto alla morte. La solitudine di una morte “senza lamento” conferisce al personaggio una dignità tragica, trasformando il nemico in una figura umana universale, al di là delle appartenenze politiche.
Quel fascista a Torino 10
che sparò per due ore
e poi scese per strada
con la camicia candida
con i modi distinti
e disse andiamo pure 15
asciugando il sudore
con un foulard di seta.
Nella seconda sezione, l’attenzione si sposta su un fascista torinese, presumibilmente durante la Resistenza. Le azioni del personaggio – “sparò per due ore e poi scese in strada in camicia bianca” – rivelano una compostezza aristocratica che Fortini osserva con una lucidità scevra da facili giudizi morali. I “maneggi distinti” e la “sciarpa di seta” indicano una classe sociale e una mentalità che mantengono i segni della civiltà borghese anche in mezzo alla violenza. Il gesto di “asciugarsi il sudore” dopo la sparatoria introduce un elemento di vita quotidiana che umanizza la scena, ricordandoci la complessità di questi momenti storici.
La poesia non vale
l’incanto non ha forza
quando tornerà il tempo 20
uccidetemi allora.
La terza e più complessa sezione rappresenta il cuore teorico del componimento, dove Fortini elabora una riflessione meta-poetica di straordinaria intensità. L’affermazione “La poesia non vale l’incanto / non ha forza” segna una crisi profonda nella fiducia verso la letteratura come strumento di cambiamento sociale. Questa sfiducia si ricollega direttamente alla tradizione della poesia civile italiana, da Foscolo a Pasolini, mettendo in discussione la sua efficacia e il suo significato.
La drammatica richiesta “quando tornerà il tempo / uccidetemi allora” esprime la consapevolezza di appartenere a una generazione di transizione, inadeguata ai nuovi tempi che si profilano all’orizzonte.
Ho letto Lenin e Marx
non temo la rivoluzione
ma è troppo tardi per me;
almeno queste parole 25
servissero dopo di me
alla gioia di chi viva
senza più il nostro orgoglio.
Il riferimento a “Lenin e Marx” colloca il discorso nel contesto del marxismo occidentale, mentre l’ammissione “non temo la rivoluzione / ma è troppo tardi per me” svela la condizione dell’intellettuale borghese che, pur riconoscendo razionalmente la necessità del cambiamento, si percepisce strutturalmente incapace di attuarlo.
L’explicit del componimento – “almeno queste parole / servissero dopo di me / alla gioia di chi viva / senza più il nostro orgoglio” – trasforma la poesia in un testamento morale. L'”orgoglio” a cui Fortini si riferisce è quello dell’intellettuale umanistico, della cultura letteraria tradizionale, che deve essere superato per consentire l’emergere di una società più giusta. Il poeta si propone come vittima sacrificale necessaria per il progresso storico, in una visione tragica ma non pessimistica del proprio ruolo.
Dal punto di vista formale, Fortini utilizza un verso libero di impostazione narrativa, caratterizzato da una sintassi semplice che contrasta con la complessità del contenuto ideologico. La struttura paratattica e l’assenza di ornamenti retorici conferiscono al testo un’efficacia comunicativa diretta, in linea con la poetica fortiniana che rifiuta l’estetismo per privilegiare la chiarezza dell’argomentazione.
Stile
La metrica alterna tra versi brevi e lunghi seguendo una logica espressiva che si adatta al ritmo del pensiero, piuttosto che a schemi rigidi. Le pause nei versi spesso si allineano con pause logiche, creando un effetto di prosa poetica che rende più facile la comprensione dei concetti, senza compromettere la tensione lirica.
Conclusione
“Quel giovane tedesco” si inserisce nel dibattito culturale degli anni Sessanta riguardo al legame tra letteratura e politica, anticipando temi che diventeranno cruciali dopo il ’68. La capacità di Fortini di unire rigore ideologico e pietà umana, analisi marxista e sensibilità umanistica, rende questo componimento un documento chiave per comprendere le contraddizioni dell’intellettuale di sinistra nel secondo Novecento.
Inoltre, il testo è un esempio significativo di quella “poesia critica” che Fortini teorizzava come alternativa sia al lirismo puro che alla propaganda, una forma espressiva capace di mantenere alta la tensione estetica mentre affronta direttamente i nodi politici e morali del presente. In questo modo, la poesia diventa uno strumento di conoscenza e autocoscienza, uno spazio di elaborazione teorica che non rinuncia all’emozione e all’immaginazione tipiche della letteratura.
Testo della poesia “Quel giovane tedesco” di Franco Fortini
Quel giovane tedesco di Franco Fortini
Quel giovane tedesco
ferito sul Lungosenna
ai piedi d’una casa
durante l’insurrezione
che moriva solo 5
mentre Parigi era urla
intorno all’Hôtel de Ville
e moriva senza lamenti
la fronte sul marciapiede.
Quel fascista a Torino 10
che sparò per due ore
e poi scese per strada
con la camicia candida
con i modi distinti
e disse andiamo pure 15
asciugando il sudore
con un foulard di seta.
La poesia non vale
l’incanto non ha forza
quando tornerà il tempo 20
uccidetemi allora.
Ho letto Lenin e Marx
non temo la rivoluzione
ma è troppo tardi per me;
almeno queste parole 25
servissero dopo di me
alla gioia di chi viva
senza più il nostro orgoglio.
da Poesia ed errore, Mondadori, Milano, 1969