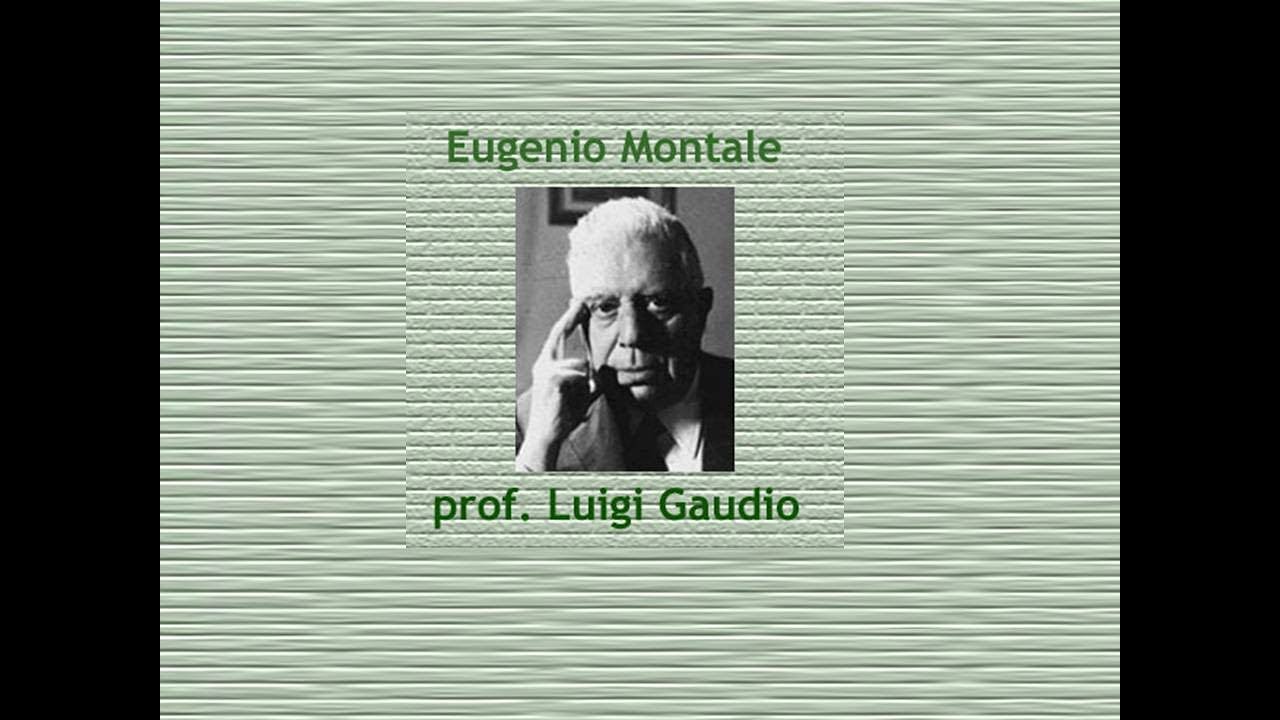Analisi della poesia L’anguilla di Eugenio Montale
19 Luglio 2020
Bambine ad Auschwitz. Laurea honoris causa alle sorelle Bucci
22 Luglio 2020
Analisi del brano “È ancora possibile la poesia?” di Eugenio Montale, con traccia di un compito per una classe quinta superiore e svolgimento
Traccia Tipologia A – Analisi: Montale, E’ ancora possibile la poesia?
Obiettivi:
- analizzare tutti i passaggi del ragionamento di Montale
- commentare il contenuto, l’efficacia stilistica, l’attualità
- esprimere un giudizio personale con esemplificazioni desunte dalle proprie conoscenze e dalla propria esperienza
Valutazione:
- analisi del contenuto e dello stile del brano p. 4
- commento pertinente e coerente p. 4
- giudizi personali motivati p. 4
- correttezza e proprietà p. 3
Tempo: 4 ore
Spazio: max 4 colonne foglio protocollo diviso a metà
Traccia:
In una parte del discorso pronunciato nel 1975 da Montale a Stoccolma, quando gli fu assegnato il Nobel, emerge un’analisi pessimistica della società contemporanea, analisi che coinvolge i giovani e affronta problemi e riflessioni molto attuali. Dopo aver enucleato i concetti chiave del ragionamento di Montale esprimi, commentando il pezzo proposto, tuoi giudizi personali e riferimenti alla realtà contemporanea che ritieni pertinenti e significativi.
Evidentemente le arti, tutte le arti visuali, stanno democratizzandosi nel senso peggiore della parola. L’arte è produzione di oggetti di consumo, da usarsi e da buttarsi via in attesa di un nuovo mondo nel quale l’uomo sia riuscito a liberarsi di tutto, anche della propria coscienza. L’esempio che ho portato potrebbe estendersi alla musica esclusivamente umoristica e indifferenziata che si ascolta nei luoghi dove milioni di giovani si radunano per esorcizzare l’orrore della loro solitudine. Ma perché oggi più che mai l’uomo civilizzato è giunto ad avere orrore di se stesso? […]
Fa impressione il fatto che una sorta di generale millenarismo si accompagni a un sempre più diffuso comfort, il fatto che il benessere (là dove esiste, cioè in limitati spazi della terra) abbia i lividi connotati della disperazione. Sotto lo sfondo così cupo dell’attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a confondersi, a smarrire la loro identità. […]
In tale paesaggio di esibizionismo isterico quale può essere il posto della più discreta delle arti, la poesia? […]
Ma ora per concludere debbo una risposta alla domanda che ha dato un titolo a questo breve discorso. Nella attuale civiltà consumistica che vede affacciarsi alla storia nuove nazioni e nuovi linguaggi, nella civiltà dell’uomo robot, quale può essere la sorte della poesia? Le risposte potrebbero essere molte. […]
Si potrebbero moltiplicare le domande con l’unico risultato che non solo la poesia, ma tutto il mondo dell’espressione artistica o sedicente tale è entrato in una crisi che è strettamente legata alla condizione umana, al nostro esistere di esseri umani, alla nostra certezza o illusione di crederci esseri privilegiati, i soli che si credono padroni della loro sorte e depositari di un destino che nessun’altra creatura vivente può vantare. Inutile dunque chiedersi quale sarà il destino delle arti. E’ come chiedersi se l’uomo di domani, di un domani magari lontanissimo, potrà risolvere le tragiche contraddizioni in cui si dibatte fin dal primo giorno della Creazione (e se di un tale giorno, che può essere un’epoca sterminata, possa ancora parlarsi).
Analisi: Montale, “È ancora possibile la poesia?”
Analisi del contenuto e dei passaggi del ragionamento
Il discorso di Montale al Nobel del 1975 si articola attraverso una progressione logica che parte dall’osservazione della contemporaneità per giungere a una riflessione esistenziale più ampia. Il poeta ligure costruisce il suo ragionamento attraverso tre movimenti fondamentali.
Primo movimento: la democratizzazione delle arti come degrado Montale apre con una diagnosi impietosa della condizione artistica contemporanea. La “democratizzazione nel senso peggiore” rappresenta il nucleo della sua critica: l’arte è divenuta merce di consumo, oggetto usa-e-getta in una società che aspira a liberarsi “anche della propria coscienza”. Questa osservazione rivela una concezione aristocratica dell’arte, vista come esperienza di élite minacciata dalla massificazione.
Secondo movimento: il paradosso del benessere disperato Il ragionamento procede verso un’analisi sociologica più profonda. Montale individua un paradosso centrale della civiltà occidentale: il “millenarismo” che accompagna il comfort, il benessere che assume “i lividi connotati della disperazione”. È una diagnosi acuta dell’alienazione moderna, dove il progresso materiale non corrisponde a una crescita spirituale.
Terzo movimento: la crisi ontologica dell’uomo La riflessione culmina in una domanda esistenziale radicale. La crisi dell’arte è sintomo di una crisi più profonda: quella dell’uomo che si crede “padrone della propria sorte” ma si dibatte nelle “tragiche contraddizioni” che lo caratterizzano “fin dal primo giorno della Creazione”. Qui Montale tocca il nucleo filosofico del suo pensiero: l’inadeguatezza costitutiva dell’essere umano.
Efficacia stilistica
La prosa montaliana rivela una maestria retorica notevole. Il poeta utilizza una strategia argomentativa che procede per domande retoriche (“Ma perché oggi più che mai…?”, “quale può essere il posto…?”), creando un ritmo incalzante che coinvolge il lettore nel processo di interrogazione.
La sintassi è complessa ma mai oscura, caratterizzata da periodi ampi che rispecchiano la complessità del pensiero. Particolarmente efficaci sono le immagini concrete che materializzano concetti astratti: i “lividi connotati della disperazione”, l'”esibizionismo isterico”, l'”uomo robot”. Queste metafore conferiscono plasticità visiva al ragionamento filosofico.
Il registro linguistico alterna momenti di solennità oratoria (“Fa impressione il fatto che…”) a passaggi di maggiore colloquialità, mantenendo sempre un tono di sobria eleganza che riflette la “discrezione” che Montale attribuisce alla poesia stessa.
Attualità della riflessione
La lucidità profetica di Montale risulta straordinariamente attuale. La sua critica alla società dei consumi anticipa fenomeni che oggi riconosciamo come centrali: la mercificazione dell’arte attraverso le logiche di mercato, l’industria culturale che produce contenuti seriali e standardizzati, la crisi dell’attenzione in un mondo saturo di stimoli.
La “musica esclusivamente umoristica e indifferenziata” che accompagna i raduni giovanili trova un perfetto parallelo nella musica commerciale contemporanea e nei festival di massa. L'”esibizionismo isterico” descrive con precisione l’epoca dei social media, dove l’apparire prevale sull’essere e l’arte diventa performance per il consenso immediato.
Il “millenarismo” accompagnato dal comfort descrive perfettamente le ansie apocalittiche del nostro tempo: crisi climatica, tensioni geopolitiche, paure tecnologiche che convivono con un benessere materiale senza precedenti nelle società occidentali.
Giudizio personale e riferimenti contemporanei
La diagnosi di Montale, pur condivisibile nella sua acutezza analitica, rivela alcuni limiti che vanno sottolineati. La sua concezione dell’arte come esperienza elitaria riflette una visione aristocratica che non tiene conto delle potenzialità democratiche dell’espressione artistica. Oggi assistiamo a fenomeni di creatività diffusa che, pur nella loro commercializzazione, mantengono spazi di autenticità espressiva.
La “democratizzazione” delle arti ha effettivamente prodotto standardizzazione e mercificazione, ma ha anche permesso l’emergere di voci prima escluse dal canone. La letteratura contemporanea, ad esempio, si è arricchita di prospettive multiculturali, di genere, di classe che hanno ampliato il panorama espressivo. Autori come Elena Ferrante o Roberto Saviano hanno dimostrato che è possibile raggiungere un vasto pubblico mantenendo qualità artistica e profondità di analisi sociale.
Il pessimismo montaliano sulla condizione giovanile appare parziale se confrontato con fenomeni contemporanei come l’attivismo climatico di Greta Thunberg o i movimenti per i diritti civili guidati dalle nuove generazioni. I “milioni di giovani” che si radunano non solo “esorcizzano la solitudine”, ma spesso esprimono forme di resistenza creativa e politica.
Tuttavia, la riflessione sulla “coscienza” rimane centrale. L’era digitale ha effettivamente prodotto nuove forme di alienazione: la dipendenza dai dispositivi, la frammentazione dell’attenzione, la sostituzione dell’esperienza reale con quella virtuale confermano le intuizioni montaliane. La “civiltà dell’uomo robot” trova eco nell’intelligenza artificiale che sempre più spesso sostituisce la creatività umana.
La domanda finale sul destino dell’arte mantiene tutta la sua pertinenza. In un’epoca in cui algoritmi generano poesie e dipinti, in cui il mercato dell’arte è dominato dalla speculazione finanziaria, in cui la letteratura è spesso ridotta a intrattenimento, l’interrogativo montaliano assume nuova urgenza.
Considerazioni conclusive
La grandezza di questo discorso risiede nella capacità di Montale di cogliere tendenze profonde della modernità, anticipando sviluppi che si sarebbero manifestati compiutamente nei decenni successivi. La sua analisi rimane un punto di riferimento imprescindibile per comprendere i rapporti tra arte e società di massa.
Tuttavia, il suo pessimismo va temperato con una considerazione più dialettica: ogni epoca di crisi artistica è anche epoca di rinnovamento. Come la poesia di Montale stesso emerse dalle macerie della tradizione ottocentesca, così l’arte contemporanea cerca nuove forme di espressione che rispondano alle sfide del presente.
La poesia, quella “più discreta delle arti”, continua a esistere non nonostante la società di massa, ma attraverso di essa, trovando nuovi canali di diffusione e nuove modalità espressive. La sua funzione critica e conoscitiva rimane intatta, anzi si rinnova nell’urgenza di dare senso a un mondo sempre più complesso e contraddittorio.
Il valore duraturo della riflessione montaliana sta nell’averci consegnato gli strumenti critici per analizzare questi fenomeni senza facili ottimismi, ma anche senza rinunciare alla speranza che l’arte mantenga la sua funzione di testimonianza e di resistenza alla banalizzazione dell’esistenza.