
Le funzioni e gli usi del participio latino
28 Dicembre 2019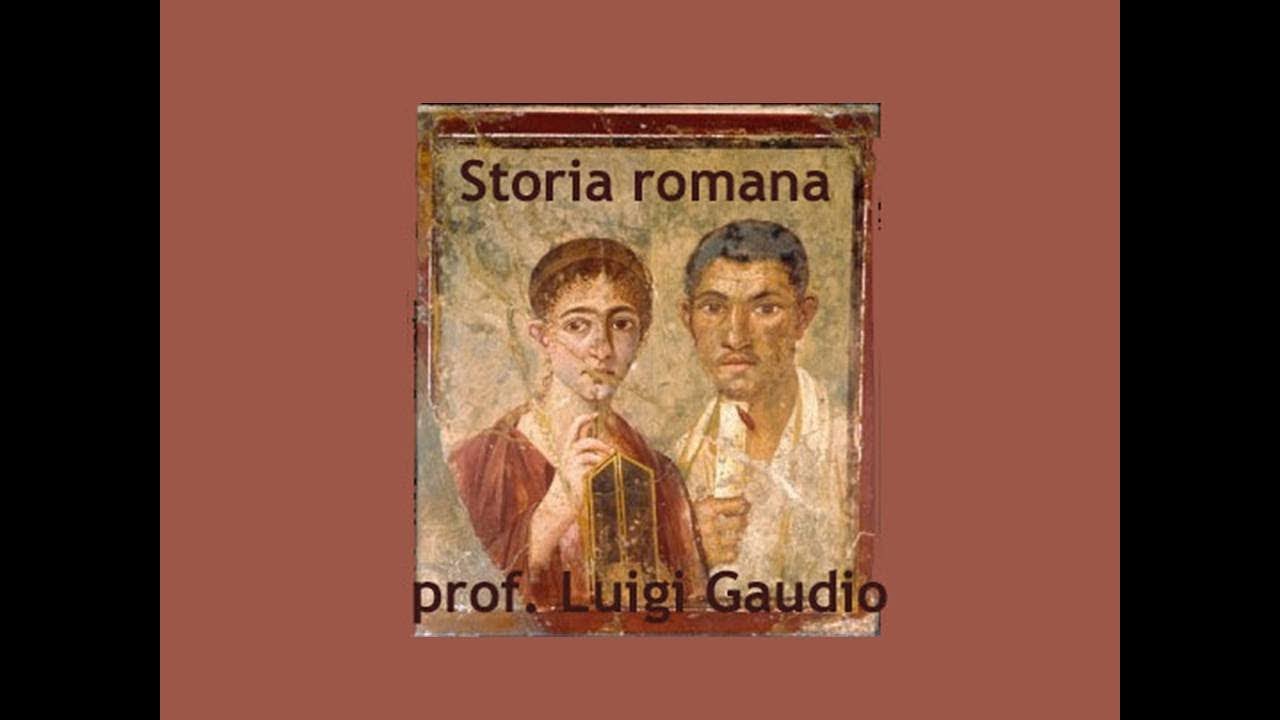
La Prima guerra punica e la pace precaria
28 Dicembre 2019Analisi e testo del Canto II, Dante Alighieri – Commedia: Paradiso
Il Canto II del Paradiso si apre con uno dei proemi più celebri e significativi dell’intera Commedia, fungendo da solenne avvertimento ai lettori e da dichiarazione della straordinaria impresa che Dante si accinge a narrare: il viaggio attraverso i cieli. Questo canto segna l’ingresso di Dante e Beatrice nel primo cielo, quello della Luna, e si trasforma in un’importante lezione di cosmologia e teologia, in cui Beatrice confuta una teoria fisica errata di Dante e spiega la vera ragione delle macchie lunari.
1. Il Proemio: Un Avvertimento e un Invito (vv. 1-18)
Dante si rivolge direttamente ai suoi lettori, distinguendo tra coloro che potranno seguirlo e coloro che, impreparati, dovrebbero rinunciare. È una metafora nautica potente, che sottolinea l’altezza e la difficoltà della materia che sta per affrontare.
O voi, che siete in piccioletta barca, Desiderosi d’ ascoltar, seguiti Dietro al mio legno che cantando varca, Tornate a riveder li vostri liti: Non vi mettete in pelago, che forse, Perdendo me, rimarreste smarriti. (vv. 1-6)
Qui, Dante si paragona a una “legno” (nave) grande e audace, mentre i lettori sono in “piccioletta barca”. L’ammonimento a “tornare a riveder li vostri liti” è un invito a non avventurarsi in un mare di conoscenza troppo profondo senza adeguata preparazione.
Egli invoca poi l’assistenza divina e delle Muse, sottolineando la natura eccezionale del suo viaggio e della sua ispirazione.
L’ acqua ch’ io prendo, già mai non si corse: Minerva spira, e conducemi Appollo, E nove Muse mi dimostran l’ Orse. (vv. 7-9)
“Minerva” (la sapienza divina), “Apollo” (la poesia e l’ispirazione divina) e le “nove Muse” (le arti e le scienze) sono le guide di questo viaggio inedito. I “pochi” lettori scelti, che hanno “drizzaste ‘l collo per tempo al pan de li Agnoli” (cioè che si sono dedicati precocemente alla contemplazione della verità spirituale, il “pan degli Angeli”), sono invitati a seguirlo, mantenendosi nel “solco” tracciato dalla sua nave.
Voi altri poghi, che drizzaste ‘l collo Per tempo al pan de li Agnoli, del quale Vivesi qui; ma non si vien satollo, Metter potete ben per l’alto sale Vostro navilio, servando mio solco Dinanzi a l’ acqua che ritorni equale. (vv. 10-15)
L’impresa di Dante supererà in meraviglia anche quella degli Argonauti, che rimasero ammirati vedendo Giasone trasformato in bifolco a Colco.
Quei gloriosi, che passaro a Colco Non s’ammiraron, come voi farete, Quando Iason vidder fatto bifolco. (vv. 16-18)
Una nave che solca un mare impetuoso illuminato da un raggio di luce, simbolo del viaggio dantesco.
2. L’Ascensione al Primo Cielo: La Luna (vv. 19-30)
Dopo il proemio, Dante e Beatrice ascendono velocemente al primo cielo, quello della Luna. Il momento dell’ingresso è descritto con una sorprendente immagine fisica, che solleva un dubbio nella mente di Dante.
La concreata e perpetua sete Del deiforme regno cen portava Veloci, quasi come ’l Ciel vedete. (vv. 19-21)
È la “sete” innata di Dio che li spinge verso l’alto.
Beatrice in suso, et io in lei guardava; E forsi ’n tanto, ’n quanto un quadrel posa, E vola, e da la noce si dischiava, Iunto mi viddi, ove mirabil cosa Mi torse ’l viso a sè; e però quella, Cui non potea mi’ opra essere ascosa, Volta ver me sì lieta come bella: Drizza la mente in Dio grata, mi disse, Che n’ à coniunti colla prima stella. (vv. 22-30)
La velocità è istantanea, paragonabile al tempo in cui una freccia scocca dall’arco. Ciò che meraviglia Dante è il modo in cui il suo corpo solido possa penetrare un corpo celeste (la Luna) senza impedimenti, come se fosse acqua. Questo fenomeno inspiegabile per la fisica terrestre solleva in lui il desiderio di comprendere la natura dell’Incarnazione di Cristo.
Parevami che nube ne cuoprisse Lucida, spessa, solida e polita, Quasi adamante in che lo Sol ferisse. Per entro sè l’ eterna margarita Ne ricevette, come acqua ricepe Raggio di luce, permanendo unita. (vv. 31-36)
La Luna è descritta come una “nube lucida, spessa, solida e polita, quasi adamante”. Il passaggio è paragonato all’acqua che riceve un raggio di luce, rimanendo unita.
Dante e Beatrice ascendono, un’immagine della loro miracolosa progressione attraverso i cieli (Dorè).
3. Il Dubbio di Dante: Le Macchie Lunari (vv. 49-60)
Dante, ora nella Luna, espone a Beatrice un dubbio che lo assilla da tempo: la causa delle macchie scure visibili sulla superficie lunare. Questa domanda, apparentemente fisica, serve a introdurre un’importante lezione sulla vera natura dei cieli e della virtù divina.
Ma ditemi, che son li segni bui Di questo corpo, che là giù in terra Fan di Cain favoleggiar altrui? (vv. 49-51)
Dante fa riferimento alla credenza popolare che vedeva nelle macchie lunari il volto di Caino, punito per il suo fratricidio. La sua spiegazione personale è basata sulla fisica aristotelica e averroista, credendo che le macchie siano causate da variazioni di densità (raro e denso) nella materia lunare.
Et io: Ciò che n’ appar quassù diverso, Credo che ’l fanno i corpi rari e densi. (vv. 59-60)
La Luna con le sue macchie scure, l’oggetto del dubbio di Dante.
4. La Confutazione di Beatrice: L’Esperimento degli Specchi (vv. 61-111)
Beatrice sorride della semplicità e dell’errore di Dante, preparandosi a confutare la sua teoria. Lei lo invita a non meravigliarsi se l’opinione dei mortali “erra” dove la “ragione à corte l’ali”.
Ella sorrise alquanto, e poi: S’ ell’ erra L’ opinion, mi disse, dei mortali, Dove chiave di senso non disserra, Certo non ti dovrien punger li strali D’ ammirazion omai: dirieto a’ sensi Vedi che la ragione à corte l’ ali. (vv. 52-57)
Beatrice confuta la teoria “raro e denso” con due argomenti principali. Prima, un argomento logico-metafisico: se la diversa luminosità dipendesse solo dalla diversa densità, una sola virtù sarebbe “più e men distributa”, mentre invece i diversi astri mostrano virtù diverse.
Se raro e denso ciò facesser tanto, Una sola virtù serebbe in tutti Più e men distributa, et altrettanto. Virtù diverse esser convegnon frutti Dei princìpi formali; e quei, fuor ch’ uno, Seguitereno a tua ragion destrutti. (vv. 67-72)
Poi, Beatrice propone un esperimento mentale per dimostrare che la rarità/densità non produce la variazione di luce che Dante immagina. L’esperimento coinvolge tre specchi e una fonte di luce: se si posizionano due specchi vicini e uno più lontano tra i primi due, e si illumina da dietro, si vedrà che, anche se la quantità di luce riflessa è minore nel più lontano, il suo splendore è uguale a quello dei vicini. Ciò dimostra che la luminosità non dipende solo dalla quantità di materia riflettente.
Tre specchi prenderai, e i du’ rimovi Da te d’ un modo, e l’ altro più rimosso Tr’ ambo li primi li occhi tuoi ritrovi Rivolti ad esso; e fa che di po’l dosso Ti stia un lume che i tre specchi accenda, E torni a te da tutti ripercosso: Benchè nel quanto tanto non si stenda La vista più lontana, lì vedrai Come convien ch’ equalmentc risplenda. (vv. 97-105)
L’importanza di questo esperimento risiede nel fatto che Beatrice fa ricorso all’esperienza (esperienzia), un metodo di indagine che, pur non essendo ancora il metodo scientifico moderno, è un passo fondamentale verso il ragionamento empirico, e che Dante considerava “fonte ai rivi di nostre arti”.
Tre specchi con un fascio di luce, che illustra l’esperimento di Beatrice per confutare Dante.
5. La Vera Spiegazione: L’Influenza Divina e Angeliche (vv. 112-148)
Dopo aver confutato la teoria di Dante, Beatrice espone la vera ragione delle macchie lunari e, più in generale, della diversa virtù e luminosità dei cieli. La causa non è materiale, ma spirituale.
- Il Primo Mobile e le Intelligenze Angeliche: La virtù divina si irradia dal Primo Mobile (il cielo più esterno, sede di Dio e degli Angeli), e da lì si diffonde attraverso i cieli sottostanti. Ogni cielo è mosso da una diversa intelligenza angelica (chiamata “beato motor”).
Dentro dal Ciel de la divina pace Si gira un corpo, ne la cui virtute L’ esser di tutto suo contento iace. Lo Ciel sequente, ch’ à tante vedute, Quell’ esser parte per diverse essenzie Da lui distinte, e da lui contenute. (vv. 112-117)
- Diversità delle Virtù: Queste intelligenze angeliche “dispongono al lor fine lor semenze” (cioè distribuiscono la loro virtù specifica) ai cieli, differenziandone le proprietà. È come se il movimento e la virtù dei cieli fossero l’arte del fabbro che forgia con il martello, guidato da questi motori celesti.
Lo moto e la virtù dei santi giri, Come dal fabbro l’ arte del martello, Da’ beati motor convien che spiri. Lo Ciel, cui tanti lumi fanno bello, Dalla mente profonda che lui volve, Prende l’ image, e fassene suggello. (vv. 127-132)
- Analogia con l’Anima Umana: Beatrice usa un’analogia con l’anima umana, che, pur essendo una, si distribuisce in diverse membra del corpo, conferendo loro diverse funzioni e potenzialità. Allo stesso modo, la “bontate” di Dio si moltiplica attraverso le stelle (i cieli), ma si differenzia in virtù diverse.
E come l’ alma dentro a vostra polve Per differenti membre, e conformate À diverse potenzie, si risolve; Così l’ intelligenzia sua bontate Multiplieata per le stelle spiega, Girando sè sopra sua unitate. (vv. 133-138)
- Virtù e Splendore: La diversa virtù infusa in ogni corpo celeste si lega alla sua materia, proprio come la vita si lega al corpo. È questa “virtù mista” che causa la diversa luminosità delle stelle e dei cieli, non la loro densità o rarità. È un “principio formale” che produce il “turbo” (scuro) e il “chiaro” (luminoso).
Virtù diversa fa diversa lega Col prezioso corpo ch’ ella avviva, Nel qual, sì come vita in lui, si lega. Per la natura lieta unde deriva, La virtù mista per lo corpo luce, Come letizia per pupilla viva. Da essa vien ciò che da luce a luce Par differente, non da denso e raro: Essa è formal principio, che produce, Conforme a sua bontà, lo turbo e ’l chiaro. (vv. 139-148)
Angeli e sfere celesti che irradiano luce, simbolo della virtù divina che anima i cieli.
Conclusione
Il Canto II del Paradiso è un capolavoro di didattica poetica. Attraverso il dibattito sulle macchie lunari, Dante non solo espone e confuta le teorie scientifiche del suo tempo, ma soprattutto offre una profonda lezione sulla gerarchia celeste e sul modo in cui la virtù divina si manifesta nel creato, differenziandosi attraverso i diversi cieli grazie all’opera delle intelligenze angeliche. Il canto celebra la luce della conoscenza e la capacità della ragione umana, guidata dalla fede (Beatrice), di elevarsi alla comprensione dei misteri divini, aprendo la strada alle visioni sempre più sublimi del Paradiso.
Testo integrale del Canto secondo del Paradiso di Dante
Canto secondo
C A N T O II.
___________
O voi, che siete in piccioletta barca,
Desiderosi d’ ascoltar, seguiti
Dietro al mio legno che cantando varca,
4Tornate a riveder li vostri liti:
Non vi mettete in pelago, che forse,
Perdendo me, rimarreste smarriti.
7L’ acqua ch’ io prendo, già mai non si corse:
Minerva spira, e conducemi Appollo,
E nove Muse mi dimostran l’ Orse.
10Voi altri poghi, che drizzaste ‘l collo
Per tempo al pan de li Agnoli, del quale
Vivesi qui; ma non si vien satollo,
13Metter potete ben per l’alto sale
Vostro navilio, servando mio solco
Dinanzi a l’ acqua che ritorni equale.
16Quei gloriosi, che passaro a Colco
Non s’ammiraron, come voi farete,
Quando Iason vidder fatto bifolco.
19La concreata e perpetua sete
Del deiforme regno cen portava
Veloci, quasi come ’l Ciel vedete.
22Beatrice in suso, et io in lei guardava;
E forsi ’n tanto, ’n quanto un quadrel posa,
E vola, e da la noce si dischiava,
25Iunto mi viddi, ove mirabil cosa
Mi torse ’l viso a sè; e però quella,
Cui non potea mi’ opra essere ascosa,
28Volta ver me sì lieta come bella:
Drizza la mente in Dio grata, mi disse,
Che n’ à coniunti colla prima stella.
31Parevami che nube ne cuoprisse
Lucida, spessa, solida e polita,
Quasi adamante in che lo Sol ferisse.
34Per entro sè l’ eterna margarita
Ne ricevette, come acqua ricepe
Raggio di luce, permanendo unita.
37S’ io era corpo, e qui non si concepe,
Come una dimension altra patio,
Che esser convien se corpo in corpo repe,
40Accender ne dovria più il disio
Di veder quella essenzia, in che si vede
Come nostra natura a Dio s’ unio.
43Lì si vedrà ciò che tenem per fede,
Non dimostrato; ma fia per sè noto
A guisa del ver primo che l’om vede.
46Io rispuosi: Madonna, sì divoto,
Com’ esser posso più, ringrazio Lui,
Lo qual dal mortal mondo m’ à rimoto.
49Ma ditemi, che son li segni bui
Di questo corpo, che là giù in terra
Fan di Cain favoleggiar altrui?
52Ella sorrise alquanto, e poi: S’ ell’ erra
L’ opinion, mi disse, dei mortali,
Dove chiave di senso non disserra,
55Certo non ti dovrien punger li strali
D’ ammirazion omai: dirieto a’ sensi
Vedi che la ragione à corte l’ ali.
58Ma dimmi quel che tu da te ne pensi.
Et io: Ciò che n’ appar quassù diverso,
Credo che ’l fanno i corpi rari e densi.
61Ed ella: Certo assai vedrai sommerso
Nel falso il creder tuo, se bene ascolti
L’ argomentar ch’ io li farò avverso.
64La spera ottava vi dimostra molti
Lumi, li quali nel quale e nel quanto
Notar si posson per diversi volti.
67Se raro e denso ciò facesser tanto,
Una sola virtù serebbe in tutti
Più e men distributa, et altrettanto.
70Virtù diverse esser convegnon frutti
Dei princìpi formali; e quei, fuor ch’ uno,
Seguitereno a tua ragion destrutti.
73Ancor se raro fusse di quel bruno
Cagion che tu dimandi, od oltre in parte
Fora di sua materia sì digiuno
76Esto Pianeto; o sì come comparte
Lo grasso e ’l magro un corpo, così questo
Nel suo volume cangerebbe carte.
79Se ’l primo fusse, fora manifesto
Nell’eclissi del Sol, per trasparere
Lo lume, come in altro raro ingesto.
82Questo non è; però è da vedere
Dell’ altro: e s’ elli avvien ch’ io l’ altro cassi,
Falsificato fia lo tuo parere.
85S’ elli è che questo raro non trapassi,
Esser conviene un termine, da onde
Lo suo contrario più passar non lassi:
88Et indi l’ altrui raggio si rifonde
Così, come color torna per vetro,
Lo qual dirieto a sè piombo nasconde.
91Or dirai tu, che si dimostra tetro
Ivi lo raggio più che ’n altre parti,
Per esser lì rifratto più a retro.
94Da questa istanzia può deliberarti
Esperienzia, se già mai la provi.
Che esser suol fonte ai rivi di nostre arti.
97Tre specchi prenderai, e i du’ rimovi
Da te d’ un modo, e l’ altro più rimosso
Tr’ ambo li primi li occhi tuoi ritrovi
100Rivolti ad esso; e fa che di po’l dosso
Ti stia un lume che i tre specchi accenda,
E torni a te da tutti ripercosso:
103Benchè nel quanto tanto non si stenda
La vista più lontana, lì vedrai
Come convien ch’ equalmentc risplenda.
106Or come ai colpi de li caldi rai
De la nieve riman nudo ’l subietto,
E dal colore, e dal freddo primai;
109Così rimaso te nello intelletto
Vollio informar di luce sì vivace,
Che ti tremolerà nel suo aspetto.
112Dentro dal Ciel de la divina pace
Si gira un corpo, ne la cui virtute
L’ esser di tutto suo contento iace.
115Lo Ciel sequente, ch’ à tante vedute,
Quell’ esser parte per diverse essenzie
Da lui distinte, e da lui contenute.
118Li altri giron per varie differenzie
Le distinzion, che dentro da sè ànno,
Dispongon al lor fine lor semenzie.
121Questi organi del mondo così vanno,
Come tu vedi omai, di grado in grado:
Chè di su prendono, e di sotto fanno.
124Riguarda ben omai sì come io vado
Per esto loco al ver che tu disiri,
Sì che poi sappi sol tener lo guado.
127Lo moto e la virtù dei santi giri,
Come dal fabbro l’ arte del martello,
Da’ beati motor convien che spiri.
130Lo Ciel, cui tanti lumi fanno bello,
Dalla mente profonda che lui volve,
Prende l’ image, e fassene suggello.
133E come l’ alma dentro a vostra polve
Per differenti membre, e conformate
À diverse potenzie, si risolve;
136Così l’ intelligenzia sua bontate
Multiplieata per le stelle spiega,
Girando sè sopra sua unitate.
139Virtù diversa fa diversa lega
Col prezioso corpo ch’ ella avviva,
Nel qual, sì come vita in lui, si lega.
142Per la natura lieta unde deriva,
La virtù mista per lo corpo luce,
Come letizia per pupilla viva.
145Da essa vien ciò che da luce a luce
Par differente, non da denso e raro:
Essa è formal principio, che produce,
148Conforme a sua bontà, lo turbo e ’l chiaro.




