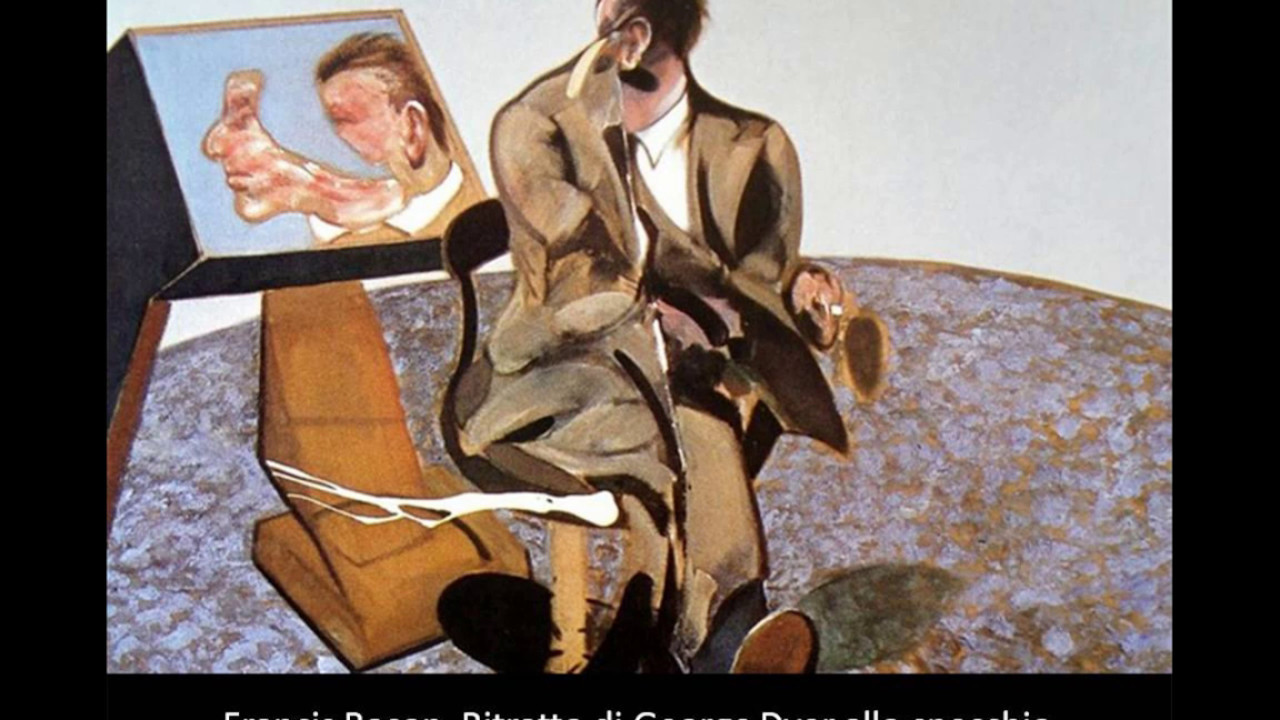Strumenti di aggregazione scolastica: il ruolo delle magliette personalizzate nei …
16 Giugno 2025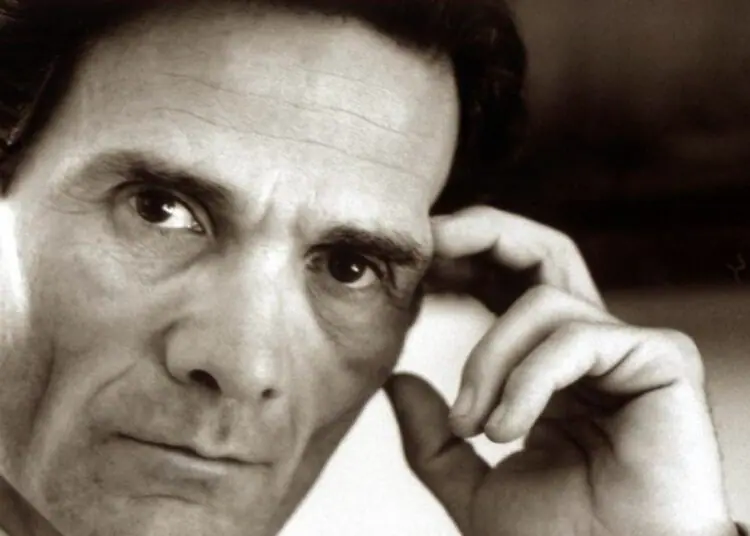
“Mi ritrovo in questa stanza” di Pier Paolo Pasolini
18 Giugno 2025📚 Traccia e svolgimento di un tema di attualità sulla indignazione sociale

TRACCIA
Sessione ordinaria 2025 Prima prova scritta – Ministero dell’Istruzione e del Merito ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PROVA DI ITALIANO
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C2
Testo tratto da: Anna Meldolesi e Chiara Lalli, L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa? , in 7-Sette – supplemento settimanale del Corriere della Sera , 13 dicembre 2024, pag. 12.
L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?
Una nuova ricerca, pubblicata su Science , dimostra che questa reazione emotiva accompagna spesso contenuti discutibili e che chi si scandalizza davanti a una presunta ingiustizia non perde tempo a cliccare sui link, per approfondire e verificare. Così, visto che la mente umana può esprimere giornalmente solo un tot di rabbioso disgusto, finiamo per sprecarlo su questioni irrilevanti per ignorare invece i temi che davvero meriterebbero la nostra irritazione.
Traccia della produzione scritta
A partire dai contenuti del testo proposto, traendo spunto dalle tue esperienze, dalle tue conoscenze e dalle tue letture, rifletti su questa rilevante caratteristica dei social.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano–lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.

SVOLGIMENTO
L’Indignazione Sociale: Un Motore Potente ma Spesso Fuorviante
Il testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli, “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?”, solleva una questione cruciale sul funzionamento delle piattaforme digitali e sull’efficacia delle emozioni che le animano. La ricerca citata su Science rivela un paradosso inquietante: la nostra capacità di indignarci, pur essendo limitata, viene spesso sprecata su questioni irrilevanti, a discapito di temi che meriterebbero un’attenzione ben più profonda. Questo aspetto, a partire dalle mie esperienze come utente e osservatore dei social media, richiede una riflessione attenta sulla loro vera natura e sul loro impatto sulla sfera pubblica.
Il Meccanismo dell’Indignazione Digitale
La prima, innegabile verità è che l’indignazione è un propellente straordinario per i social network. Un post che susciti scandalo, rabbia o disgusto ha una viralità intrinseca: viene condiviso, commentato, rilanciato con una velocità che pochi altri tipi di contenuto possono raggiungere. Questo meccanismo si basa sulla nostra reazione emotiva, spesso più immediata e meno filtrata della ragione. Si crea un effetto eco, in cui l’indignazione di uno amplifica quella di un altro, generando ondate di condanna collettiva che possono raggiungere milioni di persone in pochi minuti.
La tendenza a indignarsi per “presunte ingiustizie”, come sottolineano Meldolesi e Lalli, è una dinamica che osservo costantemente. Molto spesso, il primo impulso è quello di reagire emotivamente a un titolo sensazionalistico o a una breve didascalia, senza avvertire la necessità di approfondire e verificare le informazioni. Il “clic sui link” per leggere l’articolo completo o per cercare fonti diverse diventa un’azione superflua, quasi un intralcio alla scarica adrenalinica dell’indignazione. Questa superficialità, alimentata dalla rapidità con cui scorrono i feed, contribuisce a creare un ambiente in cui la reazione impulsiva prevale sulla riflessione critica.
La Consumabilità dell’Indignazione e le Sue Conseguenze
La ricerca evidenzia un punto cruciale: la nostra mente può esprimere solo una quantità limitata di “rabbioso disgusto”. È come se avessimo un “serbatoio” di indignazione giornaliera. Se lo esauriamo su questioni futili o manipolate, finiamo per non avere più energie emotive per affrontare i problemi reali e urgenti. Questa “consumabilità” dell’indignazione porta a una sorta di fatica da compassione o stanchezza emotiva, in cui la reiterazione di stimoli negativi e spesso irrilevanti ci rende apatici di fronte a ciò che meriterebbe una vera mobilitazione.
Le conseguenze di questo fenomeno sono molteplici. A livello individuale, si rischia di vivere in un perenne stato di irritazione superficiale, anziché canalizzare le proprie energie verso un impegno concreto. A livello sociale, l’attenzione pubblica si disperde su argomenti effimeri, distogliendo le risorse mentali e dibattimentali dai veri nodi cruciali. Penso, ad esempio, a come dibattiti complessi su temi come il cambiamento climatico, le disuguaglianze sociali o le crisi internazionali vengano spesso sovrastati da polemiche sterili o da casi mediatici montati ad arte, che si esauriscono nel giro di poche ore.
Questa dinamica rende i social media non solo un motore di informazione, ma anche un potente strumento di distrazione di massa. L’indignazione, invece di essere una molla per il cambiamento positivo, si trasforma in un circolo vizioso di reattività superficiale che, in ultima analisi, può servire a mantenere lo status quo, piuttosto che a scuoterlo.
Possibili Contromisure e la Via della Consapevolezza
Di fronte a questa caratteristica dei social media, è fondamentale sviluppare una maggiore consapevolezza critica. Le mie esperienze di studio e le mie letture mi portano a credere che la soluzione non sia abbandonare i social, ma imparare a usarli in modo più responsabile e riflessivo.
Un primo passo è la verifica delle fonti. Prima di indignarsi o condividere, è essenziale dedicare qualche istante a controllare la veridicità delle informazioni e la reputazione di chi le diffonde. Questo implica un impegno attivo nella media literacy e nel riconoscimento delle fake news.
Un secondo aspetto è la gestione emotiva. Sviluppare la capacità di non reagire impulsivamente a ogni stimolo, ma di fare un passo indietro e valutare se un determinato contenuto meriti davvero la nostra indignazione e il nostro tempo, è cruciale. Questo non significa diventare indifferenti, ma discriminanti.
Infine, è importante canalizzare l’indignazione in azioni concrete. Se un tema ci tocca profondamente, l’obiettivo non dovrebbe essere solo sfogare la rabbia online, ma cercare modi per contribuire attivamente al cambiamento: informarsi ulteriormente, partecipare a iniziative locali, sostenere organizzazioni che lavorano su quel tema, o semplicemente iniziare un dialogo costruttivo offline.
In conclusione, l’indignazione sui social media è un’arma a doppio taglio. Ha il potenziale per mobilitare e sensibilizzare, ma se non gestita con consapevolezza, rischia di trasformarsi in un rumore di fondo inefficace, sprecando energie preziose e distogliendoci dalle vere sfide che richiedono la nostra attenzione. La vera utilità dell’indignazione, anche nel mondo digitale, sta nel trasformarla da reazione impulsiva a motore di un cambiamento informato e duraturo.