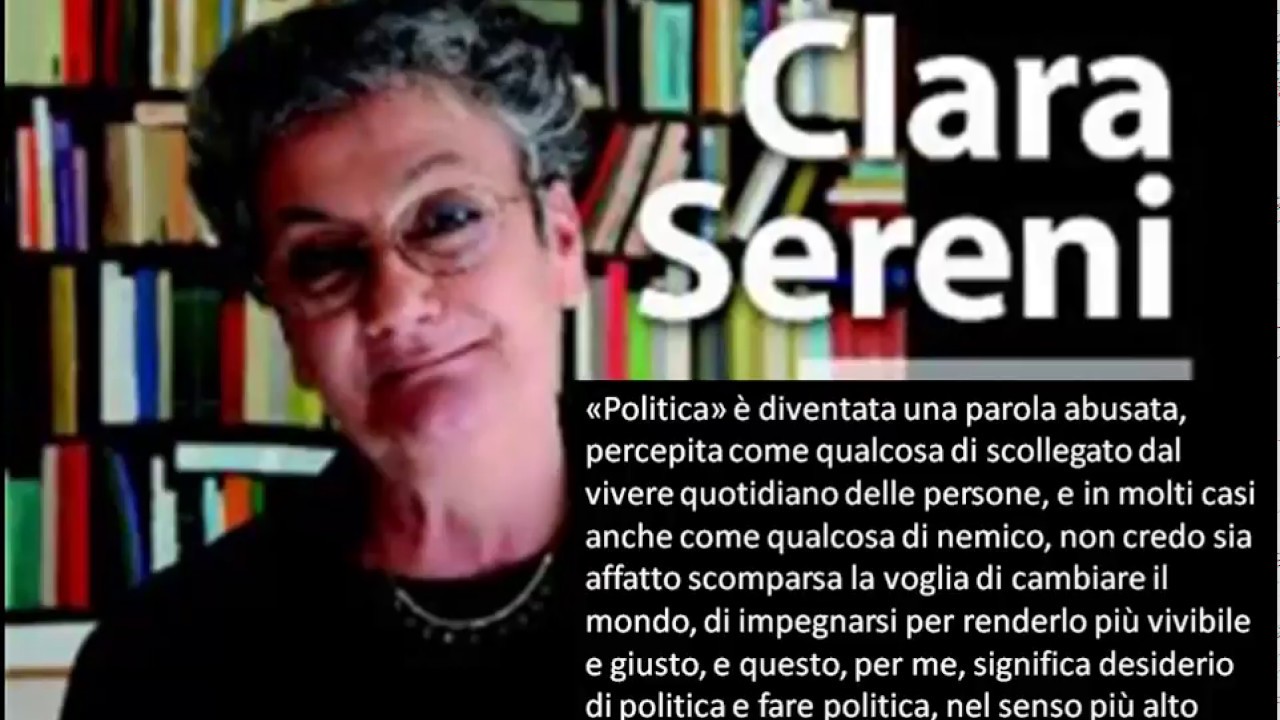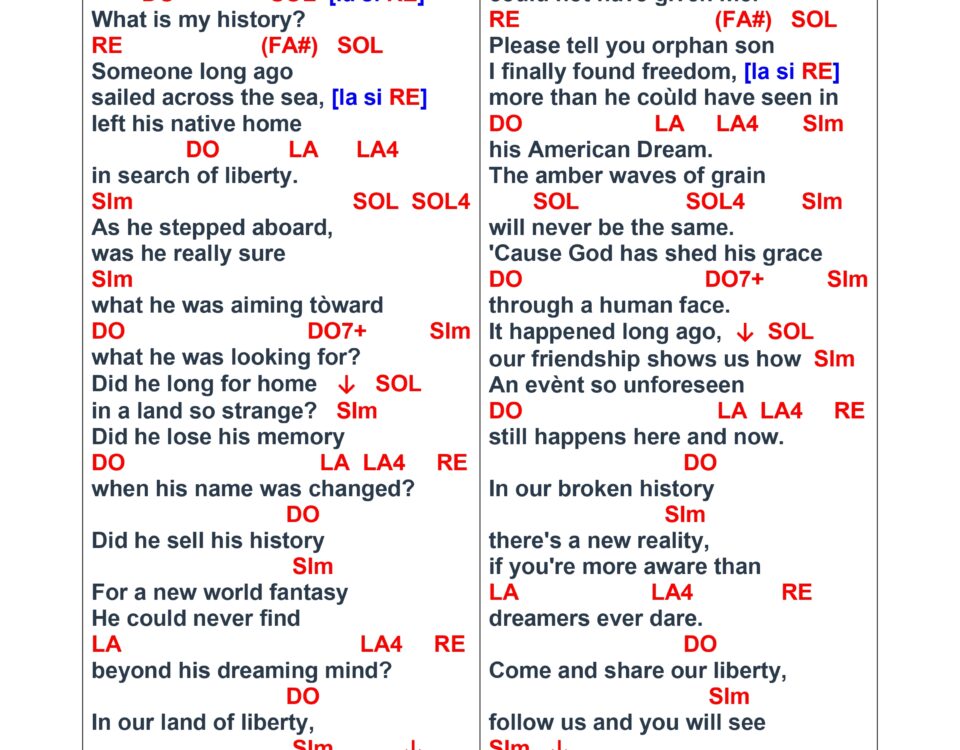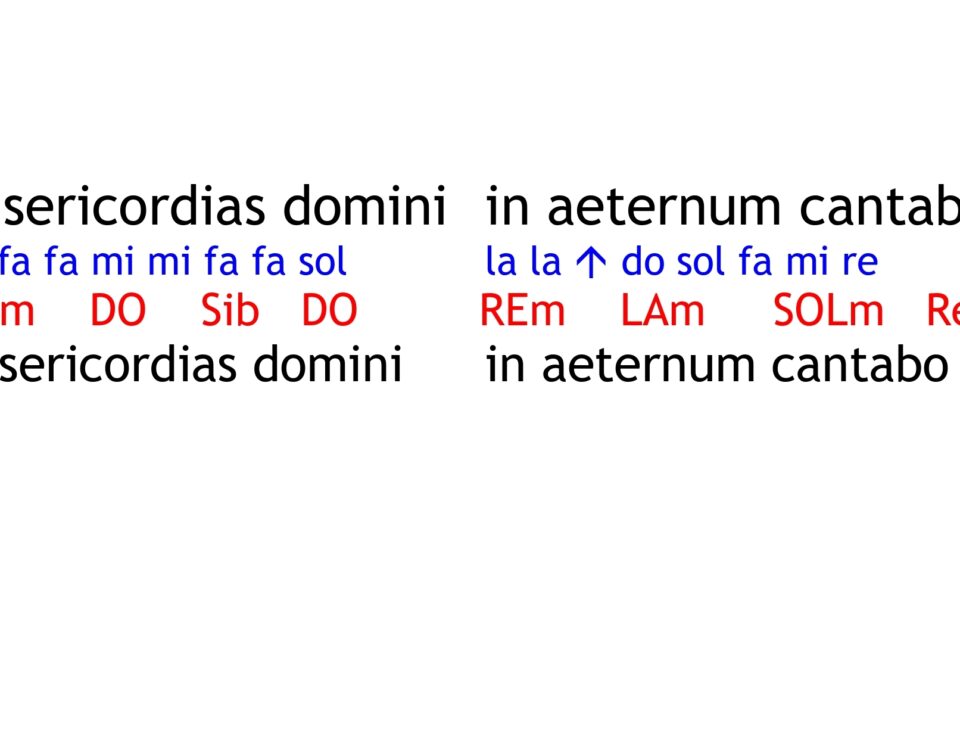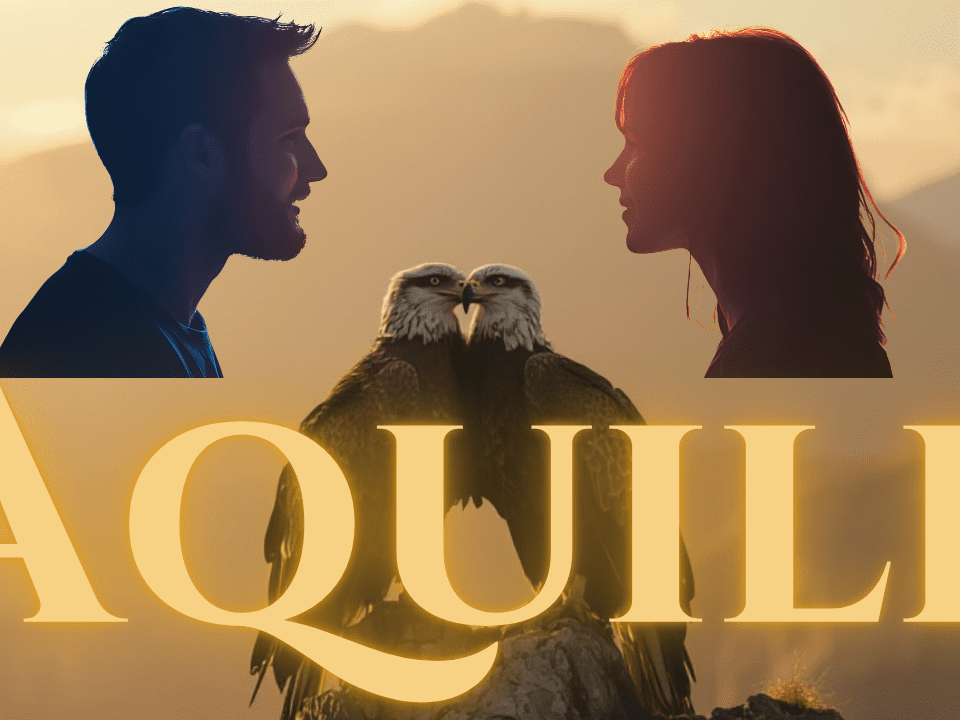Ragazzo padre di Enzo Jannacci
28 Dicembre 2019
Aggettivi e Pronomi Possessivi
28 Dicembre 2019Atrazina è un racconto intenso e commovente tratto dalla raccolta Eppure (1995) di Clara Sereni, autrice italiana nota per la sua scrittura lucida e introspettiva che esplora temi sociali, relazioni e identità femminili.
Analisi del testo
1. Trama e temi principali
Il racconto narra la vita di una donna che, dopo un incidente in fabbrica, si trova a prendersi cura del marito, rimasto psicologicamente distrutto. La loro esistenza, un tempo ordinata e piena di piccole gioie domestiche, si trasforma in una lotta quotidiana contro la follia e l’isolamento.
- L’amore e la dedizione: La protagonista sacrifica tutto per il marito, trasformando la casa in un rifugio perfetto, quasi un tentativo di ripristinare un ordine perduto.
- La follia e il dolore: L’incidente spezza l’equilibrio della coppia. Il marito vive in un limbo, continuando a fingere di andare al lavoro, mentre la donna cerca disperatamente di mantenere un senso di normalità.
- La pulizia come ossessione e salvezza: Il rituale maniacale della pulizia diventa una metafora del suo bisogno di controllo in un mondo che le sfugge.
- La solitudine e la disperazione: L’atrazina (un erbicida tossico nell’acqua) diventa il simbolo di un male invisibile che corrode ogni certezza, portandola a una decisione estrema.
2. Stile e simbolismo
- Realismo e poesia: Sereni unisce una narrazione precisa e concreta a momenti di lirismo, come quando descrive la lucentezza degli oggetti o il vuoto negli occhi del marito.
- La casa come metafora: Rappresenta l’identità della donna, il suo amore, ma anche una prigione.
- L’atrazina: Simboleggia il male che penetra silenziosamente, distruggendo ogni illusione di purezza e ordine.
3. Conclusione tragica
L’epilogo è straziante: la donna, ormai stanca e senza speranza, convince il marito a portarla con sé in fabbrica, in un gesto che suggerisce un suicidio o una fuga definitiva dalla realtà.
Perché è un grande racconto?
Clara Sereni riesce a raccontare con delicatezza e forza il dramma di chi si prende cura di una persona malata, il crollo delle certezze e la resistenza quotidiana. La scrittura è essenziale ma carica di emozione, rendendo universale una storia personale.
Un testo che fa riflettere sull’amore, la follia e il limite tra ordine e caos.
📘Testo del racconto “Atrazina“ da Eppure” (1995) di Clara Sereni.
Con il suo lavoro da giovane aveva girato molto: tante case ricche o almeno agiate, anche all’estero. Intellettuali e ambasciatori, nobildonne lievemente decadute, cantanti, attori: da tutti aveva imparato qualcosa, per quella capacità che aveva di succhiare cultura — buon gusto, eleganza, informazioni — dovunque ne intuisse una minima traccia. Poi il matrimonio d’amore, il marito l’aveva voluta tutta per sé e anche a lei sembrava di avere imparato abbastanza. Così tutte le sue abilità di cameriera rifinita (e anche cuoca, guardarobiera, governante), l’amore per la bellezza e il piacere dell’armonia li aveva convogliati nella casa, una casa a disposizione da abbellire, strofinare, lustrare. Come uno specchio. La pulizia era per lei una passione vera, profonda. I ripiani lucidi dei mobili a guardarli le davano ogni volta una sorta di ebbrezza; e così l’acciaio dei rubinetti, il candore della biancheria, il nitore di lampadari e finestre.
In casa lui si muoveva con circospezione affettuosa, attento a non guastare la fatica di lei. Nei giorni di festa rinnovava e aggiustava, stuccava e puliva: insieme studiavano cataloghi e vetrine, insieme immaginavano abbellimenti e migliorie. Quando erano stanchi, alla fine delle giornate, il grande letto intagliato da lui era lucido, le lenzuola ben tese: i capelli di lei si allargavano sui cuscini sprimacciati, e ancora c’era la voglia di parole, di progetti, di invenzioni. Non ebbero figli, perciò lo stipendio da operaio specializzato bastava, perfino per qualche lusso: i fiori freschi sul tavolo, il divano di velluto, il servizio da caffè in silver-plated. Gli abiti sobri per lui quando uscivano, per lei le scarpe assortite alla borsetta.
Decoro e dignità, pulizia e precisione, il lavoro ben fatto. Era il modo che avevano per dare ordine al mondo insieme, controllarlo, adattarvisi: senza illusioni, con determinazione. E con speranza. (Per lui poi c’era anche la politica: lei se ne teneva lontana, quel che aveva lo considerava sufficiente.) Un’esistenza piena. Fino all’incidente. Cinque suoi compagni di lavoro ci lasciarono la vita, lui ci lasciò l’anima: rimase «giù di mente», come disse il medico che glielo riconsegnò.
Capì subito che poteva soltanto rassegnarsi: gli occhi di lui erano vuoti, senza luce, forse senza nemmeno dolore. Doverglisi dedicare completamente non la stupì, in fondo si era costruita in quel mondo, tuttofare significa anche infermiera e balia asciutta, fatica da sopportare e isolamento. Fiori non poteva più comprarne, mise un geranio alla finestra. Accese più spesso la radio, per coprire i silenzi e per tenersi al corrente. Non era pericoloso, né violento. Parlare parlava poco e solo della fabbrica: come se ancora ci andasse ogni giorno. Infatti tutte le sere caricava la sveglia, e ogni mattina a quell’ora usciva di casa con la tuta, il berretto, i panini che lei gli preparava. Tornava al tramonto unto nelle mani, nel viso, nella canottiera perfino. Senza recriminare lei lo aiutava a fare il bagno, a tornare pulito.
Chissà dove andava a sporcarsi così. Provò a chiederglielo, lui si alterò: decise di lasciargli la libertà di quel segreto, l’ultima cosa tutta sua che gli fosse rimasta. Fece le pratiche necessarie, ebbe la pensione di invalidità e la fece bastare. La vita in casa non era tanto diversa da prima: però il dolore le marciva dentro (la contiguità con la follia mette in dubbio ogni normalità, frequentando l’assurdo tutto si smargina e scolorisce), tante volte di fronte alle certezze residue di lui si trovava a pensare se non era alla fin fine tutto vero, se non era lei a sbagliarsi e confondere. Poi lui poggiava la mano sporca sulla tovaglia di bucato, senza attenzione, o lasciava che i listelli del parquet si scollassero, uno dopo l’altro: pulendo e riassestando si convinceva di se stessa, quando le mani inutili di lui lo confermavano diverso.
Cercò aiuti, ebbe assistenti sociali e operatori psichiatrici ma non servirono, il marito alle facce nuove si spaventava e diventava come un bambino, con lei soltanto riusciva a tratti a ritrovarsi uomo. Quando le dissero di rifarsi una vita li mandò via, tutti, chiuse la porta dietro di loro e cercò altre parole. Le donne che incontrava al mercato, cariche di spesa e di risentimenti, erano frettolose, evasive; perciò parlò di detersivi, di metodi straordinari di lustrare il rame, del sapone di Marsiglia che non è più quello di una volta: condivise la sua scienza e un po’ della sua storia, le fu riconosciuta un’autorità, si puntellò con quella.
Si diede delle abitudini, dei piccoli obiettivi: un cibo che gli piaceva per carpirgli un sorriso, una passeggiata insieme per essere ancora coppia. Al futuro evitava di pensare, il presente la teneva occupata a sufficienza. Erano difficili i fine-settimana, quando le fabbriche sono chiuse e lui restava in casa: allora si agitava, metteva in disordine biancheria e stoviglie, le cose gli cadevano di mano e si rompevano, ci restava male, a volte piangeva e a lei toccava consolarlo.
Quando lui sfasciò il ferro da stiro lei si improvvisò elettricista, divenne imbianchino per cancellare le manate dai muri, in ginocchio sul pavimento strofinava via le impronte di fango e la polvere dagli angoli. Con l’idea che quella loro casa – la pulizia, l’ordine, la precisione del lustro, del candido, dell’immacolato, dell’integro — fosse per tutti e due come un guscio d’uovo, il contenitore che solo poteva tenere insieme il bianco e il grigio della loro vita. Togliere le macchie la rassicurava, pulirgli il nero dalle mani la confortava: nudo e lavato davanti a lei sullo stuoino del bagno, la pelle arrossata dagli strofinii, i capelli lucidi d’acqua, le pareva ancora intatto. Salvarlo ogni giorno, togliere via con la sporcizia il male. Lucidare, rammendare, candeggiare, spolverare, pulire, risciacquare: le sue giornate trascorrevano così, e avevano uno scopo.
Una domenica stava lavando i piatti, nella catinella di plastica con la cura di sempre. Il marito era ancora in pigiama, alla radio dissero dell’atrazina: un veleno subdolo, incolore, invisibile, micidiale stava scorrendo anche dal suo rubinetto. Guardò i piatti, brillavano: cosa vuol dire sporco, cosa significa pulito, le braccia le si arresero lungo i fianchi. Chiuse l’acqua, si asciugò le mani, le guardò: sciupate, inutili, ormai senza rimedio. Serrò porte e finestre, controllò che tutto fosse in ordine. Tenne l’abito da fatica, aiutò il marito a indossare la tuta.
Consapevole del giorno di festa lui protestava, pacata e convincente gli spiegò di straordinari e commesse urgenti così si lasciò persuadere, si sentì indispensabile ed ebbe un guizzo nello sguardo prima di perdersi di nuovo. Lo guardò negli occhi opachi, attirò il suo viso verso di sé perché la vedesse, la ascoltasse, la capisse. Con dolcezza, amorosa e disperata, gli impose: «Non lasciarmi più sola, portami con te. In fabbrica.»