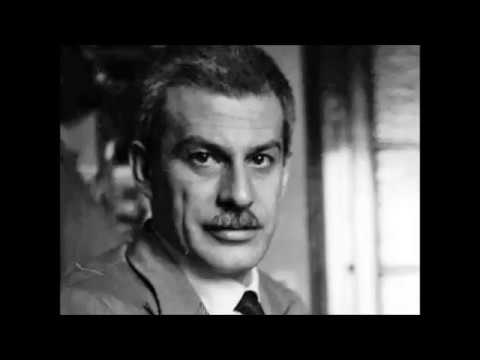Chissà come si divertivano di Isaac Asimov
21 Agosto 2015
Don Peppino Diana da Gomorra di Saviano
21 Agosto 2015Traccia e svolgimento di una analisi di un testo di Elio Vittorini tratto da Conversazione in Sicilia
Intorno al 1937 Vittorini incomincia a scrivere il romanzo Conversazione in Sicilia, che uscirà poi nel 1941. Leggi il seguente brano, che rappresenta l’incipit di quel romanzo, e rispondi alle domande poste in fondo.
“Io ero, quell’inverno[1], in preda ad astratti furori. Non dirò quali, non di questo mi son messo a raccontare. Ma bisogna dica ch’erano astratti, non eroici, non vivi; furori, in qualche modo, per il genere umano perduto. Da molto tempo questo, ed ero col capo chino. Vedevo manifesti di giornali squillanti e chinavo il capo; vedevo amici, per un’ora, due ore, e stavo con loro senza dire una parola, chinavo il capo; e avevo una ragazza o moglie che mi aspettava ma neanche con lei dicevo una parola, anche con lei chinavo il capo. Pioveva intanto e passavano i giorni, i mesi, e io avevo le scarpe rotte, l’acqua che mi entrava nelle scarpe, e non vi era più altro che questo: pioggia, massacri sui manifesti dei giornali, e acqua nelle mie scarpe rotte, muti amici, la vita in me come un sordo sogno, e non speranza, quiete. Questo era il terribile: la quiete nella non speranza. Credere il genere umano perduto e non aver febbre di fare qualcosa in contrario, voglia di perdermi, ad esempio, con lui.” Ero agitato da astratti furori, non nel sangue, ed ero quieto, non avevo voglia di nulla. Non mi importava che la mia ragazza mi aspettasse; raggiungerla o no, o sfogliare un dizionario era per me lo stesso; e uscire a vedere gli amici, gli altri, o restare in casa era per me lo stesso. Ero quieto; ero come se non avessi mai avuto un giorno di vita, né mai saputo cosa significa esser felici, come se non avessi nulla da dire, da affermare, negare, nulla di mio da mettere in gioco, e nulla da ascoltare, da dare e nessuna disposizione a ricevere, e come se mai in tutti i miei anni di esistenza avessi mangiato pane, bevuto vino, o bevuto caffé, mai stato a letto con una ragazza, mai avuto dei figli, mai preso a pugni qualcuno, o non credessi tutto questo possibile, come se mai avessi avuto un’infanzia in Sicilia tra i fichidindia e lo zolfo, nelle montagne; ma mi agitavo entro di me per astratti furori, e pensavo il genere umano perduto, chinavo il capo, e pioveva, non dicevo una parola agli amici, e l’acqua mi entrava nelle scarpe.”
Nei capitoli successivi inizia il viaggio in treno di Silvestro, il quale incontra un personaggio, chiamato Gran Lombardo, in realtà un siciliano, chiamato così per antiche origini normanne, che condensa in poche parole le tensioni dell’epoca:
“Credo che l’uomo sia maturo per altro, – disse[2] – Non soltanto per non rubare, non uccidere, eccetera, e per essere buon cittadino… Credo che sia maturo per altro, per nuovi, per altri doveri. È questo che si sente, io credo, la mancanza di altri doveri, altre cose, da compiere… Cose da fare per la nostra coscienza in un senso nuovo.”
Domande:
- Quali sono gli astratti furori di cui parla Silvestro all’inizio del libro?
- Perché i “furori” non sono “eroici”?
- A cosa fa riferimento l’espressione “manifesti di giornali squillanti”?
- Perché nel primo brano ci sono molte ripetizioni?
- Spiega il significato della seguente espressione “la vita in me come un sordo sogno”
- Spiega il significato del testo da “Ero agitato da astratti furori” fino alla fine del primo brano.
- Quali sono i nuovi doveri di cui parla il Gran Lombardo? Perché dice che sono “nuovi”? A quali “vecchi” doveri si contrappongono?
- Perché questo testo è considerato attuale, anche se risulta fortemente condizionato dal clima culturale nel quale è stato elaborato?
- Trova agganci con altre opere di Vittorini o di altri autori, non necessariamente del suo tempo.
Risposte
- La parola furore indica etimologicamente una rabbia, che risulta compressa, astratta, perché non può essere espressa in un periodo come quello in cui è stato scritto il romanzo, in quanto il regime reprimeva chiunque esprimesse posizioni chiare di dissenso. Tutto questo genera nel protagonista un senso di inutilità, di passività, che investe anche le parti più vitali dell’esistenza, come il rapporto con la donna. Il silenzio, la quiete, la pioggia martellante, rendono la triste consapevolezza dell’impossibilità di ribellarsi alla dittatura.
- Perché Silvestro non ha il coraggio di ribellarsi al regime, alla situazione di appiattimento in cui vive. Giordano Bruno ha scritto un libro “Degli eroici furori”, ma Giordano Bruno, significativamente, è andato incontro alla morte per aver affermato le sue idee fino alla fine, rischio che, per il momento, Silvestro non è disposto a correre, preferendo l’inattività ad un gesto di rivolta destinato alla repressione.
- Si allude qui alla propaganda martellante della stampa di regime nel periodo della guerra civile in Spagna. Dall’Italia fascista furono spediti contingenti militari in appoggio alle milizie franchiste. Lo stesso fratello del protagonista, apparso in sogno verso la fine del romanzo, ha perso la vita nel corso di questa guerra. La retorica mostra qui tutta l’assurdità, nella mesta consapevolezza che il fratello ha dato la vita per un motivo assurdo e ideologico.
- Da notare in particolar modo sono le negazioni che si ripetono in tutto il brano. Soprattutto l’avverbio “non”, in “non dirò quali”, “non di questo”, “non vi era più altro”, “non speranza”, “non aver febbre”, “non mi importava”. Ci sono comunque altre espressioni ricorrenti di carattere negativo, come “senza”, “neanche”, “nulla”, ecc… Tutto questo, insieme con la pioggia martellante, che aumenta il senso di monotonia e di ossessione, e soprattutto l’espressione “non speranza”, alludono all’impossibilità di agire nella quale si trova Silvestro, alter-ego dello stesso autore, di fronte ad una situazione che appare senza via d’uscita, che non è solo, come vorrebbe far capire l’autore ai censori fascisti, dovuta ad un’inquietudine esistenziale, ma è dovuta anche al clima oppressivo del regime. Insomma Vittorini esprime qui la sua rassegnata rinuncia a vivere, a sperare, un senso di inutilità che pervade un’intera generazione, fino a quando non diventa possibile ribellarsi, nel momento quasi magico della resistenza.
- Forse il protagonista vive la realtà come un incubo, cui non sa adattarsi, oppure la sua vita così disperata era talmente assurda, da apparire più un sogno che una esperienza reale.
- Silvestro è talmente sfiduciato che riconosce l’inutilità della cultura e della lettura (sfogliare un dizionario era per me lo stesso), l’assurdità
- I vecchi doveri sono quelli imposti dalla morale tradizionale, mentre quelli nuovi sono dovuti allo slancio di libertà e al sogno di cambiamento sociale e politico, che si realizzeranno nel corso della guerra di liberazione della resistenza, tra il 1943 e il 1945, cui Vittorini parteciperà in prima persona. Il riferimento esplicito ai comandamenti (non rubare, non uccidere) indica per contrasto che i nuovi doveri, sono, come dice appunto il Gran Lombardo, “altri”, doveri che implicano non solamente un divieto, ma un’azione per costruire qualcosa di nuovo, una società più giusta e libera, una nazione più solidale. I vecchi comandamenti, o vecchi doveri, corrono il rischio, invece, di essere una facciata conformistica, dietro la quale si nasconde il più puro egoismo e perbenismo.
- Proprio l’indeterminatezza, dovuta alla necessità di eludere la censura fascista, affranca questo libro da una pura interpretazione storica o sociologica, rendendolo uno dei più significativi per la capacità di adattarsi all’uomo di tutti i tempi, alla ricerca sempre di nuovi traguardi, anche se vive in una condizione politica più evoluta rispetto a quella dell’Italia fascista, durante la quale fu elaborato questo testo.
- L’insoddisfazione, la solitudine, la noia espresse da Vittorini all’inizio del suo romanzo hanno precedenti illustri nell’Ortis di Foscolo, nello Zibaldone di Leopardi e nei testi pirandelliani. Possono essere individuate analogie anche con i testi di altre letterature, in particolar modo il teatro dell’assurdo di Ionesco e Becket, ed alcuni romanzi o racconti brevi di Thomas Mann.
Schematizzazione della poetica di Vittorini:
- In sintonia con Pavese, Vittorini contribuì alla diffusione del Mito dell’America, pubblicando in anni di autarchia (1941), la antologia “Americana”
- Si fece innovatore della narrativa, con i suoi romanzi, da divedere fra i testi scritti ancora sotto le imposizioni del regime fascista, come Conversazione in Sicilia, ancora legati allo stile della prosa d’arte, e testi celebrativi della resistenza, come Uomini e no, proiettati nella nuova stagione culturale del neorealismo.
- Direttore della rivista Politecnico e collaboratore della casa editrice Einaudi, nel secondo dopoguerra fu portavoce delle istanze di autonomia della cultura, contro chi la voleva asservita ad un progetto politico.
[1] In realtà si viene a sapere nel corso del romanzo che si tratta dei primi mesi di dicembre, quindi non ancora vero e proprio inverno, benché di inverno si tratti da un punto di vista della totale assenza di vita e di speranza.
[2] Chi parla è il Gran Lombardo, personaggio austero, che Silvestro incontra nel corso del suo viaggio in treno verso la Sicilia. In realtà non è affatto un lombardo, ma un siciliano, chiamato così come molti di origine normanna, o comunque settentrionale, in quell’isola. Rappresenta l’anima più profonda della Sicilia, caratterizzata dallo scetticismo verso ogni forma di potere imposto dall’esterno, anche se spesso quest’anima è bloccata dall’incapacità di reazione.