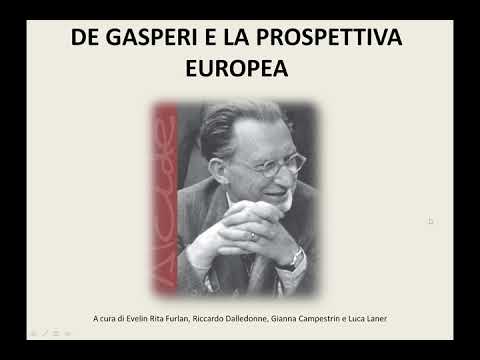
La costruzione dell’unità europea tra De Gasperi e Moro: un impegno per la pace…
28 Maggio 2025
Patria di Giovanni Pascoli
28 Maggio 2025ITALIANO Traccia ufficiale della prima prova scritta dell’Esame di Stato 2018 (Tipologia D – Tema di ordine generale – attualità)
Traccia ufficiale e il relativo svolgimento completo per la Tipologia D – Tema di ordine generale della prima prova dell’Esame di Stato 2018 .
TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE
Traccia ufficiale
Argomento:
Il principio dell’eguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione.
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano; è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 e regola ancora oggi i rapporti tra lo Stato e i cittadini. Analizza e commenta i principi enunciati nell’articolo 3, anche in relazione alla storia recente.
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»
Svolgimento – Tema di ordine generale
Titolo:
Eguaglianza formale e sostanziale: un impegno costante per una società più giusta
Introduzione
L’Articolo 3 della Costituzione italiana , approvata nel 1947 e in vigore dal 1° gennaio 1948, rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema democratico. Esso afferma con chiarezza due grandi principi: l’uguaglianza formale (tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge) e l’uguaglianza sostanziale (la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono tale uguaglianza). Questo tema analizza il significato storico e attuale di questi principi, riflettendo su come l’Italia abbia cercato di realizzarli negli anni, nonché sugli sforzi ancora necessari per garantire una reale equità tra i cittadini.
Il significato dell’Articolo 3
L’Articolo 3 della Costituzione recita:
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»
Questa disposizione segna una svolta rispetto al passato. Nella società pre-unitaria e durante il regime fascista, le differenze sociali, regionali, culturali e di genere erano fonte di discriminazioni sistematiche. La Costituzione ha invece posto le basi per un nuovo tipo di Stato: uno Stato democratico, inclusivo e solidale , che riconosce i diritti formali a tutti i cittadini e si impegna a rendere effettivi tali diritti per ciascuno.
Uguaglianza formale vs. Uguaglianza sostanziale
- Uguaglianza formale : riguarda il piano giuridico, ovvero il fatto che la legge tratti tutti allo stesso modo, indipendentemente da origine, sesso o status.
- Uguaglianza sostanziale : richiede interventi concreti per eliminare quelle disuguaglianze strutturali (economiche, culturali, geografiche) che impediscono a molti di godere realmente degli stessi diritti.
Un impegno nato dopo la guerra
La scrittura dell’Articolo 3 fu fortemente influenzata dagli orrori del conflitto mondiale e dalle ingiustizie del periodo fascista. L’Italia uscì dalla Seconda Guerra Mondiale distrutta moralmente e materialmente, con profonde divisioni sociali e regionali. I padri costituenti vollero dare vita a un documento che non solo proclamasse l’uguaglianza, ma ne garantisse la fattibilità attraverso politiche pubbliche e azioni dello Stato.
In questo senso, l’Articolo 3 non è solo una norma giuridica, ma anche un programma politico e morale: non basta dire “tutti sono uguali”, bisogna creare le condizioni affinché lo siano veramente.
Le politiche per l’uguaglianza sostanziale
Negli anni Cinquanta e Sessanta, lo Stato italiano adottò molte misure per colmare i divari esistenti:
- Riforma agraria : mirata a ridurre il gap tra Nord e Sud.
- Scuola media unica (1962) : per permettere a tutti i ragazzi di proseguire gli studi, superando le barriere di classe.
- Leggi sui diritti dei lavoratori : per garantire parità salariale e protezione sindacale.
- Piano Marshall e investimenti infrastrutturali : per ridurre il ritardo economico del Mezzogiorno.
Queste iniziative dimostrano un primo tentativo di tradurre in pratica il principio dell’uguaglianza sostanziale. Tuttavia, molte di esse incontrarono difficoltà, soprattutto per carenza di risorse e resistenze politiche.
Negli anni successivi, il dibattito si è concentrato su altre forme di discriminazione, come quelle di genere, etnia o orientamento sessuale. Ad esempio, la legge Mancino (1993), che punisce la diffusione di ideologie razziste, o le battaglie per l’accesso alla salute, all’istruzione e al lavoro per persone con disabilità o appartenenti a minoranze.
La sfida continua: la realtà contemporanea
Oggi, l’Articolo 3 rimane un obiettivo aperto. Nonostante il testo costituzionale garantisca formalmente il rispetto di ogni cittadino, molte disparità permangono:
- Disparità economiche : non tutti i cittadini hanno accesso alle stesse opportunità a causa delle condizioni familiari, del reddito o del luogo di nascita.
- Carenze nel sistema educativo : in alcune aree del Paese, la qualità dell’istruzione è inferiore, incidendo sul futuro professionale dei giovani.
- Discriminazioni moderne : razzismo, omofobia, intolleranza verso migranti e minoranze.
Anche il mercato del lavoro presenta gravi criticità: il precariato, il gender pay gap e la mancanza di sostegni per i lavoratori meno abbienti evidenziano quanto l’uguaglianza sostanziale sia ancora lontana.
Lo Stato, pur essendosi dotato di strumenti come il Reddito di Cittadinanza o il Bonus Cultura, deve fare di più per garantire che il diritto non resti solo sulla carta, ma si trasformi in opportunità concrete .
Eguaglianza e partecipazione democratica
L’ultimo comma dell’Articolo 3 pone l’accento sulla partecipazione democratica :
«[…] l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Ciò significa che la democrazia non è solo rappresentanza, ma coinvolgimento diretto di ogni individuo nella vita pubblica. Eppure, oggi assistiamo a una crescente distanza tra cittadini e istituzioni. Il rischio è che solo alcuni gruppi sociali riescano a farsi ascoltare, mentre altri – immigrati, disoccupati, giovani – rimangano emarginati.
Per colmare il divario, servono:
- Politiche attive di inclusione
- Riforme che favoriscano la mobilità sociale
- Maggiore attenzione alla formazione e alla cultura civica
Conclusione
L’Articolo 3 della Costituzione italiana rappresenta uno dei cardini della nostra democrazia. Esso non si limita a proclamare l’uguaglianza, ma la rende un dovere dello Stato: non basta trattare tutti allo stesso modo, bisogna garantire a tutti le stesse possibilità .
Dopo oltre settant’anni, il cammino è stato lungo, ma incompleto. Rimangono disuguaglianze territoriali, economiche e culturali che ci ricordano quanto sia importante non smettere di lavorare per un Paese più giusto e inclusivo.
La vera sfida per il futuro è quella di mantenere vivo lo spirito costituzionale, facendo in modo che l’uguaglianza non sia solo un valore teorico, ma un diritto reale per tutti i cittadini italiani.




