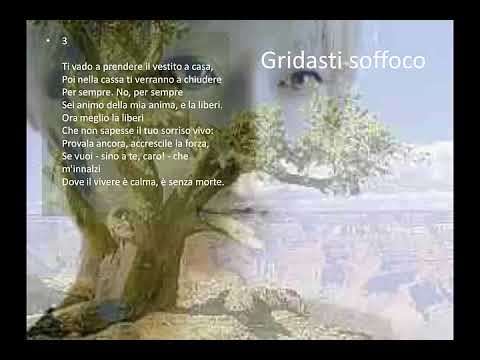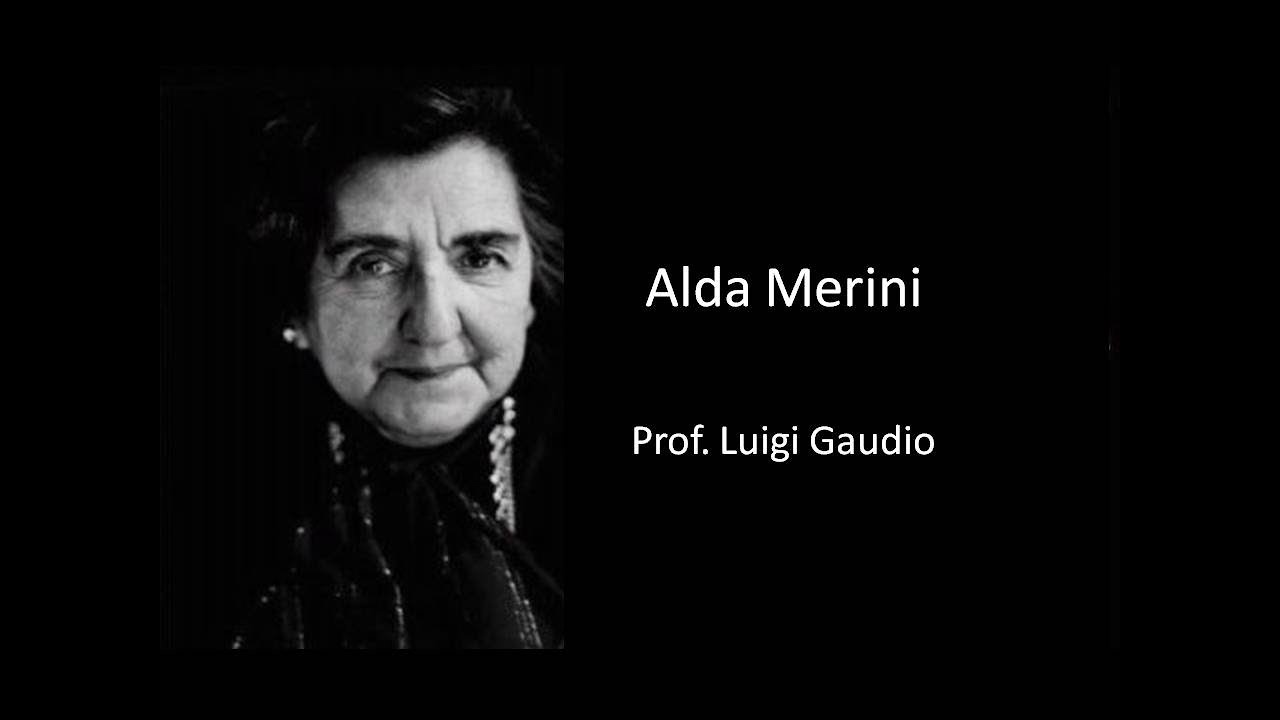
Il furto della verginità di Alda Merini
30 Luglio 2019
Danimarca: lezione di geografia
30 Luglio 2019Questa poesia di Giuseppe Ungaretti è uno dei momenti più toccanti del dolore paterno nella letteratura italiana del Novecento.
Scritta in memoria del figlio Antonietto, che è morto prematuramente a soli nove anni nel 1939 in Brasile, dove il poeta insegnava all’università, “Gridasti soffoco” trasforma l’esperienza del lutto in una profonda riflessione su tempo, memoria e sopravvivenza spirituale.
La composizione si sviluppa attorno a due movimenti principali: la rievocazione dell’agonia del bambino e la meditazione sul legame che persiste oltre la morte.
L’incipit cattura subito l’attenzione con il suo gioco tra seconda e prima persona – “Non potevi dormire, non dormivi” – creando un dialogo impossibile ma necessario tra padre e figlio.
La descrizione dell’agonia si snoda attraverso immagini di straordinaria intensità visiva. Il “viso scomparso già nel teschio” e gli “occhi che si dilatarono… si persero” trasformano l’osservazione clinica della morte in una visione poetica. Un passaggio particolarmente significativo è quando il poeta confessa di essere stato “sempre timido, ribelle, torbido; ma puro, libero, felice rinascevo nel tuo sguardo”. Questo verso mette in luce la funzione redentrice dell’amore paterno: il bambino non solo riceve amore, ma lo restituisce trasformato, purificando l’anima del padre.
L’immagine della “bocca che una volta pareva, lungo i giorni, lampo di grazia e gioia” che poi “si contorse in lotta muta” racchiude la tragedia dell’interruzione precoce della vita. La metafora del lampo è particolarmente efficace: evoca sia la brevità che l’intensità luminosa dell’esistenza del bambino.
Il cuore del poema si concentra sul concetto del “chiuso cerchio” dei nove anni. Ungaretti qui presenta una visione del tempo che è completamente diversa da quella cronologica: “nove anni cui né giorni, né minuti mai più s’aggiungeranno: in essi s’alimenta l’unico fuoco della mia speranza”. Questo tempo chiuso, paradossalmente, si apre alla rivisitazione dei ricordi: “Posso cercarti, posso ritrovarti, posso andare, continuamente vado a rivederti crescere da un punto all’altro dei tuoi nove anni”.
La parte dedicata alle mani crea una progressione temporale e tattile di grande impatto. Si passa dalle “mani di pargolo che afferrano le mie senza conoscerle” alle “mani che si fanno sensibili, sempre più consapevoli”, fino a giungere alle “mani che diventano secche e, sole – pallidissime – sole nell’ombra sostano”. Questa evoluzione dalle mani inconsapevoli del bambino a quelle che “sostano” nell’ombra della morte delinea un percorso esistenziale completo, racchiuso in pochi versi.
Il contrasto temporale “La settimana scorsa eri fiorente” introduce una dimensione di straniamento che attraversa tutta la poesia: l’impossibilità di accettare la rapidità con cui la vita si è trasformata in morte. I preparativi funebri – “Ti vado a prendere il vestito a casa, poi nella cassa ti verranno a chiudere per sempre” – vengono subito negati dalla frase “No, per sempre sei animo della mia anima, e la liberi”.
Nella seconda parte della poesia, si sviluppa il tema del senso di colpa del sopravvissuto. “Sconto, sopravvivendoti, l’orrore degli anni che t’usurpo” esprime quel particolare rimorso che colpisce chi resta quando chi doveva sopravvivere muore. Il verso “come se, ancora tra di noi mortale, tu continuassi a crescere; ma cresce solo, vuota, la mia vecchiaia odiosa” rivela la distorsione temporale del lutto: il tempo del defunto si è fermato, mentre quello del vivo continua in modo inutile.
La conclusione ci porta a riflettere sul paesaggio brasiliano, che appare estraneo e persino ostile: “Questo cielo australe è troppo azzurro, troppi astri lo popolano, troppi e, per noi, non ce n’è uno familiare”. Questa estraneità geografica amplifica il senso di smarrimento esistenziale. Il “cielo sordido, che scende senza un soffio” degli ultimi versi trasforma quell’azzurro così intenso in una presenza opprimente, mentre le “mani tese a scansarlo” richiamano, per contrasto, le mani del bambino che non riescono più a afferrare quelle del padre.
La lingua di Ungaretti qui mostra una maturità espressiva che ha superato l’estrema concentrazione dell’ermetismo giovanile, senza però perdere l’intensità. Il verso si distende in un respiro più ampio, ma conserva quella precisione nella scelta delle immagini e nella costruzione ritmica che contraddistingue la migliore poesia del Novecento italiano. La sintassi, apparentemente semplice, nasconde stratificazioni temporali complesse che riflettono la complessità dell’esperienza del lutto.
“Gridasti soffoco” si inserisce nella tradizione della poesia funeraria italiana, ma la rinnova profondamente grazie all’immediatezza dell’esperienza contemporanea e alla capacità di trasformare il dolore privato in una riflessione universale sulla condizione umana. La grandezza di Ungaretti risiede nella sua abilità di dare forma poetica a un’esperienza che rischia sempre di rimanere muta, creando uno dei più alti esempi di lirica del dolore nella letteratura italiana.

Testo della poesia “Gridasti soffoco” di Giuseppe Ungaretti, dalla raccolta Un grido e paesaggi
Gridasti soffoco di Giuseppe Ungaretti dalla raccolta Un grido e paesaggi
Non potevi dormire, non dormivi…
Gridasti: Soffoco…
Nel viso tuo scomparso già nel teschio,
gli occhi, che erano ancora luminosi
solo un attimo fa, 5
gli occhi si dilatarono… si persero…
sempre ero stato timido,
ribelle, torbido; ma puro, libero,
felice rinascevo nel tuo sguardo…
Poi la bocca, la bocca 10
che una volta pareva, lungo i giorni,
lampo di grazia e gioia,
la bocca si contorse in lotta muta…
Un bimbo è morto…
Nove anni, chiuso cerchio, 15
nove anni cui né giorni, né minuti
mai più s’aggiungeranno:
in essi s’alimenta
l’unico fuoco della mia speranza.
Posso cercarti, posso ritrovarti, 20
posso andare, continuamente vado
a rivederti crescere
da un punto all’altro
dei tuoi nove anni.
Io di continuo posso, 25
distintamente posso
sentirti le tue mani nelle mie mani:
le mani tue di pargolo
che afferrano le mie senza conoscerle;
le tue mani che si fanno sensibili, 30
sempre più consapevoli
abbandonandosi nelle mie mani;
le tue mani che diventano secche
e, sole – pallidissime –
sole nell’ombra sostano… 35
La settimana scorsa eri fiorente…
Ti vado a prendere il vestito a casa,
poi nella cassa ti verranno a chiudere
per sempre. No, per sempre
sei animo della mia anima, e la liberi. 40
Ora meglio la liberi
che non sapesse il tuo sorriso vivo:
provala ancora, accrescile la forza,
se vuoi – sino a te, caro! – che m’innalzi
dove il vivere è calma, è senza morte. 45
Sconto, sopravvivendoti, l’orrore
degli anni che t’usurpo,
e che ai tuoi anni aggiungo,
demente di rimorso,
come se, ancora tra di noi mortale, 50
tu continuassi a crescere;
ma cresce solo, vuota,
la mia vecchiaia odiosa…
Come ora, era di notte,
E mi davi la mano, fine mano… 55
Spaventato tra me e me m’ascoltavo:
E’ troppo azzurro questo cielo australe,
troppi astri lo gremiscono,
troppi e, per noi, non uno familiare…
(Cielo sordido, che scende senza un soffio, 60
sordo che udrò continuamente opprimere
Mani tese a scansarlo)
dalla raccolta Un grido e paesaggi