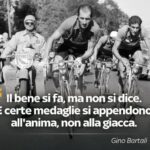
Gino Bartali, grande sportivo e grande uomo
6 Giugno 2025
Fine d’agosto di Cesare Pavese
6 Giugno 2025Traccia svolta di una analisi di un testo poetico di Vincenzo Cardarelli
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – PROVA DI ITALIANO – Sessione Straordinaria 2019
TRACCIA TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A1
Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli)
Sera di Gavinana
dalla raccolta Poesie, Mondadori, Milano, 1942.
Sera di Gavinana¹
Ecco la sera e spiove sul toscano
Appennino. Con lo scender che fa
le nubi a valle, prese a lembi
qua e là come ragne² fra gli alberi
intricate, si colorano i monti
di viola.
Dolce vagare allora
per chi s’affanna il giorno ed in se stesso,
incredulo, si torce. Viene dai borghi,
qui sotto, in faccende, un vociar lieto
e folto in cui si sente il giorno
che declina e il riposo imminente.
Vi si mischia il pulsare, il batter secco
ed alto del camion sullo stradone
bianco che varca i monti. E tutto quanto
a sera, grilli, campane, fonti,
fa concerto e preghiera, trema
nell’aria sgombra.
Ma come più rifulge, nell’ora
che non ha un’altra luce, il manto
dei tuoi fianchi ampi, Appennino.
Sui tuoi prati che salgono a gironi,
questo liquido verde, che rispunta
fra gl’inganni del sole ad ogni acquata³,
al vento trascolora, e mi rapisce,
per l’inquieto cammino, sì che teneramente
fa star muta l’anima vagabonda.
Sera di Gavinana dalla raccolta Poesie, Mondadori, Milano, 1942.
Nota critica
La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile individuare alcune costanti, spesso inserite – come nel caso di ‘Sera di Gavinana’ – in un contesto di descrizione stagionale, accompagnato da ricche immagini pittoriche.
COMPRENSIONE E ANALISI
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
- Individua brevemente i temi della poesia.
- Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia, nella poesia qui proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con esse è preclusa ogni comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire?
- Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e modernità. Cerca di individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a movimenti letterari e poetici degli inizi del XX secolo.
- A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”?
- Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al poeta. Soffermati su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima vagabonda”.
INTERPRETAZIONE
“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti riferimenti alla tradizione letteraria italiana, si caratterizza per caratteri di inattesa originalità che fanno breccia nel testo.
Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più significative. Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti per te rilevanti, individua i collegamenti ad autori, testi e correnti della nostra letteratura.
Note:
¹ Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia
² ragne: ragnatele
³ acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia
Sessione straordinaria 2019 Prima prova scritta
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
SVOLGIMENTO
🔍 Analisi di ‘Sera di Gavinana’ di Vincenzo Cardarelli
La poesia “Sera di Gavinana” di Vincenzo Cardarelli, tratta dalla raccolta Poesie (1942), si inserisce nel solco della sua produzione caratterizzata da descrizioni paesaggistiche intense, spesso legate a contesti stagionali e ricche di suggestioni pittoriche. Il testo presenta una riflessione sull’incontro tra l’io lirico e il paesaggio, qui l’Appennino toscano al crepuscolo, esplorando temi universali quali la condizione umana, la memoria e il rapporto tra natura e modernità.
Comprensione e Analisi
1. Individua brevemente i temi della poesia.
I temi principali della poesia “Sera di Gavinana” sono:
- La natura e il paesaggio appenninico, descritto nel momento del crepuscolo e dopo la pioggia, con un forte impatto visivo e sensoriale.
- La condizione esistenziale dell’io lirico, caratterizzata da una profonda inquietudine (“chi s’affanna il giorno”, “incredulo, si torce”, “anima vagabonda”) che trova un momentaneo rapimento nella contemplazione della natura.
- Il tempo che declina (la sera) e il riposo imminente, che si oppone e si mescola alla fatica del giorno.
- Il dialogo tra passato e presente/modernità, evocato dai suoni dei borghi e dal rumore del camion, che convivono nello stesso paesaggio.
- La solitudine dell’individuo di fronte alla vastità della natura e alla complessità della vita.
2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia, nella poesia qui proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con esse è preclusa ogni comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire?
La condizione solitaria dell’io lirico cardarelliano è effettivamente mitigata, in “Sera di Gavinana”, dalla percezione di “presenze” umane e della modernità, benché distanti e non direttamente comunicanti con il poeta. Queste presenze sono evocate attraverso precisi rimandi sensoriali, prevalentemente uditivi:
- Il “vociar lieto e folto” (vv. 11-12) proveniente dai borghi: È un suono collettivo, segno di vita comunitaria e di attività che si placa con il declinare del giorno. Questo rumore “lito e folto” suggerisce un’umanità che vive e opera, contrapposta all’interiorità solitaria del poeta, ma che con essa condivide il ritmo del tempo e l’attesa del riposo.
- Il “pulsare, il batter secco / ed alto del camion sullo stradone” (vv. 14-15): Questo è il rumore della modernità che irrompe nel paesaggio naturale e tradizionale. È un suono meccanico, secco e forte, che si mescola al “vociar” dei borghi, creando un’immagine acustica complessa e stratificata. Rappresenta la presenza dell’uomo che modifica il paesaggio e i ritmi della vita, anche se l’io lirico rimane un osservatore distaccato di questa dinamica.
- Il “concerto e preghiera” (v. 19) di “grilli, campane, fonti” (v. 18): Questo è un insieme di suoni naturali e umani (le campane) che si fondono in un’armonia serale. Le campane, in particolare, sono un simbolo della presenza umana organizzata e della sua religiosità, pur rimanendo una “presenza” acustica lontana e non interattiva.
Attraverso questi stimoli sonori, il poeta crea una sinfonia crepuscolare in cui la solitudine dell’io lirico non è totale isolamento, ma una condizione di osservazione sensibile di un mondo che, pur distante, si manifesta attraverso le sue vibrazioni e i suoi rumori.
3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e modernità. Cerca di individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a movimenti letterari e poetici degli inizi del XX secolo.
Nello sfondo del “toscano Appennino”, Cardarelli opera una sintesi tra elementi della natura, dell’attività umana e della modernità, richiamando, per la sua sinteticità e suggestione, alcuni movimenti letterari e poetici degli inizi del XX secolo.
- Natura:
- Paesaggio: “toscano Appennino”, “nubi a valle”, “monti di viola”, “prati che salgono a gironi”, “vento”.
- Fenomeni atmosferici: “spiove”, “acquata”.
- Elementi naturali sonori: “grilli”, “fonti”.
- Immagini cromatiche: “monti di viola”, “liquido verde”. La descrizione della natura è evocativa, essenziale, quasi pittorica, con un’attenzione alla luce e al colore che ricorda l’impressionismo o, per certi aspetti, il simbolismo nella sua capacità di evocare atmosfere e stati d’animo. La natura non è solo sfondo, ma presenza viva e talvolta “antagonista”.
- Umanità:
- Vita collettiva: “borghi”, “vociar lieto e folto”.
- Attività quotidiana: “chi s’affanna il giorno”, “in faccende”.
- Simboli tradizionali: “campane” (che scandiscono il tempo della comunità). Questa presenza umana è evocata attraverso suoni e immagini di vita contadina o di piccole comunità, che rappresentano una dimensione più tradizionale e radicata.
- Modernità:
- Tecnologia e infrastrutture: “camion sullo stradone / bianco che varca i monti”. La presenza del camion e dello stradone è un elemento di rottura, che introduce la dimensione del progresso tecnico e del movimento veloce nel paesaggio tradizionale. È un’immagine che preannuncia le trasformazioni del paesaggio italiano.
- Riferimenti a movimenti letterari e poetici degli inizi del XX secolo:
- Vocianesimo/Crepuscolarismo: L’attenzione per le piccole cose, per i suoni discreti e per l’atmosfera malinconica del crepuscolo, unita a un tono a tratti dimesso e a una certa propensione alla solitudine esistenziale dell’io lirico, può richiamare il crepuscolarismo. La “vociar lieto e folto” dal borgo suggerisce una certa attenzione per la vita semplice e quotidiana.
- Ermetismo (antecedente): Pur non essendo un ermetico in senso stretto, Cardarelli anticipa una certa tendenza all’essenzialità espressiva e alla suggestione evocativa tipica di questa corrente. La densità semantica e la ricerca di un “rapporto profondo” con il paesaggio, anche se non la frammentazione estrema, lo avvicinano a certe sensibilità.
- Realismo lirico: Cardarelli tende a un realismo che non è mera cronaca, ma trasfigurazione lirica del dato reale, che si eleva a simbolo. L’inserimento di elementi di modernità (il camion) in un contesto tradizionale anticipa quel confronto tra vecchio e nuovo tipico di tanta poesia del Novecento.
4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”?
La sinestesia “liquido verde” (v. 24) allude ai prati dell’Appennino, in particolare all’erba fresca e rigogliosa che rinasce dopo la pioggia. Il termine “liquido” si riferisce all’acqua dell’acquazzone appena caduto, che rende l’erba bagnata e lucida, quasi fosse un manto fluido. “Verde” è, ovviamente, il colore dei prati. La sinestesia fonde la percezione visiva del colore con la percezione tattile o suggestiva della liquidità, creando un’immagine vivida e sensoriale che esprime la vitalità della natura dopo il temporale, un verde intenso e quasi tangibile per la sua freschezza e la sua recente “lavatura”.
5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al poeta. Soffermati su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima vagabonda”.
Nel terzo blocco strofico, il paesaggio dell’Appennino non è più solo uno sfondo, ma assume un ruolo attivo e quasi antropomorfo, diventando un interlocutore e, in un certo senso, un “antagonista” o, meglio, una forza che sfida e modella l’interiorità del poeta.
Il “ruolo” dell’Appennino come “antagonista” è espresso in diversi modi:
- Il “manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino” (v. 23): L’Appennino viene personificato con attributi corporei (“fianchi”), rendendolo una presenza imponente e quasi fisica. Questo “manto” assume un’aura di maestosità e rivelazione (“come più rifulge, / nell’ora che non ha un’altra luce”).
- “gl’inganni del sole ad ogni acquata” (v. 26): Qui il paesaggio non è solo passivo, ma presenta quasi una sua volontà, un’intenzione ingannevole, con il sole che si “svela” e si “nasconde” tra le acquate. Questa dinamica tra luce e pioggia, tra rivelazione e velatura, attribuisce alla natura una sorta di gioco, di sfida percettiva.
- Il paesaggio che “mi rapisce” (v. 27): È il gesto più esplicito di personificazione e di azione “antagonista” o prevaricante. L’Appennino, con il suo “liquido verde” che “al vento trascolora”, non è più solo oggetto di contemplazione, ma soggetto di un’azione che sottrae il poeta al suo stato. Questo rapimento è ambiguo: è un’esperienza estatica e piacevole, ma implica anche una perdita di controllo, un’essere “preso” da una forza esterna.
La definizione di sé come “anima vagabonda” (v. 30) è centrale per comprendere questa dinamica.
- “Vagabonda” sottolinea una condizione di irrequietezza interiore, di ricerca incessante, di mancanza di un ancoraggio stabile. È l’anima che erra, che non trova pace, che forse si “torce” su se stessa nell’affanno del giorno (v. 9).
- Il “rapimento” da parte dell’Appennino, che fa “teneramente fa star muta / l’anima vagabonda”, indica una momentanea sospensione di questa irrequietezza. Il paesaggio, con la sua grandezza e la sua bellezza mutevole, ha il potere di zittire il tormento interiore, di placare, anche se solo per un istante, la sua inquietudine errabonda. Non è una risoluzione definitiva, ma un attimo di tregua, di contemplazione in cui la dispersione dell’anima si concentra e trova una forma di quiete imposta dalla potenza della natura. L’Appennino, quindi, è un “antagonista” che sfida l’inquietudine del poeta, costringendolo a una (seppur temporanea) quiete interiore.
Interpretazione
“Sera di Gavinana” è una poesia che, pur attingendo a piene mani dalla ricca tradizione letteraria italiana, riesce a imporsi per caratteri di inattesa originalità, facendo breccia nel testo con la sua intima fusione di paesaggio e stato d’animo. Le chiavi interpretative più significative risiedono proprio nella sua capacità di evocare, attraverso un linguaggio limpido e a tratti classicheggiante, una modernità sottile e una profonda inquietudine esistenziale.
Uno degli aspetti più evidenti è il classicismo di Cardarelli, che si manifesta nella limpidezza della forma, nella ricerca dell’equilibrio e nella capacità di creare immagini di forte impatto visivo. L’incipit stesso, “Ecco la sera e spiove / sul toscano Appennino”, richiama una solennità quasi virgiliana o leopardiana nella descrizione del paesaggio. La scelta del settenario, con l’alternanza di rime e assonanze, conferisce al verso una musicalità sobria e controllata. Questa adesione a una tradizione di rigore formale è una costante nella produzione cardarelliana, che si opponeva agli eccessi del futurismo o al frammentismo di altre correnti coeve, cercando un equilibrio tra la modernità e la lezione dei classici. Si pensi, per analogia, alla poesia di Pascoli, che pur innovando, manteneva una certa predilezione per la precisione descrittiva e un legame con la natura, anche se con esiti simbolici diversi.
L’originalità emerge, tuttavia, nella fusione tra il paesaggio “esterno” e il paesaggio “interiore”. L’Appennino non è uno sfondo neutro, ma un catalizzatore di stati d’animo. Il “liquido verde” che “mi rapisce” è un esempio di questa compenetrazione: la sensazione fisica del paesaggio si traduce in un rapimento dell’anima. La sinestesia è un tratto distintivo di questa capacità di fondere le percezioni, e in Cardarelli non è mai un mero artificio, ma un mezzo per esprimere una realtà più complessa e profonda. Questa attenzione alla dimensione interiore del paesaggio anticipa sensibilità che si ritroveranno poi, con maggiore radicalità, nell’Ermetismo, dove il paesaggio diventa spesso simbolo di una condizione esistenziale.
Un’altra chiave di lettura significativa è la dialettica tra tradizione e modernità. L’Appennino toscano, con i suoi borghi, le campane e le fonti, rappresenta una dimensione arcaica e rassicurante, quella dell’Italia rurale e profonda. A questa si contrappone, ma si mescola, l’elemento della modernità: il “camion sullo stradone bianco”. Questo contrasto è emblematico di un Novecento in rapida trasformazione, in cui i residui di un mondo antico convivono con l’irrompere della tecnologia. Cardarelli non giudica, ma registra questa compresenza, mostrando come anche il rumore del motore possa inserirsi nella sinfonia crepuscolare, anche se con un tono più “secco” e “alto”. Questo tema del confronto tra città e campagna, tra progresso e tradizione, è un topos ricorrente nella letteratura italiana del ‘900, da Gozzano a Pavese.
Infine, la condizione dell'”anima vagabonda” e il senso di inquietudine rappresentano un tratto distintivo dell’io lirico cardarelliano e un’eco della sensibilità decadente e novecentesca. L’individuo, pur immerso in una natura grandiosa, non trova piena pace, ma solo un momentaneo “rapimento” che lo fa “star muta” dalla sua irrequietezza. Non c’è la catarsi definitiva, ma un’attimo di sospensione. Questa “vagabondaggine” dell’anima può essere letta come una metafora della condizione umana moderna, disancorata e in perenne ricerca, che trova un effimero conforto nella bellezza della natura ma non una risoluzione alle proprie domande esistenziali. È un tema che lega Cardarelli a poeti come Ungaretti, con la sua ricerca di un assoluto nella frammentazione, o persino a certi aspetti della poesia di Montale, dove la natura è spesso un correlativo oggettivo di una condizione esistenziale complessa e a tratti dolorosa.
In conclusione, “Sera di Gavinana” è un testo che, pur nella sua apparente semplicità descrittiva, si rivela un esempio significativo della capacità di Cardarelli di tessere un dialogo tra la tradizione e le nuove sensibilità del Novecento. Attraverso una sapiente orchestrazione di immagini pittoriche, suggestioni sonore e una profonda indagine dell’interiorità, la poesia ci offre uno sguardo intimo e malinconico sul rapporto tra l’uomo e il paesaggio, una riflessione sulla fragilità dell’esistenza e sulla ricerca, spesso vana, di una quiete duratura.





