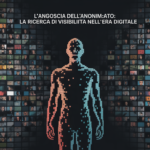
L’angoscia dell’anonimato: la ricerca di visibilità nell’era di…
15 Giugno 2025
Analisi di Il Versificatore di Primo Levi
15 Giugno 2025Traccia e svolgimento di una Analisi del testo letterario Son tanto brava lungo il giorno di Sibilla Aleramo
TRACCIA
PROVA DI ITALIANO A1 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE – PROVA DI ITALIANO – Sessione straordinaria 2024 – Prima prova scritta – Ministero dell’istruzione e del merito
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A1
Autore: Sibilla Aleramo
Titolo: Son tanto brava lungo il giorno
Fonte: in Tutte le poesie, Il Saggiatore, Milano, 2023
TESTO
Son tanto brava lungo il giorno.
Comprendo, accetto, non piango.
Quasi imparo ad aver orgoglio
quasi fossi un uomo.Ma, al primo brivido di viola in cielo
ogni diurno sostegno dispare.Tu mi sospiri lontano:
«Sera, sera dolce e mia!».Sembrami d’aver fra le dita
la stanchezza di tutta la terra.
Non son più che sguardo, sguardo sperduto,
e vene.
COMPRENSIONE E ANALISI
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.
- Presenta sinteticamente il contenuto della poesia.
- Nel componimento poetico sono elencate le caratteristiche per le quali una donna può essere considerata ‘brava’: individuale e spiega il verso ‘Quasi imparo ad aver orgoglio quasi fossi un uomo’.
- Illustra il motivo per cui le emozioni della protagonista cambiano all’arrivo della sera e il significato del verso ‘ogni diurno sostegno dispare’.
- La poesia si conclude rivelando uno stato d’animo della protagonista diverso da quello dei primi versi: individua e spiega le espressioni che rivelano questo cambiamento.
INTERPRETAZIONE
Alla luce delle tue conoscenze e personali esperienze esprimi le tue considerazioni sulle caratteristiche di una poetica “al femminile”, prendendo anche in considerazione l’evoluzione dei temi ad essa pertinenti nello sviluppo storico della letteratura italiana.
Durata massima della prova: 6 ore
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana

SVOLGIMENTO
Analisi di ‘Son tanto brava lungo il giorno’ di Sibilla Aleramo
La poesia “Son tanto brava lungo il giorno” di Sibilla Aleramo, figura centrale della letteratura italiana e del femminismo del Novecento, è una lirica che esplora la dualità dell’esperienza femminile: la maschera di forza e accettazione imposta dalle convenzioni sociali e la vulnerabilità emotiva che emerge nel silenzio della sera. Attraverso la voce della protagonista, Aleramo delinea un ritratto intimo di una donna che, pur conformandosi alle aspettative diurne, si abbandona alla sua vera natura al calar della luce, rivelando un’inquietudine profonda e una stanchezza esistenziale.
Comprensione e Analisi
1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia.
La poesia descrive la condizione interiore della protagonista nell’arco di una giornata. Durante il giorno, ella si sforza di apparire “brava”, capace di comprendere, accettare e non piangere, quasi assimilando un orgoglio tipicamente maschile. Tuttavia, con l’arrivo della sera, simboleggiato dal “primo brivido di viola in cielo”, ogni appoggio e ogni forza diurna svaniscono. In questo momento di vulnerabilità, il ricordo di una persona amata (“Tu mi sospiri lontano: «Sera, sera dolce e mia!»”) si fa sentire intensamente. La protagonista si sente sopraffatta da una stanchezza universale, riducendosi a un “sguardo sperduto” e alle sole “vene”, simbolo di una fragilità corporea e di un’esistenza quasi eterea.
2. Nel componimento poetico sono elencate le caratteristiche per le quali una donna può essere considerata ‘brava’: individuale e spiega il verso ‘Quasi imparo ad aver orgoglio quasi fossi un uomo’.
Nel componimento, le caratteristiche per le quali una donna può essere considerata “brava” nel contesto sociale e culturale implicitamente richiamato sono:
- Comprendo: La capacità di capire le situazioni, forse anche di accettare i propri limiti o le circostanze sfavorevoli senza ribellione.
- Accetto: La rassegnazione, la sottomissione al proprio destino o alle regole imposte.
- Non piango: La capacità di reprimere le proprie emozioni, di mostrarsi forte e imperturbabile, di non cedere alla debolezza o al dolore.
Il verso ‘Quasi imparo ad aver orgoglio quasi fossi un uomo’ è particolarmente significativo. Qui, l’orgoglio non è inteso come vanità, ma come una forma di dignità, di forza interiore, di autonomia, di resistenza alla sofferenza, qualità che la società dell’epoca spesso attribuiva in via esclusiva o preponderante agli uomini. La protagonista non possiede naturalmente questo tipo di “orgoglio”, ma lo “impara” o tenta di acquisirlo, come se fosse una qualità estranea alla sua natura femminile o una maschera da indossare. Il “quasi” sottolinea la difficoltà di questa assimilazione e la sua imperfezione, suggerendo che si tratta di un’emulazione, non di un’acquisizione autentica. La donna si sforza di conformarsi a un modello di forza e imperturbabilità tipicamente maschile, per essere accettata o rispettata in un mondo dominato da valori patriarcali, sacrificando però la sua vera emotività.
3. Illustra il motivo per cui le emozioni della protagonista cambiano all’arrivo della sera e il significato del verso ‘ogni diurno sostegno dispare’.
Le emozioni della protagonista cambiano radicalmente all’arrivo della sera per diversi motivi, legati sia alla dimensione psicologica che simbolica:
- Crollo della Maschera: La sera, con la sua oscurità e la sua tranquillità, simboleggia la fine della giornata sociale e l’inizio del tempo privato, intimo. È il momento in cui la protagonista può finalmente togliersi la maschera di forza e conformismo indossata durante il giorno (“Son tanto brava lungo il giorno. Comprendo, accetto, non piango”). La luce del giorno, con le sue esigenze e le sue aspettative, le fornisce un “sostegno” per mantenere questa facciata, ma al buio tale necessità svanisce.
- Vulnerabilità Emotiva: Il “primo brivido di viola in cielo” è una sinestesia che evoca non solo il cambiamento cromatico del crepuscolo, ma anche una sensazione fisica di vulnerabilità e malinconia. È il segnale che il controllo emotivo viene meno.
- Richiamo Affettivo: La sera è anche il momento in cui si manifesta la nostalgia e il bisogno dell’altro, simboleggiato dal “Tu mi sospiri lontano: «Sera, sera dolce e mia!»”. Questo richiamo affettivo (forse di un amato, o del desiderio di un amore) indebolisce ulteriormente le difese della protagonista, facendole sentire il peso della solitudine o della distanza.
Il verso ‘ogni diurno sostegno dispare’ significa che tutte le difese, gli autoinganni, le convenzioni sociali e la forza d’animo che la protagonista si sforza di mantenere durante il giorno per apparire “brava” e adeguata, vengono meno con il calar della sera. Sono i “sostegni” che le permettono di contenere le sue fragilità e le sue emozioni. La loro scomparsa la lascia esposta, vulnerabile, permettendo al suo vero stato d’animo di emergere.
4. La poesia si conclude rivelando uno stato d’animo della protagonista diverso da quello dei primi versi: individua e spiega le espressioni che rivelano questo cambiamento.
La poesia si conclude con uno stato d’animo di profonda stanchezza, fragilità, dispersione e disorientamento, in netto contrasto con la controllata “bravura” dei primi versi. Le espressioni che rivelano questo cambiamento sono:
- “Sembrami d’aver fra le dita la stanchezza di tutta la terra.”: Questa espressione rivela una stanchezza non solo personale, ma quasi cosmica, universale. La protagonista si sente gravata da un peso immenso, il fardello dell’esistenza stessa, che la svuota di ogni energia residua. È una stanchezza esistenziale, non meramente fisica.
- “Non son più che sguardo, sguardo sperduto, e vene.”: Questa è una scomposizione del suo essere.
- “Non son più che sguardo”: La protagonista si riduce a pura percezione, ma uno sguardo che è anche passivo, che non agisce. Non è più un soggetto completo, ma una funzione.
- “sguardo sperduto”: Questo aggettivo indica smarrimento, disorientamento, mancanza di un punto di riferimento o di una meta. È la perdita di lucidità e di direzione che aveva cercato di mantenere di giorno.
- “e vene”: Le vene, simbolo di fragilità, di ciò che scorre e che è nascosto sotto la pelle, rappresentano la sua essenza più vulnerabile e trasparente, la sua corporeità più esposta e meno “forte”. La debolezza fisica si unisce a quella emotiva.
Nel complesso, queste espressioni mostrano la protagonista spogliata di ogni difesa, ridotta all’essenziale della sua fragilità fisica ed emotiva, stanca e smarrita, in un momento di totale vulnerabilità che è l’opposto della compostezza diurna.
Interpretazione
“Son tanto brava lungo il giorno” di Sibilla Aleramo è un testo emblematico di una poetica “al femminile” che, in Italia, ha cercato di dare voce a un’esperienza spesso silenziata o distorta dalla prospettiva maschile. La poesia esplora la scissione tra l’essere e l’apparire, la fatica di conformarsi a un ruolo sociale e la dolorosa autenticità che emerge nel privato. Questo tema è centrale nell’opera di Aleramo, autrice di Una donna, un romanzo autobiografico che fu un manifesto per l’emancipazione femminile, in cui la protagonista si ribella alle convenzioni borghesi e alla sottomissione al marito per affermare la propria identità e la propria vocazione di scrittrice. Lì, come nella poesia, emerge la difficoltà di essere donna in una società patriarcale, il prezzo da pagare per l’autonomia e la profonda solitudine che ne può derivare.
La “bravura” diurna della protagonista è una maschera sociale, un’autoimposizione dettata dalle aspettative di una società che premia la donna “forte”, “comprendente”, “accettante”, e soprattutto “non piangente”, cioè capace di reprimere le proprie emozioni e di assimilare qualità “maschili” come l’orgoglio. Il “quasi imparo ad aver orgoglio quasi fossi un uomo” rivela la consapevolezza di questa finzione, di un’identità costruita per necessità, non per autentica inclinazione. È la rappresentazione del sacrificio dell’individualità femminile sull’altare delle convenzioni.
L’arrivo della sera è il momento in cui questa maschera crolla, e la verità interiore si manifesta. Il “brivido di viola” e il “disparire di ogni diurno sostegno” segnano il confine tra il pubblico e il privato, tra l’impostazione e l’autenticità. In questo spazio intimo, emerge la stanchezza esistenziale (“la stanchezza di tutta la terra”), il senso di smarrimento (“sguardo sperduto”) e la fragilità fisica (“vene”). Il richiamo “Sera, sera dolce e mia!” di un’altra persona sottolinea un bisogno di affetto e comprensione che la protagonista non può esprimere di giorno.
La poetica al femminile, come quella di Aleramo, si distingue proprio per la sua capacità di esplorare queste dimensioni intime, emotive e spesso nascoste dell’esperienza femminile. Nello sviluppo storico della letteratura italiana, il tema dell’identità femminile e della sua evoluzione ha attraversato diverse fasi:
- Dalle origini al primo Novecento: Fino a buona parte dell’Ottocento, la voce femminile nella poesia è spesso filtrata da canoni maschili, o si esprime in ambiti più privati (epistolari, diari, come Anna Frank, vedi C2 Sessione ordinaria 2024). L’emergere di figure come Ada Negri (anche lei a cavallo tra ‘800 e ‘900) porta una poesia più orientata alla realtà sociale e lavorativa, ma spesso ancora in schemi tradizionali. Sibilla Aleramo è una pioniera, perché con Una donna e poi con la sua poesia rompe apertamente con la tradizione, portando in primo piano la ribellione contro il ruolo imposto e la ricerca di un’autonomia esistenziale ed emotiva. La sua scrittura è un atto di autoaffermazione, spesso doloroso.
- Dopo la Seconda Guerra Mondiale: Il secondo dopoguerra e, in particolare, gli anni ’60 e ’70, con l’emergere del movimento femminista, vedono un’esplosione di una poetica al femminile più consapevole e militante. Autrici come Alda Merini o Patrizia Cavalli esplorano con grande libertà e spesso crudezza la complessità della psiche femminile, il corpo, la sessualità, la follia, l’amore e la disillusione, con un linguaggio che rompe con le convenzioni e dà voce a un’esperienza autentica e non filtrata. Se Aleramo apre la strada al riconoscimento della sofferenza del ruolo, queste autrici successiva ne esplorano le profondità psicologiche con maggiore radicalità.
- Contemporaneità: Oggi, la poetica al femminile è estremamente variegata, ma continua a interrogarsi sui temi dell’identità, della libertà, della violenza di genere (come la denuncia dei femminicidi in Dacia Maraini, vedi C1 Sessione ordinaria 2024), del rapporto con il corpo e con la maternità, spesso in dialogo con le complessità della società digitale e le nuove sfide. L’esperienza femminile non è più un tabù, ma un campo di esplorazione vasto e riconosciuto.
Nella mia esperienza personale e nelle mie letture, ho trovato in queste voci femminili una risonanza profonda. La poesia di Aleramo mi fa riflettere sulla pressione sociale di dover essere “forti” o “perfetti” (un tema che ho esplorato anche con Levi-Montalcini, vedi C1 Sessione ordinaria 2024) e sul valore del permettersi la vulnerabilità. La sua lirica mi insegna che l’autenticità spesso si rivela nei momenti di solitudine, quando cadono le maschere diurne, e che accettare la propria fragilità è un atto di coraggio. È nella “bravura” diurna che si cela la stanchezza, e nel “brivido di viola” serale che si ritrova, seppur con malinconia, la verità di sé.
Biografie e appunti
-
Sibilla Aleramo della classe Quinta “B” Commerciale dell’Istituto Tecnico “Baruffi” di Ceva, in provincia di Cuneo
-
Biografia di italialibri
-
Aleramo di Luigi de Bellis
-
Aleramo dalla Letteratura Italiana di Luigi De Bellis
-
Biografia di italiadonna
-
Scheda biografica della classe Quinta “B” Commerciale dell’Istituto Tecnico “Baruffi” di Ceva, in provincia di Cuneo
Ipertesti
-
Una donna di Sibilla Aleramo della classe Quinta “B” Commerciale dell’Istituto Tecnico “Baruffi” di Ceva, in provincia di Cuneo.
recensioni
-
“Una donna” di Sibilla Aleramo della classe Quinta “B” Commerciale dell’Istituto Tecnico “Baruffi” di Ceva, in provincia di Cuneo




