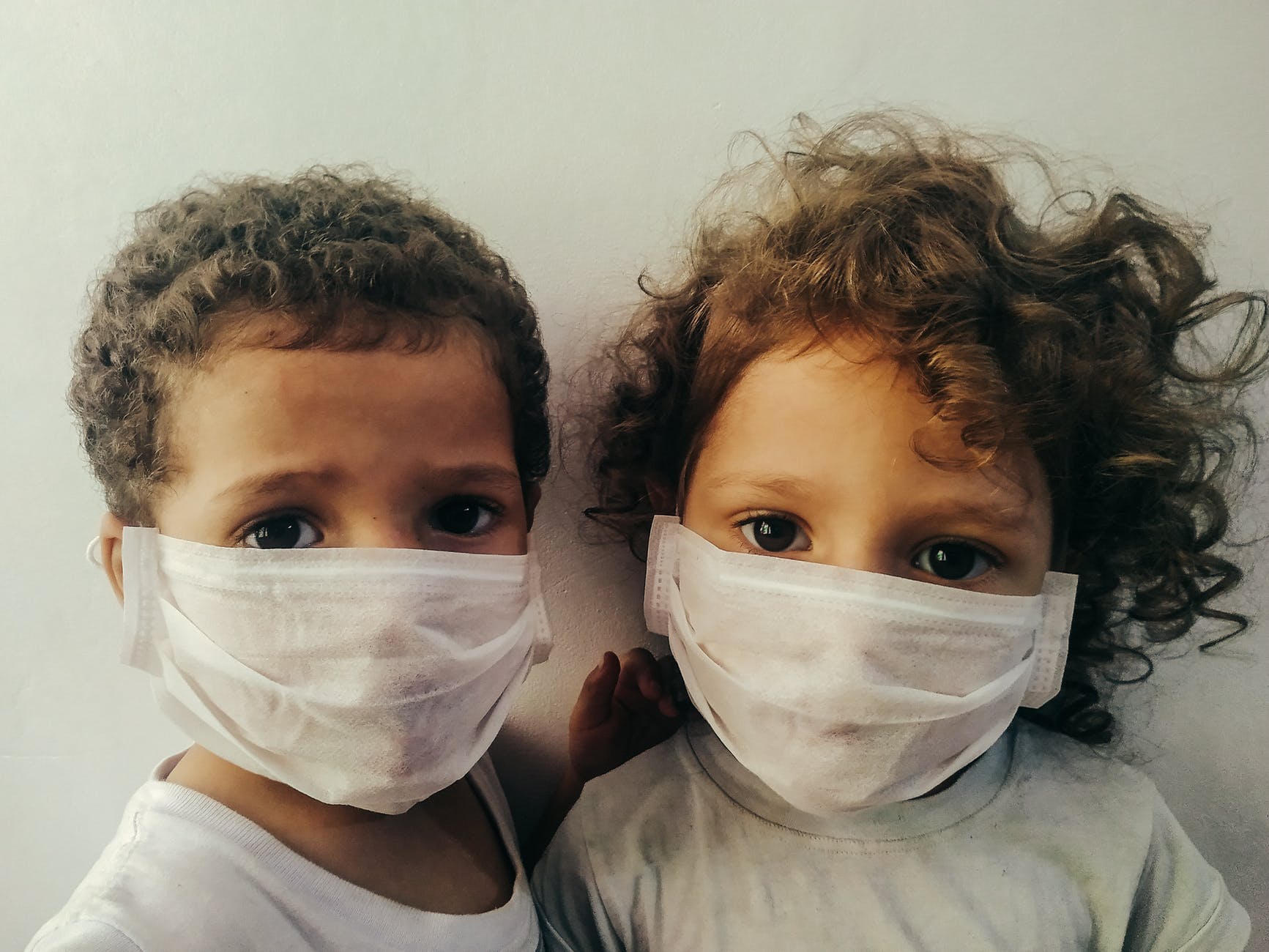
Niente mascherina se in classe manca il saturimetro per l’alunno in difficol…
16 Marzo 2021
Il colombre di Dino Buzzati
16 Marzo 2021Testo originale , parafrasi e analisi della poesia ‘Un altro lunedì’ di Primo Levi
Testo della poesia “Un altro lunedì” di Primo Levi, affiancato dalla sua parafrasi
| Testo della poesia di Primo Levi Un altro lunedì
«Dico chi finirà all’Inferno: Invece vanno in Paradiso Cosi Minosse orribilmente ringhia Avigliana, 28 gennaio 1946.
|
Parafrasi di “Un altro lunedì”
«Vi dico chi sarà destinato all’Inferno: Invece andranno in Paradiso: Così Minosse, con voce spaventosa, grugnisce Avigliana, 28 gennaio 1946. |

Analisi di ‘Un altro lunedì’ di Primo Levi
La poesia “Un altro lunedì” di Primo Levi, composta nel 1946 e inclusa in Ad ora incerta, è un testo profondamente intriso di ironia amara e di richiami alla sua drammatica esperienza nei Lager. Ambientata nella stazione di Porta Nuova a Torino, la poesia trasforma il banale ritorno alla vita lavorativa del lunedì mattina in una scena dantesca di giudizio universale, con un “nuovo Minosse” che opera una distinzione, stavolta, tra dannati ed eletti in base a criteri tutt’altro che divini o morali.
Comprensione e Analisi
1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia, indicandone i temi.
La poesia descrive un lunedì mattina nella stazione di Porta Nuova a Torino, dove il poeta immagina un Minosse moderno che, attraverso i megafoni, annuncia chi è destinato all’Inferno e chi al Paradiso. I “dannati” sono elencati con categorie che richiamano la vita borghese e l’efficienza (giornalisti americani, professori di matematica, ragionieri, farmacisti, direttori di società, chi si alza presto per necessità). Gli “eletti” al Paradiso, invece, sono figure legate alla semplicità, alla natura, all’emozione o a mestieri più umili o avventurosi (pescatori, soldati, bambini, cavalli, innamorati, cuoche, ferrovieri, russi, inventori, assaggiatori di vino, saltimbanchi, lustrascarpe, e i primi passeggeri del tram mattutino che sbadigliano). L’intera scena è ambientata nell'”angoscia dei lunedì mattina” che solo chi la prova può comprendere, e si conclude con l’indicazione della data e del luogo di composizione.
I temi principali della poesia sono:
- La quotidianità alienante e l’angoscia del ritorno al lavoro.
- La critica sociale ironica e la satira dei valori borghesi e della produttività.
- Il rovesciamento dei valori tradizionali di “dannazione” e “salvezza”.
- La contrapposizione tra apparenza e sostanza nella vita.
- La memoria del Lager (giudizio e selezione) rielaborata in chiave sarcastica.
- La dimensione umana e fragile contrapposta all’efficienza meccanica.
2. Spiega la distinzione tra i “dannati” all’Inferno e gli “eletti” al Paradiso, e quali sono i criteri usati dal Minosse di Levi.
Nel “giudizio” di questo lunedì, la distinzione tra “dannati” all’Inferno e “eletti” al Paradiso opera un rovesciamento ironico dei criteri tradizionali di merito e peccato.
I “dannati” all’Inferno sono prevalentemente figure associate alla razionalità, all’efficienza, al potere economico e intellettuale, alla burocrazia e alla routine conformista:
- Giornalisti americani: Probabilmente simbolo di una certa superficialità mediatica o di un potere comunicativo invasivo.
- Professori di matematica: Figure della logica, del rigore, della fredda razionalità.
- Senatori e sagrestani: Rappresentanti del potere politico e religioso, forse criticati per la loro aridità o formalismo.
- Ragionieri e farmacisti: Mestieri che evocano la routine, il calcolo, la precisione sterile.
- Gatti: Una nota ironica, forse per la loro apparente autonomia e indifferenza.
- Finanzieri e direttori di società: Emblemi del capitalismo, del potere economico, della ricchezza materiale.
- Chi si alza presto alla mattina / Senza averne necessità: Questa è una critica ironica all’efficienza compulsiva, al puritanesimo lavorativo non motivato da reale bisogno.
Gli “eletti” al Paradiso, invece, sono figure legate a valori più autentici, spontanei, emotivi, al lavoro manuale, alla natura, all’arte o a una certa marginalità sociale:
- Pescatori e soldati: Professioni a contatto con la natura o con il rischio, che richiedono coraggio e fisicità.
- Bambini, naturalmente: Simboli di innocenza, spontaneità e purezza, naturalmente meritevoli.
- Cavalli e innamorati: Rappresentanti della bellezza, della forza istintiva, della passione e dell’emozione autentica.
- Cuoche e ferrovieri: Mestieri legati al servizio, al fare concreto, alla vita semplice.
- Russi e inventori: Simboli forse di una cultura resistente e di una creatività non convenzionale (con l’eco della Russia sovietica che aveva combattuto il nazismo).
- Gli assaggiatori di vino, saltimbanchi e lustrascarpe: Mestieri legati al piacere sensoriale, all’arte popolare, all’umiltà e alla marginalità.
- Quelli del primo tram del mattino / Che sbadigliano nelle sciarpe: Rappresentano la quotidianità non mascherata, la fatica autentica, l’umanità più vera e meno pretenziosa.
I criteri usati da questo Minosse sono quindi un rovesciamento satirico dei valori dominanti della società borghese e capitalistica. Sembra che la dannazione colpisca chi è troppo legato all’efficienza, al successo materiale, alla fredda razionalità, mentre la salvezza sia concessa a chi conserva una dimensione più umana, spontanea, passionale o, paradossalmente, meno “utile” o meno “efficiente” secondo i canoni produttivistici.
3. Qual è il ruolo del Minosse e della stazione di Porta Nuova in questa scena? Collegali ai riferimenti danteschi e all’esperienza di Levi.
Il Minosse di Levi è una figura centrale nella scena, fungendo da giudice grottesco e arbitrario. In Dante, Minosse è il demone che giudica i peccatori all’ingresso dell’Inferno, avvolgendosi con la coda tante volte quanti sono i cerchi in cui il dannato deve scendere. In Levi, Minosse “orribilmente ringhia / Dai megafoni di Porta Nuova”, trasformandosi in una voce impersonale e meccanica, quella degli altoparlanti, che impone una sentenza insensata e paradossale. La sua “orribilità” non è quella demoniaca, ma quella dell’assurdità del giudizio.
La stazione di Porta Nuova è il luogo fisico in cui si svolge questa parodia di giudizio. Non è un limbo o un girone infernale, ma un luogo di transito, il punto di partenza e arrivo della vita lavorativa quotidiana. La stazione, luogo di masse in movimento, diventa il teatro di questa selezione, sottolineando come la vita moderna, con i suoi ritmi e le sue “necessità” (il lavoro, il pendolarismo), imponga essa stessa una sorta di giudizio e di divisione tra gli individui.
I riferimenti danteschi sono espliciti e carichi di risonanze biografiche:
- Minosse: È il giudice infernale, ma il suo criterio è invertito da Levi. Non giudica i peccati morali, ma le caratteristiche sociali e professionali.
- “Chi intendere non può chi non la prova” (v. 24): Questa espressione è una chiara parafrasi del famoso verso dantesco (“E come quei che con la febbre sente / la sua bocca più dolce, così io / sentii la mia anima più dolce di quel punto / ch’io ebbi a dire: ‘Chi intendere non può / chi non la prova’”). Il verso originale dantesco si riferisce a un’esperienza estrema e indicibile, qui è applicato all’angoscia del lunedì mattina.
- Reminiscenze del Lager: La nota specifica del testo (“che l’ha scritta nel 1946, un anno dopo aver fatto esperienza di ‘nuovi Minosse’ che distinguevano i ‘sommersi dai salvati’, ma con altri criteri”) è fondamentale. L’esperienza di Auschwitz ha insegnato a Levi che la distinzione tra “sommersi e salvati” non si basava su criteri divini o morali, ma sull’arbitrio disumano dei carcerieri, sulla fortuna, sulla capacità di adattamento o sull’opportunismo. Il Minosse di Porta Nuova è una rielaborazione grottesca di quei “nuovi Minosse” del Lager, che decidevano della vita e della morte con criteri incomprensibili e crudeli, se non puramente arbitrari. L’Inferno del Lager era una realtà ben più concreta e spaventosa di qualsiasi inferno dantesco, e le sue leggi erano altrettanto assurde e inappellabili.
4. Quale significato, a tuo avviso, si può attribuire all'”angoscia dei lunedì mattina” che “intendere non può chi non la prova”?
L’espressione “angoscia dei lunedì mattina / Che intendere non può chi non la prova” (vv. 23-24) assume un significato che va oltre la semplice avversione per l’inizio della settimana lavorativa, elevandosi a simbolo di una condizione esistenziale di malessere profondo e universale, con echi della sofferenza patita nel Lager.
- Universalità del disagio quotidiano: A un primo livello, è un’espressione comune e comprensibile a chiunque debba tornare alla routine del lavoro dopo il riposo. L’angoscia è legata al peso degli obblighi, alla monotonia, alla perdita di libertà del fine settimana. È un disagio che accomuna la maggior parte della popolazione adulta.
- Incomunicabilità dell’esperienza: Il verso “Che intendere non può chi non la prova” sottolinea un senso di incomunicabilità e solitudine nel disagio. Questa è una cifra tipica di Levi, che in Se questo è un uomo e I sommersi e i salvati ribadisce l’indicibilità dell’esperienza del Lager, comprensibile solo a chi l’ha vissuta. Qui, la stessa formula è applicata a un’esperienza molto più comune, creando un effetto di abbassamento ironico, ma anche di sottolineatura di una sofferenza, per quanto “minore”, ugualmente autentica e personale.
- Eco della sofferenza più grande: Dato il contesto post-Lager in cui Levi scrive, l’angoscia del lunedì assume una risonanza più cupa. Se l’angoscia del Lager era una sofferenza estrema e indicibile, il fatto di applicare la stessa formula a un disagio quotidiano può voler dire che, per chi ha vissuto l’inferno, anche la normalità può celare un’angoscia, un senso di peso, una rievocazione (seppur lontana e per contrasto) di un’esperienza in cui la distinzione tra sommersi e salvati era questione di vita o di morte. Il “lunedì” della vita lavorativa può richiamare la ripresa di un ciclo di obblighi e limitazioni che, per chi ha conosciuto l’assoluta privazione di libertà, è comunque un peso.
In sintesi, l’angoscia del lunedì mattina è una metafora della malcelata infelicità della vita moderna, una sofferenza sottile che si rivela incomprensibile a chi non l’ha provata, e che, per Levi, può avere un’eco, per quanto lontana, delle incomprensibili selezioni e delle inappellabili condanne vissute nel Lager.
Interpretazione
“Un altro lunedì” di Primo Levi è molto più di un’istantanea della vita lavorativa post-bellica; è una profonda e sottile rielaborazione poetica dell’esperienza del Lager e della sua incidenza sulla percezione della realtà da parte del sopravvissuto. Scritta nel 1946, a solo un anno dalla sua liberazione da Auschwitz, la poesia rivela l’impossibilità per Levi di separare il presente dalla memoria dell’inferno, proiettando le dinamiche di selezione e giudizio del Lager sulle apparentemente banali divisioni della società civile.
Il cuore dell’interpretazione risiede nel confronto tra il Minosse dantesco e i “nuovi Minosse” del Lager, e la loro reincarnazione grottesca nei megafoni di Porta Nuova. In Dante, Minosse incarna la giustizia divina, seppur terrificante, che assegna la pena in base ai peccati. Nel Lager, come Levi ha testimoniato in Se questo è un uomo e I sommersi e i salvati, la “selezione” tra chi viveva e chi moriva era un atto arbitrario, disumano, spesso privo di logica o basato su criteri perversi (la condizione fisica, la “utilità” per i carnefici, la mera casualità). Non c’era un giudizio morale, ma una condanna a morte. Questo Minosse “orribilmente ringhia” non per la sua natura demoniaca, ma per l’assurdità e l’indifferenza con cui opera la sua selezione.
La lista dei “dannati” e degli “eletti” è una satira acuta dei valori borghesi e della società produttivistica. Chi è condannato all’Inferno sono spesso coloro che incarnano l’efficienza, la razionalità, il successo materiale, la burocrazia: figure che, nella prospettiva di Levi, potrebbero essere simbolo di una “normalità” che, nel suo conformismo e nella sua ossessione per la produttività, può celare un’aridità spirituale o una cecità morale. I “professori di matematica” e i “ragionieri” sembrano essere condannati per la loro fredda logica, i “finanzieri” e i “direttori di società” per la loro avidità, “chi si alza presto alla mattina / Senza averne necessità” per la sua falsa operosità.
Al contrario, i “salvati” sono le figure della marginalità, della spontaneità, dell’emozione, della fisicità, della creatività disinteressata: i pescatori, i soldati (forse per il loro contatto con il limite, con la vita e la morte), i bambini, gli innamorati, i saltimbanchi, gli inventori. Persino i “russi”, allora alleati e simbolo di una lotta che aveva rovesciato un regime, trovano posto in Paradiso. Questo rovesciamento dei valori è tipico dell’ironia di Levi, che spesso usa il paradosso per svelare l’assurdità del mondo. È un’affermazione del valore dell’autenticità umana, della sua fragilità e delle sue imperfezioni, contro la disumanizzazione dei sistemi e delle logiche produttive.
Il riferimento dantesco “Che intendere non può chi non la prova” è la chiave di volta che lega l’esperienza universale dell’angoscia del lunedì alla sofferenza indicibile del Lager. Levi, pur usando un tono apparentemente leggero e ironico, non può liberarsi del peso della sua memoria. L’angoscia del lunedì mattina, per quanto banale in confronto, diventa una metafora della persistente vulnerabilità umana di fronte a sistemi che selezionano e giudicano, e della solitudine di chi ha vissato un’esperienza estrema e ora si confronta con una “normalità” che sembra non comprendere il suo vero peso. Il luogo comune del disagio settimanale si carica di una risonanza esistenziale, quasi un lamento sotteso.
In altre opere di Levi, come La tregua, la difficoltà del ritorno alla vita normale dopo l’orrore del Lager è un tema ricorrente. L’uomo che ha visto l’abisso non può più guardare il mondo con gli stessi occhi; anche la routine più banale può celare un’inquietudine. La poesia “Un altro lunedì” è un piccolo ma potente esempio di come Levi, attraverso l’uso dell’ironia e la rielaborazione di modelli letterari (Dante), riesca a esprimere la sua profonda critica sociale e la sua incancellabile testimonianza di umanità ferita, anche nel contesto apparentemente anodino della vita quotidiana del dopoguerra. Il suo Minosse è un simbolo delle forze invisibili e spesso assurde che continuano a classificare e a giudicare l’esistenza umana, richiamando la fragilità della distinzione tra “sommersi” e “salvati” in un mondo che, pur fuori dal Lager, non è ancora del tutto liberato dall’arbitrio e dalla sofferenza.




